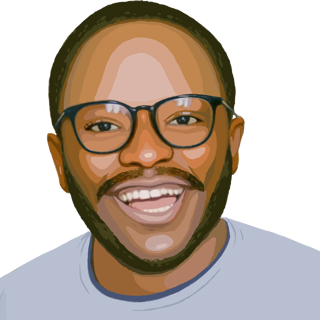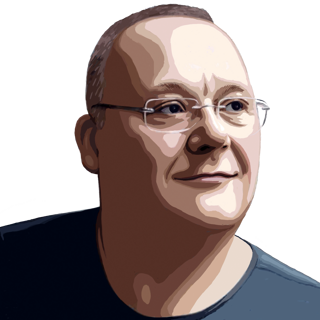In tutti i continenti una figura familiare è tornata nelle piazze. In Nepal giovani manifestanti hanno costretto il primo ministro a dimettersi dopo anni di corruzione. In Marocco il collettivo senza leader Gen Z 212 ha riempito le strade con slogan contro le spese folli dello stato e l’incuria quotidiana. In Madagascar, di fronte alla mancanza d’acqua e ai blackout, studenti e disoccupati hanno costretto il presidente a sciogliere il governo (il 12 ottobre il presidente ha lasciato il paese e due giorni dopo i militari hanno preso il potere). I mezzi d’informazione globali si sono affrettati a darci un bel titolone: la Generazione Z in rivolta.
Tuttavia, questa descrizione ripetuta dalla Cnn fino al New York Times è al tempo stesso vera e molto fuorviante. È vero che i manifestanti sono giovani, che i mezzi digitali (la piattaforma Discord, TikTok e i canali di Telegram) ne hanno accelerato il coordinamento. Ma chiamare queste rivolte “proteste della generazione Z” vuol dire confondere il mezzo con il messaggio. Vuol dire ridurre la politica a demografia. Così si perde il quadro della realtà più profonda: queste rivolte esprimono la ricomparsa di un soggetto politico globale da tempo rimasto ai margini, la gioventù come coscienza di un sistema mondiale in decadenza.
Il ripetersi delle rivolte giovanili non è un mistero. Nel capitalismo i giovani ereditano i costi delle crisi causate da altri
Le manifestazioni di quest’anno appartengono allo stesso filone delle primavere arabe e del movimento #FeesMustFall contro l’aumento delle tasse universitarie in Sudafrica, mobilitazioni di massa che non erano riuscite a cambiare il sistema che combattevano. Questi movimenti avevano messo a nudo i limiti della democrazia neoliberale, ma alla fine erano stati arginati.
La rivoluzione rimandata non è stata spenta, è stata dispersa. Gli eventi del 2025 sembrano indicare che l’energia di quel ciclo sta tornando, plasmata da condizioni economiche più difficili e senza le vecchie illusioni di riforma. Se gli anni dieci del duemila sono stati un decennio di rivolte senza rivoluzione, i tumulti di oggi sono una politica della necessità: non ancora rivoluzionaria, ma nata dalla consapevolezza che oggi anche la semplice sopravvivenza impone uno scontro con il sistema.
Il ripetersi delle rivolte giovanili non è un mistero. Nel capitalismo i giovani ereditano i costi delle crisi causate da altri, diventando adulti in economie che non hanno più bisogno del loro lavoro e in sistemi politici che non richiedono più il loro consenso. In Marocco più di un terzo delle persone sotto i 24 anni è disoccupato, mentre lo stato costruisce stadi per i Mondiali del 2030. In Nepal intere generazioni sono state esportate come manodopera migrante, tenendo in piedi un’economia delle rimesse che permette alle élite nazionali di rimandare qualsiasi riforma strutturale. In gran parte del sud globale il surplus permanente di giovani è diventato una costante della vita economica, una maggioranza demografica condannata alla ridondanza sociale.
Trattare questo fenomeno come un dramma generazionale (generazione Z contro anziani) significa depoliticizzarlo. La categoria della “gen Z” appartiene al lessico del marketing del tardo capitalismo, non a quello del cambiamento storico. Serve a dire che quello che unisce questi giovani è la cultura o la mentalità invece che le condizioni materiali. Ma la condizione che li accomuna non è psicologica, è strutturale. Le stesse economie trainate dal debito, gli stessi servizi sociali privatizzati e gli stessi programmi di austerità imposti dall’esterno che hanno definito l’era neoliberista oggi hanno raggiunto il loro limite politico. I giovani si trovano alla frontiera di questo sistema al capolinea, dove ogni promessa di sviluppo è sprofondata in una precarietà permanente.
Quando i mezzi d’informazione parlano di “ribellione della gen Z” in realtà intendono: non prendetela sul serio
La forma della protesta è cambiata, ma non la sua logica. In Marocco il canale Gen Z 212 su Discord ha raggiunto in pochi giorni i 130mila iscritti, un’infrastruttura digitale che riempie lo spazio vuoto un tempo occupato da partiti e sindacati. In Madagascar il network online Gen Z Mada si è coordinato con i sindacati per proclamare scioperi nazionali. In Nepal il movimento nato contro la messa al bando dei social media si è evoluto fino a diventare un rifiuto di massa di tutto l’ordine post-maoista, screditato da decenni di liberalizzazioni e di ricambio delle élite. Queste non sono solo ribellioni digitali: sono ricomposizioni di classe fatte attraverso strumenti digitali, esperimenti di organizzazione tra le rovine dei veicoli tradizionali della politica di massa.
Molti di questi movimenti, inoltre, adottano la stessa etichetta con cui i mezzi d’informazione li hanno battezzati. La Gen Z 212 in Marocco, la Gen Z Mada in Madagascar e la Gen Z Nepal hanno fatto propria questa definizione non perché s’identificano con una categoria del marketing globale, ma per dare un nome alla loro affinità generazionale dentro la crisi. Funziona da scorciatoia, da etichettatura autoironica nel linguaggio del mondo che li esclude. Anche il giornalismo si comporta in modo simile: tratta la generazione Z come un’attrazione da zoo, facendo congetture sulle sue abitudini: lo “sguardo spento”, l’avversione per il lavoro, la paura delle discoteche. Ma ignora l’ordine sociale che produce queste condizioni. Il contenuto ideologico delle proteste è ancora in formazione. Molti articolano la propria collera in termini morali: corruzione, dignità, tradimento. Ma sotto questo vocabolario c’è una consapevolezza strutturale del fatto che le élite nazionali agiscono da mediatrici di un sistema globale che ha smesso di mantenere le sue promesse. Come ha detto un manifestante a Nairobi, in Kenya, lo scorso anno: “Siamo governati dalle banche, non dal parlamento”. Da Antananarivo a Kathmandu l’accusa è la stessa: lo stato è stato svenduto; il futuro è ipotecato.
Questa coscienza non ha ancora un programma, ma è più radicale di quello che sembra. Rappresenta la percezione che le ingiustizie quotidiane sono legate all’architettura del capitalismo globale. Negli anni scorsi i manifestanti rivendicavano l’inclusione: essere riconosciuti, prendere parte allo sviluppo. La richiesta che anima le rivolte odierne è più essenziale: sopravvivere a un sistema che ha provocato il logoramento delle condizioni essenziali di vita.
Questo è anche il motivo per cui la Palestina è diventata un punto di riferimento. Il genocidio a Gaza e il coraggio di chi l’ha sfidato – dagli studenti alla Global sumud flotilla – hanno chiarito a una generazione che l’imperialismo non è un concetto astratto. Quello che lega le proteste a Nairobi, Kathmandu, Lima e Casablanca alle manifestazioni per la Palestina è il comune rifiuto di un mondo regolato dal saccheggio e dalla prepotenza.
La traiettoria dell’attivista svedese Greta Thunberg, 22 anni, coglie alla perfezione questa dinamica. Un tempo beniamina dell’ambientalismo – accolta a Davos, abbracciata da Obama e applaudita come una dimostrazione del fatto che la generazione Z s’impegna – Thunberg è stata celebrata perché la sua critica appariva morale e non sistemica. Ma appena ha collegato la giustizia climatica all’antimperialismo, si è schierata con i palestinesi e ha definito genocidio la guerra a Gaza, gli inviti sono finiti (e Thunberg è stata coerente su una serie di questioni, tra cui l’Ucraina, l’Armenia e il Sahara Occidentale). I politici occidentali che un tempo la applaudivano improvvisamente hanno scoperto i loro limiti di tolleranza. Ciò che è cambiato non è la sua età ma la sua visione politica. L’establishment può sopportare il dissenso giovanile solo quando compiace la sua autostima.
Quando i mezzi d’informazione definiscono questa ondata di proteste una “ribellione della generazione Z” ciò che intendono realmente è: non prendetela sul serio. L’etichetta addomestica ciò che dovrebbe essere minaccioso. Trasforma la lotta politica in una moda. Ma se guardiamo al di là di questa apparenza, quello che salta agli occhi è uno schema ricorrente che connette il presente a una storia più lunga di rivolte giovanili sotto il capitalismo, da Parigi nel 1968 a Soweto nel 1976. In ciascuno di questi casi i giovani non erano uno speciale gruppo d’interesse, ma lo strato sociale attraverso il quale la storia ha annunciato che il vecchio ordine era giunto alla sua fine.
Oggi quell’annuncio risuona di nuovo. Siamo di fronte non solo all’impazienza di una generazione, ma al riemergere di una contraddizione globale che nessun governo potrà gestire all’infinito. La rivoluzione rimandata è ricomparsa, senza illusioni e mediata dagli schermi, ma identica nella sostanza: la rivendicazione di un mondo che sia in grado di fare il bene delle persone e non del potere o del profitto. ◆ fdl
Questo articolo è uscito sul giornale online Africa is a Country.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1636 di Internazionale, a pagina 38. Compra questo numero | Abbonati