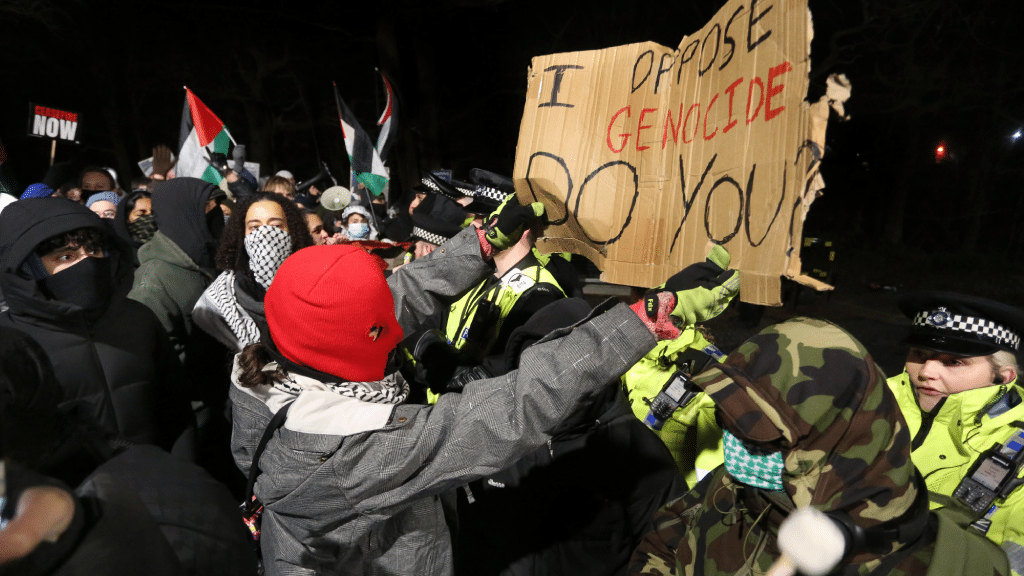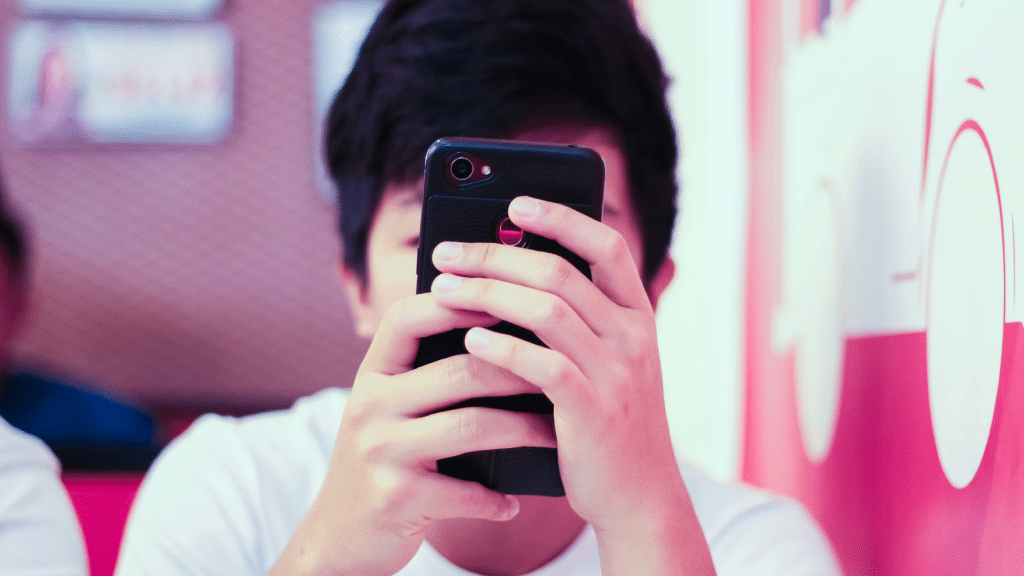Senza fare troppo rumore, in settimana si è avviato verso la pensione uno dei simboli più riconoscibili e duraturi degli Stati Uniti: il penny. La zecca di Filadelfia ha coniato le ultime monete da un centesimo, in circolazione da più di 230 anni, su cui è raffigurato, di profilo, il presidente Lincoln.
Una decisione arrivata dopo anni di discussioni e rinvii, e motivata soprattutto da ragioni economiche. Il centesimo, introdotto alla fine del settecento per garantire piccoli scambi quotidiani, era essenziale in un’economia in cui scarseggiavano monete di basso valore, ma con il passare dei decenni l’inflazione ne ha eroso il potere d’acquisto, fino a renderlo praticamente inutile nelle transazioni e molto svantaggioso dal punto di vista economico: produrre una moneta costa quasi quasi quattro centesimi.
Nonostante questo il penny è rimasto in circolazione, come oggetto più simbolico che funzionale, e come un esempio emblematico di quanto possa essere difficile disfarsi di politiche controproducenti o palesemente sbagliate.
La giornalista Caity Weaver ne ha parlato mesi fa in un articolo sul New York Times Magazine, riassumendo il problema nell’espressione “paradosso del penny perpetuo”.
Il paradosso sta nel fatto che gli esercenti devono avere dei penny in cassa per darli come resto alle persone che pagano in contanti, ma una volta uscite dal negozio quelle persone non usano le monetine, accumulandole invece in barattoli, cassetti e salvadanai. Di conseguenza il governo è costretto a coniare nuovi penny per sostituire quelli non più in circolazione, in una spirale produttiva senza fine. Si stima che oggi negli Stati Uniti ce ne siano 240 miliardi, quasi 700 per ogni americano. Smettendo di produrre queste monete, il governo dovrebbe risparmiare circa 56 milioni di dollari all’anno.
Due caramelle
Da tempo quasi tutti sono d’accordo sulla necessità di togliere dalla circolazione i penny. Appelli in questo senso sono arrivati negli anni da William E. Simon, segretario del tesoro durante l’amministrazione Nixon, da Paul Volcker, storico presidente della Federal reserve, e da vari ex direttori della zecca, alcuni dei quali hanno definito la situazione “ridicola”.
Nell’archivio dell’Atlantic ho trovato un articolo pubblicato nel 1933, in piena grande recessione, in cui una lettrice ricordava con nostalgia l’epoca in cui “un centesimo valeva qualcosa”. La donna rievocava i tempi della scuola, quando ricevere di nascosto una monetina significava poter comprare dei dolciumi. Nel 1933 già non era più così: il penny bastava appena per due caramelle incartate. Una testimonianza che anticipava l’inesorabile perdita di valore della monetina.
Se gli appelli sono sempre caduti nel vuoto è per una classica combinazione di inerzia politica e interessi industriali. La Artazn, l’azienda che rifornisce i dischi di zinco grezzo usati per produrre i penny, ha finanziato decine di campagne per evitare la riforma.
L’Artazn sostiene l’organizzazione Americans for common cents, guidata da un lobbista che promuove il penny come strumento utile ai più poveri e per le iniziative di beneficenza (in realtà gli studi dimostrano da tempo che le persone con redditi più bassi ricorrono ormai soprattutto a carte prepagate e app di pagamento, e anche le organizzazioni di beneficenza preferiscono donazioni con strumenti digitali).
Ora il passo è stato finalmente fatto, ma togliere dalla circolazione la moneta più prodotta della storia dell’umanità è più facile a dirsi che a farsi. Giorni fa Caity Weaver è tornata a occuparsi del problema, spiegando che il governo non sembra avere un piano per il “dopo penny”. Come esempio virtuoso cita il caso del Canada, che nel 2012, quando il costo di produzione dei penny canadesi raggiunse 1,6 centesimi a pezzo, annunciò che avrebbe cessato la produzione delle monete e le avrebbe gradualmente ritirate dalla circolazione.
Contemporaneamente, il governo lanciò un’estesa campagna di informazione pubblica, spiegando ai canadesi la logica alla base della sua decisione e pubblicando delle linee guida (comprese delle piccole immagini) su come arrotondare le transazioni in contanti in assenza di penny (facendo in modo che alla fine i consumatori non ci rimettessero troppo). “A oggi la zecca canadese ha riciclato più di 15mila tonnellate di penny restituiti dai canadesi, che in cambio hanno ricevuto esattamente il loro valore nominale. Il riciclaggio del metallo dei penny canadesi (principalmente rame e acciaio) ha contribuito a compensare il costo del trasporto su camion di miliardi di penny indesiderati in tutta la nazione. E ha evitato che le monete finissero in discarica”.
Il governo degli Stati Uniti non ha preparato un piano simile, anzi non ha nessun piano, spiega Weaver: “Le autorità non hanno fornito indicazioni su come dovrebbero funzionare le transazioni in contanti calcolate al centesimo”. Si prevede che la novità farà aumentare i costi per gli acquirenti. Uno studio condotto dai ricercatori della Federal reserve di Richmond ha stimato che i consumatori potrebbero rimetterci complessivamente sei milioni di dollari all’anno.
Un altro problema riguarda il riciclo. I penny statunitensi, anche se placcati in rame, sono realizzati principalmente in zinco. Lo zinco riciclato vale solo circa un quarto del rame riciclato (ogni anno negli Stati Uniti vengono riciclate quasi 1 milione di tonnellate di rame, contro solo circa 165mila tonnellate di zinco). Inoltre il rame e lo zinco sono molto difficili da separare.
Il penny comunque è arrivato al capolinea e in futuro potrebbe toccare la stessa sorte al nichelino, che ha un valore nominale di cinque centesimi ma costa quasi quattordici centesimi per essere prodotto.
Questo articolo è tratto dalla newsletter Americana.
|
Iscriviti a Americana |
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Americana
|
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it