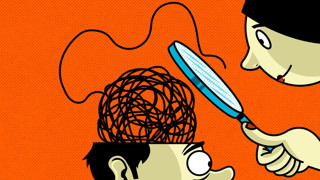È una vicenda che vi farà guardare la soia con altri occhi. Questo legume piuttosto comune e dall’elevato contenuto proteico è finito sorprendentemente al centro della rivalità sino-americana e delle tensioni geopolitiche della nostra epoca.
Di solito, in questo periodo dell’anno, i produttori di soia statunitensi cominciano il raccolto avendo già fatto il pieno di ordini. Il loro cliente principale è la Cina, che l’anno scorso ha comprato metà della produzione per un valore di 13 miliardi di dollari. Quest’anno invece dalla Cina neanche un ordine, neanche un dollaro. Una perdita economica catastrofica.
La spiegazione si riassume in due parole: guerra commerciale. Appena rientrato alla Casa Bianca, Donald Trump ha immediatamente scatenato una battaglia a colpi di dazi, colpendo in modo particolare la Cina. Pechino ha risposto fermando le esportazioni di terre rare (minerali di cui domina il mercato) e interrompendo le importazioni di soia americana.
La scelta della soia non è casuale. Lo stato americano in cima alla classifica della produzione è l’Iowa, feudo repubblicano dominato dai sostenitori di Donald Trump. A novembre, quando il presidente americano e il numero uno cinese Xi Jinping si incontreranno a Seoul, la soia sarà sicuramente uno dei temi sul tavolo.
Ma dove si rifornisce la Cina ora che ha voltato le spalle agli Stati Uniti? È qui che la vicenda si fa appassionante. Negli anni settanta un cattivo raccolto negli Stati Uniti (che all’epoca erano di gran lunga il primo produttore mondiale) ha spinto due grandi paesi agricoli dell’America Latina, il Brasile e l’Argentina, a concentrarsi sulla soia.
All’inizio del ventunesimo secolo, quando lo sviluppo della Cina ha accelerato, le abitudini alimentari dei cinesi sono cambiate, e a quel punto le importazioni di soia sono esplose moltiplicandosi per undici e raggiungendo il 60 per cento della produzione globale. Pechino ha diversificato gli acquisti fra i tre paesi delle Americhe per non dipendere da un solo produttore.
Le tensioni geopolitiche hanno fatto il resto, i compratori cinesi hanno ricevuto l’ordine di boicottare gli Stati Uniti e di acquistare tutta la soia possibile dal Brasile. Anche il paese guidato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che fa parte dei Brics come la Cina, è vittima di dazi imposti da Washington per motivi politici, legati al processo a carico dell’ex presidente Jair Bolsonaro, amico di Trump.
Fino all’Amazzonia
Questa vicenda, che si sviluppa a cavallo di tre continenti e gira intorno a un legume che serve soprattutto a nutrire il bestiame, non è solo lo specchio della globalizzazione degli ultimi decenni, ma anche una testimonianza di quale possa essere l’impatto di qualsiasi variazione nei rapporti geopolitici.
Nel libro Géopolitique du soja, appena pubblicato, l’esperto di questioni agricole Olivier Antoine scrive: “La soia è il simbolo di quanto le rivalità geopolitiche vadano al di là delle questioni diplomatiche o militari coinvolgendo anche le dinamiche alimentari e agricole”.
E in gioco non ci sono solo gli equilibri geopolitici. La fame di soia della Cina è infatti uno dei fattori che spingono a deforestare l’Amazzonia, per fare spazio ai terreni agricoli e permettere al Brasile di essere il primo produttore mondiale. L’Europa, dal canto suo, ha vietato l’importazione di soia proveniente da terreni strappati alle foreste. La tensione attuale non risolverà la situazione.
Gli statunitensi si stanno rendendo conto di aver sottovalutato la capacità di ritorsione e la determinazione della superpotenza cinese. Gli agricoltori dell’Iowa, quando hanno votato per Trump, non si aspettavano di perdere tutto.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it