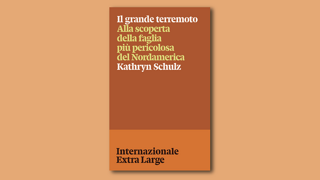Le immagini dei giovani che ripuliscono le strade di Kathmandu al termine di una settimana furiosa è un messaggio esplicito sulle intenzioni e la determinazione della generazione Z. Nel giro di una manciata di giorni, con scontri violenti in cui sono morte 51 persone, hanno cambiato le sorti del Nepal facendo cadere governo e parlamento. Dopo l’assalto e gli incendi alle sedi istituzionali e alle abitazioni degli esponenti politici dovrà seguire, quindi, una pars construens. In che direzione è ancora presto per dirlo, ma a giudicare dalla rapidità con cui i giovani – molti studenti universitari e laureati disoccupati – sono riusciti a organizzare le proteste contro l’élite, le aspettative sono alte.
In realtà il futuro del Nepal plasmato dagli under 30 potrebbe già essere cominciato. Venerdì ha giurato da prima ministra Sushila Karki, 76 anni, ex presidente della corte suprema, indicata dai manifestanti come la loro prescelta per portare il paese alle elezioni. Karki ha promesso che entro sei mesi se ne andrà e che nel frattempo ascolterà cos’ha da dire la generazione che ha cacciato l’establishment.
Difficile non vedere un legame, o almeno un’assonanza, tra gli eventi dei giorni scorsi in Nepal e quelli di fine agosto in Indonesia, dove migliaia di persone sono scese in piazza contro i privilegi della classe politica, la corruzione e il nepotismo. Sullo sfondo, un’economia che rallenta, l’inflazione e la disoccupazione giovanile che avanzano e la mancanza di opportunità per una parte consistente della popolazione (i giovani sono il 20 per cento del totale in Nepal e il 16 per cento in Indonesia).
Ma, allargando lo sguardo, i parallelismi arrivano fino a quel che è successo in Bangladesh l’anno scorso, dove le rivolte giovanili hanno messo in fuga la prima ministra Sheikh Hasina, o in Sri Lanka nel 2022, dove la rabbia popolare, soprattutto dei giovani, ha destituito un’intera dinastia politica, quella dei Rajapaksa, che governava il paese da vent’anni. Prima ancora c’erano state le manifestazioni in Birmania dopo il golpe militare del 2021, le proteste in Thailandia e quelle a Hong Kong contro la legge sulla sicurezza nazionale.
Le ultime tre rivolte sono fallite, non per la mancanza di determinazione o organizzazione dei manifestanti, ma perché la presa sul potere dei regimi autoritari contro cui si battevano era ancora troppo forte e quei governi erano pronti a usare la violenza a oltranza per reprimere le proteste.
Influenze reciproche
Le ragioni dietro alla nascita di ognuno di questi movimenti sono legate a questioni interne a ciascun paese, ma è indubbio che ci siano alcuni fattori comuni, a cominciare dalla bassa età media della popolazione e dal malcontento per la mancanza di prospettive per arrivare all’alto tasso di corruzione e al ruolo dei social media nella vita di giovani e giovanissimi e nell’attività politica dal basso.
Ma quanto si influenzano tra loro questi fenomeni? “Stiamo assistendo all’emergere di movimenti giovanili in diverse parti dell’Asia in una successione piuttosto ravvicinata e in modi che suggeriscono che gli eventi in una parte della regione stiano fornendo una sorta d’ispirazione per quelli di un’altra”, dice Jeff Wasserstrom, storico della Cina all’Università della California Irvine, negli Stati Uniti, e autore di The milk tea alliance: inside Asia’s struggle against autocracy and Beijing (Columbia Global Reports 2025).
“Non li ispirano direttamente”, continua Wasserstrom, “ma danno a chi vive in un luogo la sensazione che certe azioni in grado di portare a un cambiamento siano possibili. Era già successo in passato. Per il mio libro ho intervistato un partecipante alla rivolta birmana del 1988 e le ho chiesto cosa passava per la testa ai giovani nei tea shop che all’epoca discutevano di agire contro la giunta. Mi ha risposto senza esitare che la consapevolezza di ciò che era accaduto nelle Filippine non molto tempo prima aveva contribuito a plasmare la loro immaginazione su ciò che poteva accadere”.
“È stato un esempio”, dice ancora lo storico, “di come le persone in contesti diversi si osservavano reciprocamente e si vedevano in situazioni parallele senza avere lo stesso sistema politico, e senza neanche vivere nella stessa regione specifica; credo che la semplice prossimità possa essere importante nel dare alle persone un senso di ciò che è possibile. E mi colpisce quanto questo continui a contare anche in un’epoca in cui gran parte delle notizie, delle immagini delle lotte e dei simboli circolano tramite i social media, rendendo possibile a chiunque sapere cosa accade ovunque. Eppure sembra che a volte le persone siano particolarmente influenzate dai simboli e dalle strategie usate in luoghi vicini a loro, con cui in qualche modo sembrano avere qualcosa in comune”.
Siamo di fronte a un’“onda asiatica” movimentista? “Ho sempre provato disagio verso l’idea di pensare l’Asia come un tutt’uno o di parlare di ‘valori asiatici’. Resisto anche all’idea di uno ‘stile asiatico’ di attivismo giovanile, ma per alcuni ragazzi coinvolti in queste lotte è una categoria, per quanto sfuggente, che può avere un significato. In un’intervista del 2020 una giovane attivista tailandese disse di sperare che le proteste nel suo paese avessero contribuito a dissipare l’idea che i giovani asiatici fossero conformisti e disinteressati alla politica. È un esempio di qualcuno influenzato da quella nozione di valori asiatici, che però vi si opponeva”.
Questo testo è tratto dalla newsletter In Asia.
|
Iscriviti a In Asia |
Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a In Asia
|
|
Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it