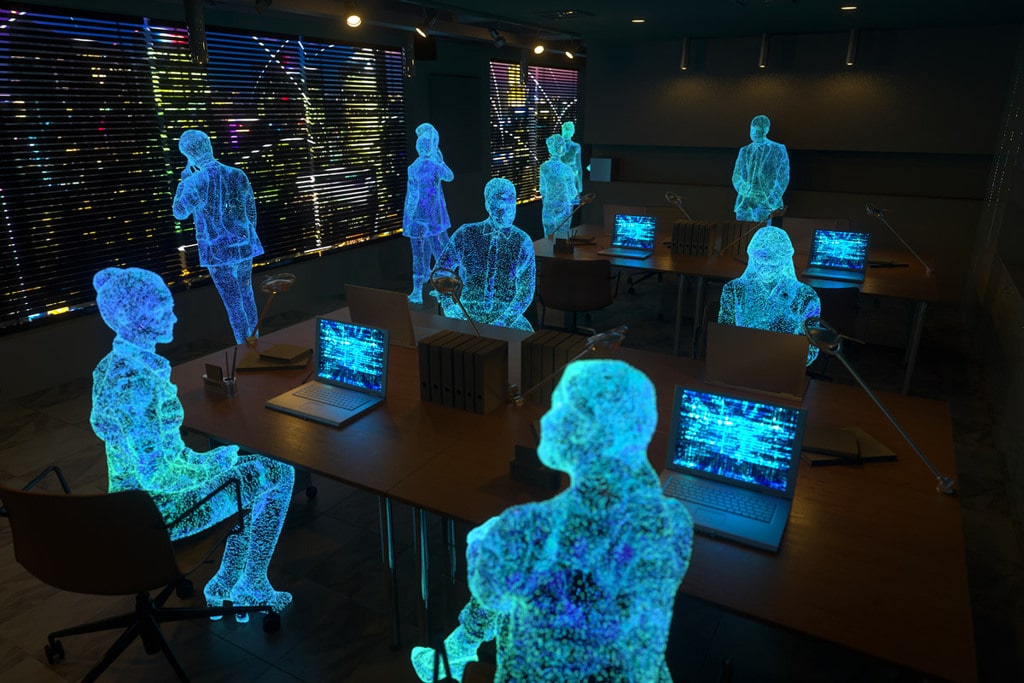Da quando cominciai a pensare a un mio futuro ingresso nel mondo del lavoro, quindi da quando misi piede per la prima volta in un’università, all’inizio degli anni novanta, ho sempre sentito dire che studiare informatica e in generale una disciplina scientifica voleva dire trovare facilmente un impiego ben retribuito e sicuro. Probabilmente le cose sono andate così in tutti questi anni, ma forse oggi questa certezza comincia a scricchiolare, paradossalmente proprio grazie ai progressi della tecnologia e in particolare alle innovazioni catalogate sotto l’etichetta di intelligenza artificiale.
Lo spunto per questa riflessione mi è stato dato da uno studio pubblicato in Svizzera e ripreso dal domenicale del quotidiano Neue Zürcher Zeitung. Si tratta di un’indagine del centro di ricerca Kof dell’Eidgenössische technische Hochschule (Eth), il politecnico federale di Zurigo.
Nel settore informatico svizzero, si legge nel rapporto, cresce la disoccupazione: mentre nel settembre del 2022 c’erano circa 1.700 persone senza lavoro, oggi sono più del doppio, intorno a quattromila. E se si contano anche le persone che hanno deciso di frequentare corsi d’aggiornamento o addirittura di cambiare mestiere si arriva a 5.500. Contemporaneamente diminuiscono le offerte di lavoro delle aziende informatiche e di altre imprese che hanno bisogno di specialisti del settore.
Sembrano tramontati definitivamente i tempi della pandemia di covid-19, quando ci fu un vero e proprio boom delle assunzioni, perché tutte le aziende puntavano decisamente sulla digitalizzazione delle loro attività. Alcuni osservatori parlano di una fisiologica correzione verso il basso, altri del fatto che sempre più persone studiano informatica e arrivano sul mercato: negli ultimi dieci anni il numero degli studenti di informatica del politecnico di Zurigo è raddoppiato.
Secondo i ricercatori del Kof, però, una delle cause principali è l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa, tecnologia che ha cominciato a essere conosciuta e apprezzata nel mondo grazie al lancio di ChatGpt della OpenAi, nel novembre del 2022. Gli strumenti più avanzati d’intelligenza artificiale, ricordano Jeremias Klaeui e Michael Siegenthaler, gli studiosi che hanno guidato la ricerca del Kof, non servono solo a scrivere dei testi o delle email, ma permettono anche di scrivere e migliorare codici informatici, valutare o preparare dei dati.
È per questo che oggi programmatori, sviluppatori di siti web e amministratori di banche dati rientrano a pieno titolo tra le figure professionali che possono essere sostituite da un algoritmo, in grado di fare molte delle loro mansioni in tempi più brevi. Siegenthaler fa un esempio: “Grazie all’intelligenza artificiale generativa un semplice sito web può essere realizzato in mezza giornata di lavoro; un paio d’anni fa serviva una settimana”.
Il fenomeno non riguarda solo il settore informatico. L’intelligenza artificiale generativa comincia a far sentire i suoi effetti un po’ dappertutto. Le liste di Amazon sono ormai pieni di descrizioni di prodotti generate da un qualche algoritmo. Ed è di questi giorni la notizia che il colosso del commercio online fondato da Jeff Bezos ha intenzione di licenziare 14mila dipendenti: la decisione arriva dopo che a giugno l’amministratore delegato Andy Jesse aveva dichiarato che il maggiore impiego degli strumenti d’intelligenza artificiale avrebbe portato a tagli del personale, soprattutto dei dipendenti che svolgono mansioni ripetitive.
Adattarsi
L’Economist, tuttavia, fa notare che gli algoritmi possono aiutare anche i consumatori e fa l’esempio del settore delle auto usate, dove le nuove tecnologie permettono a un potenziale acquirente di raccogliere in pochi secondi enormi quantità di informazioni su un veicolo in vendita e capire un po’ meglio quali siano le sue condizioni reali. È la fine della cosiddetta economia del rip off, dello spennare, cioè di quelle attività in cui le aziende sfruttano l’asimmetria informativa rispetto ai clienti per “spennarli” e trarne il profitto più alto possibile.
Il settimanale britannico stima che all’inizio del nuovo millennio il 30 per cento dei consumi degli statunitensi riguardava beni e servizi caratterizzati da gravi asimmetrie informative, mentre oggi la quota è scesa al 25 per cento. Il merito è di servizi innovativi basati sull’intelligenza artificiale: come quelli della startup CarEdge, che propone un algoritmo in grado di fare da intermediario nelle trattative con un rivenditore di auto.
La rivoluzione promessa dall’intelligenza artificiale è una cattiva notizia per chi lavora? No. O, quanto meno, non sarà così per chi riuscirà ad adattarsi al nuovo e alle opportunità che inevitabilmente offrirà, o per chi sarà aiutato a farlo. I ricercatori del Kof di Zurigo sottolineano che chi entra nel mondo del lavoro dovrà acquisire nuove conoscenze e soprattutto avere le competenze sociali necessarie per capire come applicarle alla realtà che ha davanti.
In un interessante saggio scritto per il New York Times Magazine, Robert Capps, ex direttore della rivista Wired, conferma che già oggi l’intelligenza artificiale è capace di svolgere molte mansioni affidate agli esseri umani, ma gli studi parlano anche del fatto che creerà nuovi posti di lavoro e soprattutto attività che prima non esistevano.
Nel mondo reale, sottolinea Capps, il lavoro non può essere ridotto a quello che fa un algoritmo: “I nostri lavori sono molto di più di una somma di mansioni; sono il contributo a un gruppo di altri esseri umani, i nostri capi e i nostri colleghi, che possono capirci, interagire con noi e fare riferimento a noi in modi che non è possibile replicare con un algoritmo”.
Per sfruttare le nuove opportunità, sarà necessario “cominciare a capire dove i nuovi lavori possono collegare le straordinarie capacità dell’intelligenza artificiale con i nostri bisogni e desideri. Il problema non è solo dove gli esseri umani vogliono l’intelligenza artificiale, ma dove l’intelligenza artificiale ha bisogno degli esseri umani”. Sicuramente, conclude Capps, ci sarà bisogno di esseri umani che controllino cosa fa un algoritmo e se ne assumano la responsabilità e di persone che sappiano come sfruttarlo al meglio in un ambiente lavorativo.
Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.
|
Iscriviti a Economica |
La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Economica
|
|
La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it