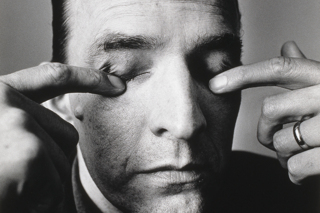Di fronte all’irruenza del presidente statunitense Donald Trump, l’Europa e le altre aree del mondo devono ripensare radicalmente le loro dottrine commerciali. Se Bruxelles non abbandonerà la sua religione basata sul libero scambio, correrà il rischio di vivere un disastro industriale e sociale senza precedenti, il tutto senza ottenere alcun beneficio per il pianeta.
Per stabilire l’ammontare dei suoi dazi doganali, Donald Trump ha seguito una logica rigorosamente nazionalista (basata unicamente sulla bilancia commerciale degli Stati Uniti) e caotica, visto che cambiava in base ai suoi sbalzi d’umore. In realtà bisognerebbe fare il contrario, i dazi dovrebbero essere decisi sulla base di princìpi condivisi.
Se l’Europa non abbandonerà la sua religione basata sul libero scambio, correrà il rischio di vivere un disastro industriale e sociale, il tutto senza ottenere benefici per l’ambiente
Il primo motivo sta nel fatto che il trasporto internazionale delle merci provoca emissioni di Co2 che ammontano al 7 per cento del totale globale. Per molto tempo gli economisti ne hanno minimizzato l’impatto sull’ambiente, assegnando un valore basso per tonnellata di anidride carbonica (tra i cento e i duecento euro). Tuttavia l’aumento del riscaldamento climatico ha reso indispensabile un cambio di rotta. Secondo le stime attuali i costi provocati dalle emissioni – catastrofi naturali, calo dell’attività economica e non solo – si avvicinano ai mille euro per tonnellata di Co2, e questo al netto dei costi non economici. Per tenere quindi in considerazione il riscaldamento climatico legato al trasporto delle merci bisognerebbe applicare ai flussi commerciali mondiali dei dazi doganali attorno al 15 per cento, con variazioni in base ai singoli casi.
Il secondo motivo per imporre i dazi è il dumping sociale, che si verifica quando le aziende spostano le attività produttive in un paese che ha una legislazione meno stringente in tema di sicurezza sul lavoro, protezione sociale e salario giornaliero. Chi ha sede in quei paesi ottiene quindi un notevole vantaggio concorrenziale.
Oggi la Cina è responsabile del 30 per cento delle emissioni mondiali, di cui circa il 20 per cento (ovvero il 6 per cento di quelle globali) è riferito alle esportazioni. Assegnando alla tonnellata di Co2 un valore di mille euro, per tenere conto del costo ambientale bisognerebbe applicare dazi doganali dell’80 per cento alle esportazioni di Pechino.
Passiamo al dumping sociale. I salari rappresentano il 49 per cento del pil cinese, contro il 64 per cento di quello europeo. Questo divario altera la concorrenza e andrebbe affrontato con dazi compensatori attorno al 15 per cento. Possiamo fare un calcolo simile per quanto riguarda il dumping fiscale, in particolare rispetto alle tasse sulle aziende e agli aiuti di stato.
Esattamente come per la Co2, l’obiettivo non è penalizzare la Cina, ma costringerla a pagare salari migliori, e in questo il dazio compensatorio sarebbe abolito. Pechino non ha bisogno di accumulare eccedenze commerciali all’infinito: prima di tutto il gigante asiatico deve portare avanti la sua decarbonizzazione (già più avanzata rispetto a quella statunitense), incrementare i salari e rafforzare la domanda interna. Allo stesso tempo, se gli Stati Uniti non cambieranno la loro strategia, l’Europa e la Cina dovranno imporre a Washington sanzioni sostanziose.
In ogni caso le tariffe doganali non sono indispensabili. Anzi, è possibile farne a meno concludendo accordi vincolanti per allineare gli obiettivi. Inoltre i dazi possono essere sostituiti dalle sanzioni finanziarie mirate, che in alcuni casi sono più efficaci. Le cifre esatte devono essere stabilite nell’ambito di una discussione democratica approfondita, nella più totale trasparenza e nel quadro di assemblee transnazionali.
Di certo parliamo di somme potenzialmente molto elevate, con dazi oscillanti tra il 50 e il 100 per cento.
Ci sono due fattori che potrebbero spingere l’Europa a cambiare orientamento: da un lato le pressioni sociali e politiche legate alla perdita massiccia dei posti di lavoro nel settore industriale; dall’altro la necessità urgente di generare introiti fiscali per rimborsare il debito europeo del 2020 e finanziare nuove spese. I dazi potrebbero risolvere questi problemi.
Per uscire dall’impasse potrebbe esserci bisogno anche di azioni unilaterali, con alcuni paesi pronti ad adottare misure nazionali per proteggersi dal dumping sociale e ambientale. A giudicare dal caso statunitense, non è escluso che una simile iniziativa possa venire dai nazionalisti e dalla destra. Se così fosse sarebbe un peccato, perché le logiche di esclusione adottate da queste forze politiche non possono risolvere i problemi sociali né cancellare la sensazione d’impotenza di cui le destre approfittano per conquistare il potere. È arrivato il momento che la sinistra europea e mondiale s’impadronisca del tema del commercio sostenibile e metta a punto un ambizioso programma d’interventi. ◆ as
Questo articolo è uscito sul quotidiano francese Le Monde.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1637 di Internazionale, a pagina 42. Compra questo numero | Abbonati