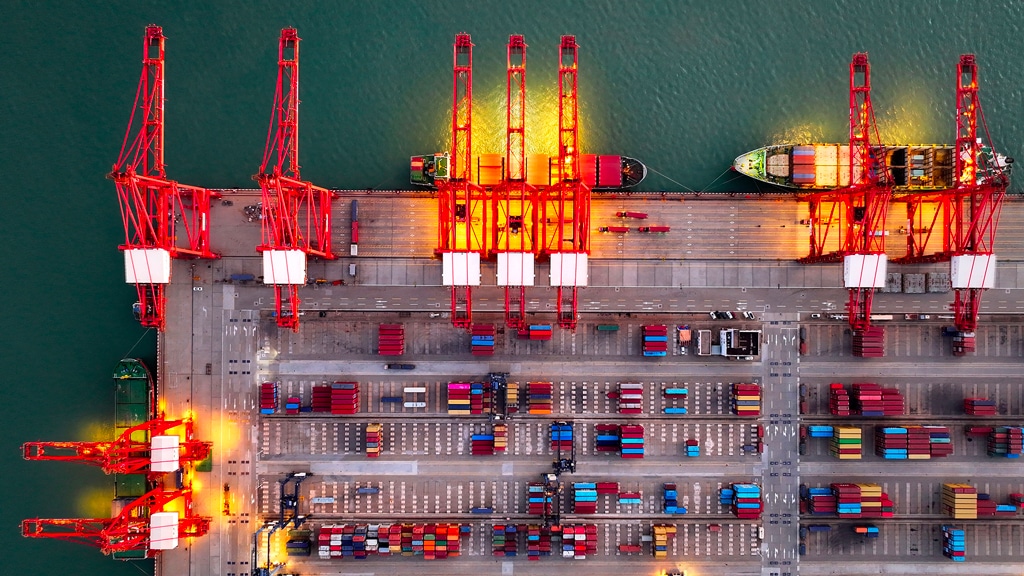In un altro contesto nessuno presterebbe troppa attenzione a un leader di estrema destra che promette l’inferno ai suoi nemici. Ma quando Bezalel Smotrich, ministro delle finanze di Israele, dichiara che la Striscia di Gaza sarà “totalmente distrutta” e la sua popolazione trasferita in altri paesi, non fa altro che comunicare brutalmente quello che si appresta a fare il suo governo.
In realtà, anche il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato piuttosto diretto, garantendo che le forze israeliane sul punto di tornare a Gaza “non interverranno per poi ritirarsi”. Siamo dunque alla vigilia di una nuova occupazione del territorio palestinese, accompagnata dal trasferimento della popolazione verso sud, in attesa dell’inizio di partenze definite “volontarie”.
Nei diciannove mesi di questa guerra, scoppiata in seguito all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, la realtà non era mai stata illustrata in modo così chiaro. Probabilmente è un effetto della presenza di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha disinibito i più estremisti, in Israele come altrove. La protezione del presidente statunitense vale come una garanzia di immunità.
Davanti a questo incubo annunciato, le reazioni internazionali sono timorose, come se il resto del mondo avesse preso atto della propria impotenza.
Questa impotenza è allo stesso tempo reale e presunta. È reale perché nei fatti solo gli Stati Uniti potrebbero influenzare sia Israele sia gli stati arabi. La prossima settimana Trump visiterà i paesi del Golfo, e Israele ha già annunciato che la sua offensiva comincerà solo dopo la partenza del presidente dalla regione.
Ma questa impotenza è anche presunta, perché i legami tra Israele e gli occidentali affondano le proprie radici nella storia e in rapporti politici e umani profondi. Questo rende difficile una rottura. L’Europa, intanto, è scossa da contraddizioni che la rendono ininfluente anche quando si esprime.
Il fatto che il mondo sia ormai governato dai rapporti di forza anziché dal rispetto della legge fa il gioco di Israele, che si impone in tutta la regione, dalla Palestina alla Siria, passando per lo Yemen.
Una novità è che la Francia sta cercando di fare, pur modestamente, da contrappeso. Il 7 maggio arriverà a Parigi il presidente siriano Ahmed al Sharaa: un evento che fa parte di questa strategia. Ex jihadista, al Sharaa è alla guida di una transizione fragile in un paese stremato e pronto a esplodere. La visita a Parigi sarà il suo primo viaggio fuori dal Medio Oriente, mentre la minoranza drusa subisce attacchi sanguinari da parte dei radicali sunniti e Israele interviene nel paese sostenendo di volerli difendere.
Ricevendo Al Sharaa a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron vuole credere che la transizione siriana possa riuscire a proteggere le minoranze minacciate. Macron ha inviato un messaggio a Netanyahu per chiedergli di non destabilizzare ulteriormente la situazione in Siria.
La Francia ha anche annunciato recentemente che il mese prossimo potrebbe riconoscere lo stato di Palestina, e ha sostenuto il piano arabo per Gaza, destinato a bloccare le mire di Trump sul territorio.
Queste iniziative stanno dando nuova vita alla politica araba della Francia, che sembrava morta dai tempi di De Gaulle, Mitterrand e Chirac, e che invece sembra essere resuscitata a causa della radicalizzazione in Israele e della brutalità dell’amministrazione Trump. Questa svolta, però, avrà un senso solo se riuscirà a coinvolgere l’Europa, e non sarà affatto facile. Il rischio, altrimenti, è quello di rafforzare il sentimento di impotenza davanti ai drammi della regione. Buoni sentimenti, ma senza un grande impatto.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it