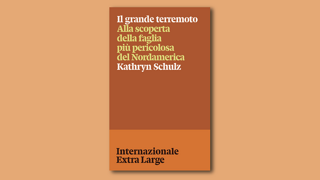Per motivare la scelta di aver assegnato a Nella carne di David Szalay il Booker prize, uno dei più importanti premi letterari al mondo, i giurati hanno detto di averlo fatto perché non avevano “letto niente di simile”. Niente di simile: niente di vero. Sembra più un’esagerazione per attirare l’attenzione su quell’oggetto di modernariato che sono i libri, oggi piuttosto trascurati. Tuttavia, cercare di avvicinare così lettori e lettrici a Nella carne non rende giustizia a un romanzo che è pieno di pagine notevoli, ma anche di alcuni limiti.
Al suo sesto libro, Szalay, 51 anni, origini ungheresi, continua la sua indagine su cosa significhi essere uomini. In Nella carne lo fa attraverso István. Le prime cinque righe del romanzo ne fanno un ritratto che non cambierà molto lungo il corso del libro, e aiutano a capire di che grana è fatto lo stile di Szalay, minimale e affilato: “A quindici anni si trasferisce con sua madre in una nuova città e ricomincia in una nuova scuola. Non è un’età facile per cose del genere – l’ordine sociale scolastico è già consolidato e lui ha qualche difficoltà a farsi degli amici”. István rimarrà inadeguato e fuori posto anche da adulto, agirà poco e molto sarà agito.
Szalay non lo descrive mai, ma lascia intuire che fin da adolescente ha un corpo che attrae. La sua prima esperienza è con la vicina di casa, una donna di quarant’anni, mentre lui ne ha quindici. Si vedono di nascosto, fanno sesso, István s’innamora, ma la vicina lo mette subito alla porta. Il rifiuto dà vita a una tragedia e la tragedia fa finire István in un carcere minorile. È uno snodo narrativo che determinerà la sua vita, e quindi il resto del libro. Un passaggio che si direbbe cruciale, un luogo narrativamente interessante da raccontare, ma Szalay evita del tutto di portarci chi legge.
È una delle prime e più importanti sottrazioni che opera in questo romanzo pieno di vuoti, tutto giocato sul togliere. Un’altra è la guerra in Iraq, che István combatte dopo essersi arruolato volontariamente, spinto da una nuova delusione sentimentale. E un’altra ancora arriva verso la fine, quando István si è lasciato alle spalle l’Ungheria e la miseria, ed è riuscito a mettere le mani su una fortuna miliardaria che però, essendo lui un personaggio a metà tra il biblico Giobbe e il kubrickiano Barry Lyndon, non può che annunciare un’altra tragedia.
Ellissi e riempitivi
Queste e altre ellissi sono uno dei motivi che hanno valso il Booker al romanzo. La scelta di non raccontare certe scene, di creare dei buchi da far riempire a chi legge, ha però una lunga storia. Se ne possono trovare degli esempi eccellenti in Pedro Páramo di Juan Rulfo e Sula di Toni Morrison. E più di recente nei racconti di Lydia Davis e Raymond Carver.
Tuttavia, mentre in questi autori l’ellissi crea tensione, ambiguità e spaesamento, in Szalay a volte dà l’impressione di essere uno strumento più didascalico e calcolato, ai limiti del manierismo. Qualcosa che fa “sempre sentire le ruote dell’ingranaggio che girano”, per dirla con lo scrittore tedesco Winfried Sebald.
Inoltre, i vuoti lasciati da Szalay sono spesso riempiti da traumi: il riempitivo più diffuso in quest’epoca letteraria caratterizzata da trame e personaggi che in molti casi ruotano intorno a ferite psicologiche. Dopo l’Iraq István soffre di stress post-traumatico, in diverse occasioni va in terapia, verso la fine beve parecchio e fa i conti con qualcosa di simile a una depressione.
Il manierismo si riaffaccia nei dialoghi. L’effetto cercato da Szalay è quello di un’aderenza al parlato, come in questo scambio tra István e Mervyn, il titolare dell’agenzia di guardie del corpo che gli offre un posto di lavoro a Londra e che gli dice come comportarsi con i clienti.
Quando parli, cerca di non gesticolare.
D’accordo.
Devi stare fermo.
Okay.
Tieni le mani appoggiate di fianco al piatto.
Okay.
Hai da accendere?, chiede.
Ovvio.
Sì, dice Mervyn.
Sì, dice István.
“Okay” è una parola che ricorre 184 volte nel romanzo: nella maggior parte dei casi a pronunciarla è István. Tuttavia, anche se incline al silenzio, e anche se Szalay non fa trasparire molto dei pensieri del suo protagonista, sarebbe sbagliato credere – e scrivere, come Dwight Garner sul New York Times – che István sia un guscio vuoto e che “non c’è nessuno per cui fare il tifo moralmente” in Nella carne. In più di un’occasione, quando István è chiamato a scegliere se salvare o lasciare morire qualcuno, sceglie di salvarlo, anche se questo causerà la sua rovina.
Perfino il suo rapporto con le donne ha più sfumature di quanto ci si potrebbe aspettare da un uomo che incarna “una forma di mascolinità primitiva”, come lo descrive il figlio di Helen, la donna sposata e ricchissima di cui diventa prima amante e poi marito. In un’epoca in cui diversi scrittori si sono irrigiditi di fronte al moltiplicarsi di voci femminili nella letteratura e nell’arte, Szalay è invece tra gli autori che non rinunciano a mettere in discussione l’idea classica di mascolinità, raccontandone i lati tossici e ambigui, le fragilità e le violenze. Forse è quello che resta di più di Nella carne. Non l’abilità tecnica, non il minimalismo glaciale, ma un personaggio che ridotto a carne e ossa dimostra di avere anche un’anima, o come la si vuole chiamare: qualcosa che gli si agita dentro, spesso in bilico tra l’ombra e la luce.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it