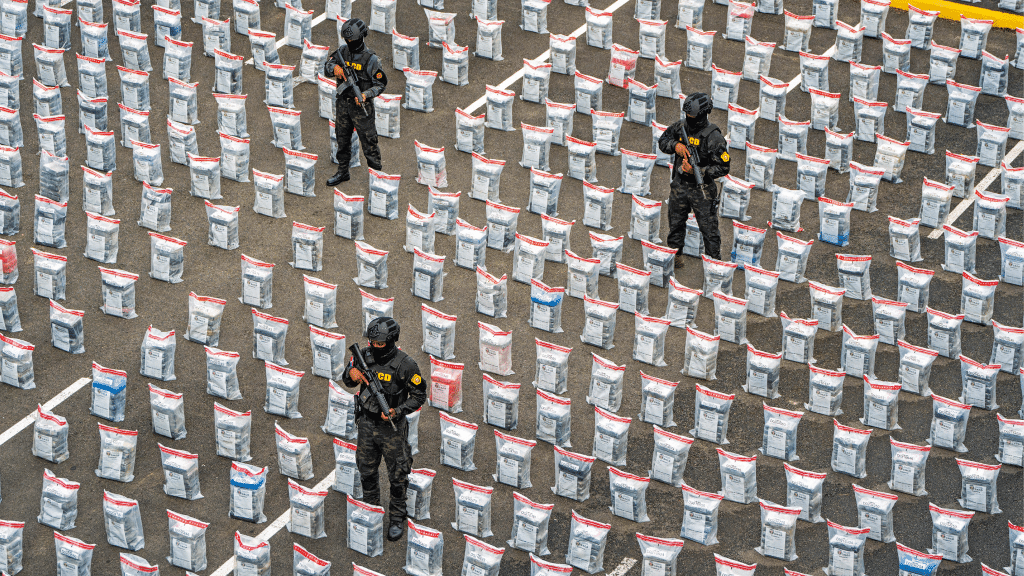Dopo la presentazione in concorso all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arriva nelle sale Duse di Pietro Marcello, biopic solo apparente. In realtà è un’opera profondamente ispirata sulla vita e la figura di una delle più grandi interpreti del teatro internazionale, Eleonora Duse, quasi una leggenda.
Più esattamente è un’opera libera come lo era l’attrice, sempre inquieta e sempre in viaggio. Un’icona e insieme una fenice, imprendibile, indefinibile eppure perfettamente incarnata da una grandiosa Valeria Bruni Tedeschi, che restituisce una personalità unica, incerta e appassionata, contraddittoria e lineare. E, con lei, è allo specchio un’epoca che sta ancora uscendo da un cataclisma globale, la prima guerra mondiale, e già sta preparando due cataclismi, se non tre, che si saldano in uno soltanto: l’avvento del fascismo e la seconda guerra mondiale, con annesso l’Olocausto.
Il film si svolge infatti “tra il 1917 e il 1923, un periodo di sconvolgimento sociale per l’Italia, che ha coinciso con l’ultima tournée della Duse prima della partenza per gli Stati Uniti, dove morì nel 1924, a Pittsburgh”. Il film coglie l’attrice nel suo finire che in verità è qui un nuovo inizio, e per questo inizia con due finali e poi con una sorta di resurrezione.
Ne nasce un capolavoro quasi assoluto, un film da vedere e rivedere più volte e che a ogni visione acquista più senso, bellezza e soprattutto forza incantatrice poiché si muove dall’inizio alla fine su un delicato, sottilissimo crinale. Anzi, in tutto e per tutto Duse è sul crinale.
Duse racconta cose dure o crudeli con grande dolcezza, una costante nel cinema di Pietro Marcello. Un cinema come sempre piacevolmente ondulatorio come una ninna nanna incantatrice, ma pervaso dai movimenti sussultori della Storia del novecento, che forgiano e più spesso deformano, devastano, come i peggiori terremoti, le tante storie umane degli umili, degli esseri umani qualsiasi. La loro potenziale felicità. Qui più che mai.
Come ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera, “la reinvenzione scenica del passato e dei suoi protagonisti (Duse, Mussolini, D’Annunzio) si specchia nell’utilizzo di autentici materiali d’archivio – cosa abituale nel regista – qui sfruttati in modo straordinario, con il lungo viaggio della salma del milite ignoto che attraversa l’Italia dalle Alpi al Vittoriale”.
Sovvertire i canoni
Questo l’altro vero protagonista del film: l’umile, il giovane mandato al macello, che torna mutilato, sfigurato o che non torna più. Il milite ignoto, che domina il Vittoriano di Roma, nasce in questo momento storico e in un certo senso nasce in questo film, poiché la storia qui narrata è fatta letteralmente con il tessuto della Storia, italiana in particolare ma non solo. Lo vediamo apparire lentamente ma in maniera continuata fino a quando nella parte finale si palesa: eppure è lui il fantasma che il film intende rendere visibile, che desidera incarnare senza esibirlo, senza didascalismo. E tuttavia quando giunge al Vittoriano pare quasi una rivelazione.
È un film nel film che conferisce all’opera, e in un certo senso a quella della Duse, tutto il suo senso profondo. Piccolissimo film nel grande film, è metafora di tutti noi che se andassimo in guerra non saremmo altro che piccoli insetti presi nell’ingranaggio della grande storia, delle sue manipolazioni continue, delle sue retoriche eterne.
È lui, l’anonimo soldato triturato dalla prima grande carneficina mondiale che in questa interpretazione cinematografica della Duse – finalmente il cinema non documentario se ne interessa – scatena in lei il progressivo desiderio di sovvertire i canoni obsoleti della sua arte, il teatro. Per lei, sia chiaro, arte somma, per restare nel linguaggio del film. Prima lento – facendo spettacoli ai soldati reduci dal fronte come vediamo all’inizio – ma che via via si fa sempre più forte, inarrestabile. L’agente scatenante di tutto è il soldato rimasto invisibile, ignoto appunto. E che tale resterà per sempre.
Il film così facendo ci parla dell’oggi, in maniera prepotente. La guerra come cosa normale e come retorica normale benché falsa e abusata. La guerra perpetua e infinita perché fa comodo a tutti, o anche la guerra come stato d’ansia continuo, come (pseudo)moto perpetuo della civiltà umana, proprio come la crisi continua. Proprio quando con Donald Trump il turbocapitalismo, già dissennato, sembra farsi superturbocapitalismo, senza nemmeno più qualche residuo di mediazione democratica (e razionale).
Torna allora in mente il brevissimo ma folgorante apologo scritto nel 1946 da Ennio Flaiano, La guerra spiegata ai poveri. Pensato per il teatro, è un dialogo volto a ingannare il Giovane che non capisce la guerra ma che alla fine, faticosamente convinto, ci andrà. Giocato tutto con toni oscillanti tra il surreale e l’assurdo, il Presidente, il Generale, il Perito religioso, la Signora, l’Usciere, il Ministro della superproduzione, Ninì, l’amichetta del Presidente, conversando rivelano secoli di retropensiero e strategia del potere, semplici, ma eterni e basilari, come questo, espresso dal Presidente: “Il dado è tratto. Dichiarata questa guerra, non abbiamo adesso che uno scopo: vincerla o, perlomeno, continuarla”.
Tra cinema e teatro
Duse è un film che dà nuova consistenza al cinema del passato, che lo rievoca e mai lo cita: dal fondale con paesaggio di una scenografia teatrale si passa a un paesaggio che seppur reale ha un evidente richiamo pittorico e al cinema del passato recente: a Tarkovsky in particolare e forse anche alla gravità di certo Bergman a colori e autunnale o ancora a quello simbolista in bianco e nero degli inizi (Il settimo sigillo, con le sue figure ieratiche in nero e teatrali); e poco prima si pensa ancora soprattutto a Tarkovsky mentre, proprio all’inizio, nella pianura in cui sono radunati i soldati reduci dalla guerra, si pensa alla pittura di un macchiaiolo come Fattori.
Ma alcuni dettagli, alcune macchie bluastre nell’erba e il fondo delle montagne annunciano sia i fondali dipinti che seguiranno sia il blu – un blu sempre sul crinale con il turchese – poi dominante: colore dell’etereo, del romantico, della raffinatezza e di Venezia, città del sogno dove all’orizzonte il colore del mare si confonde con quello del cielo. Città utero che a Duse darà tanto e viceversa.
E poi ancora con un paesaggio veloce colto dal finestrino del treno, denso e coloratissimo, magmatico, di un verde intenso, quasi psichedelico: questo frammento, un frammento di felicità – la più semplice quindi la più intensa, come quella di un bambino – è quello che la Duse vede dal finestrino e cerca di immortalare, nella sua fugacità, con la sua piccolissima cinepresa a manovella, effimera e volatile come un film muto e in bianco e nero. Il viaggio continuo che riassume l’essenza della vita dell’attrice, la vita che scorre o che (s)fugge. O come il flusso di un film, di questo film sul teatro ma non teatrale: piuttosto una contrapposizione affettuosa tra cinema e teatro: Duse è girato in maniera ravvicinata e continuata sui volti ed è spesso sussurrato; il teatro è giocato sui corpi e in genere la recitazione è ben scandita, talvolta altisonante.
Ma nel film su Eleonora Duse si parla anche tanto di arte, di teatro. Tuttavia non esattamente in maniera univoca e lineare. Appassionata nel difendere l’arte e gli amici ma incapace di essere madre – foss’anche in maniera semplice – si farà usare da Mussolini, che assicurerà una pensione all’attrice sommersa dai debiti, nel suo sogno fanciullesco di onorare l’Arte. Eleonora Duse è personaggio contraddittorio. Ma anche impetuoso e commovente come una Giovanna d’Arco dell’arte, capitana di una nave della bellezza in un mare dominato da uomini sparvieri.
Ma qui, a ben vedere, c’è un lavoro sulla recitazione spesso sopra le righe – in particolare nel personaggio di Zacconi, simbolo di un teatro tronfio e altisonante, dove le maiuscole abbondano, che Duse uccide progressivamente anche sotto la spinta di Sarah Bernhardt, sua concorrente diretta: straordinaria la sequenza in cui Duse si confronta con la giovane attrice della pièce di Ibsen, La donna del mare (messa in scena il 5 maggio 1921 al teatro Balbo di Torino): si oscilla continuamente tra registri sottilissimi: il grave, il comico, il melodramma e il farsesco si sovrappongono e si confondono.
Così come la ricerca di vita assoluta sempre e comunque si confonde con l’oblio, desiderato e temuto al contempo, la musica di Beethoven e Vivaldi si confonde con quella elettronica di Marco Messina, appositamente concepita, e il Rondò Veneziano. Una costante del cinema di Marcello è la ricerca, dietro le apparenze, dell’omogeneità nell’eterogeneità, negli opposti, al contrario delle ideologie oggi imperanti. Tra cui anche quelle di sinistra, che vogliono narrazioni un po’ troppo prive dell’ambiguità del mondo reale.
Anima incerta
Inoltre, se si parla dell’umile e del milite invisibile, il film narra un personaggio della modernità che è per metà invisibile: niente tracce sonore, un solo film muto con lei protagonista, Cenere, di cui sussistono poche foto e poche lettere. Come incarnare allora la “Divina Eleonora Duse”, “L’araba fenice che ha illuminato La Fenice”, “La matrigna del Teatro del soldato” che ha rivoluzionato completamente l’arte recitativa e che nelle tournée in Europa recitava in italiano, un personaggio che fu vero mito e che ebbe tra i suoi grandi amori perfino “il Vate” Gabriele D’Annunzio (che gli sopravvivrà ma che resterà legato a lei in maniera ombelicale)?
Pietro Marcello lo fa con il film di una biografia incerta al fine di rappresentare un’anima incerta ma allo stesso tempo del tutto certa nella ricerca incontenibile di un assoluto; ricerca fatta attraversando l’arte in tutte le sue sfumature e possibilità e attraversando l’era incerta in cui ha vissuto.
Soprattutto quando alla fine della sua vita si annunciava una seconda, doppia catastrofe: l’avvento del fascismo e un secondo conflitto mondiale. Un’era incerta, tempi incerti dai cattivi, funesti presagi. Proprio come oggi dove siamo tutti – di nuovo – sul crinale.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it