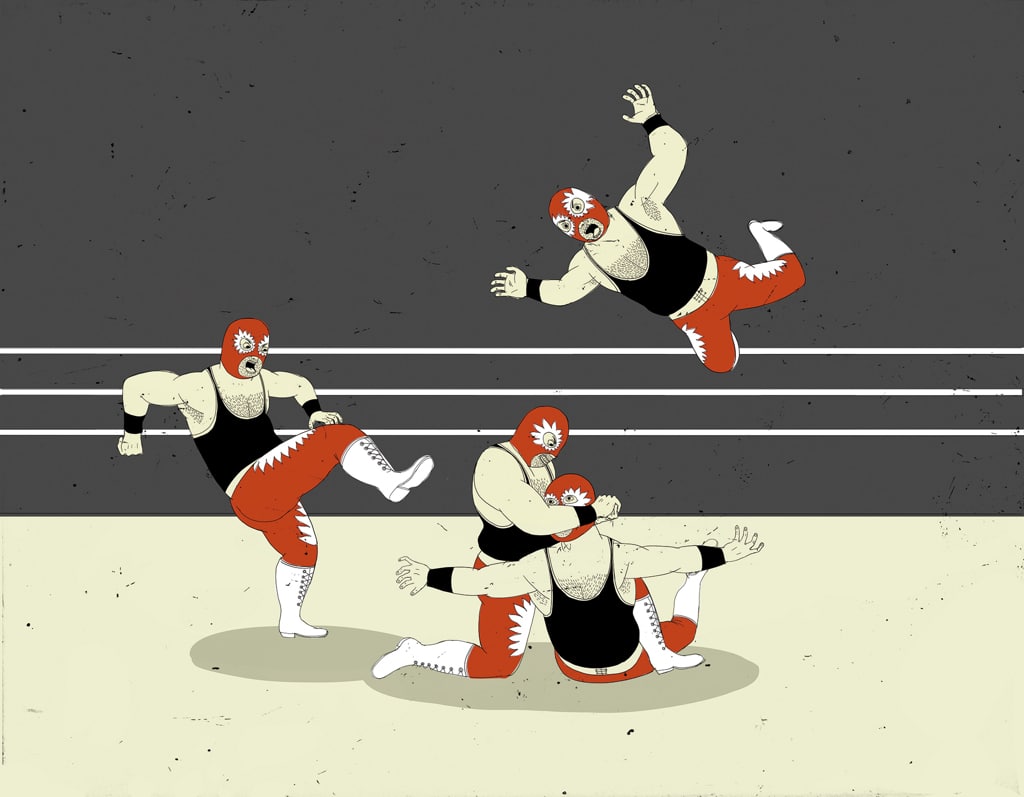Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2008 nel numero 770 di Internazionale.
Immaginate una lunga seduta dal dentista. Siete irrigiditi sulla poltrona, tenete i pugni stretti e sudate. Il dentista si china su di voi e dice: “Abbiamo finito. Se vuole può tornare a casa, altrimenti posso continuare ancora un po’, facendole sentire meno dolore”. Non è affatto scontato che la risposta più logica sia: “No, grazie”.
Daniel Kahneman, psicologo premio Nobel per l’economia, ha condotto una serie di studi sul ricordo delle esperienze dolorose e ha scoperto che quando pensiamo a quegli eventi siamo influenzati dall’intensità della loro conclusione: abbiamo un ricordo più positivo di un’esperienza finita con un dolore leggero rispetto a una che si è conclusa con una grande sofferenza. Alla proposta del dentista diremmo tutti di no, ma potrebbe essere meglio accettare, perché ne avremmo un ricordo meno spiacevole. Contraddizioni di questo tipo sorgono continuamente.
Se chiedessimo a un gruppo di persone se sono più felici al lavoro o in vacanza, ci risponderebbero che lavorano per andare in vacanza. Ma se gli dessimo un cicalino che suona a caso in vari momenti della giornata e gli chiedessimo di scrivere cosa stavano facendo e di che umore erano ogni volta che hanno sentito il bip, probabilmente scopriremmo che sono più felici al lavoro, perché spesso è più coinvolgente e socializzante delle vacanze. E se gli chiedessimo cosa le rende più felici nella vita, un terzo di loro direbbe che sono i figli o i nipoti. Ma quando usano un diario per registrare i loro momenti felici, di solito si scopre che occuparsi dei bambini è noioso.
Da sempre gli esseri umani si chiedono cosa li renda felici. Oggi c’è un nuovo approccio alla scienza del piacere che ci ha permesso di fare scoperte sorprendenti. L’aspetto più interessante è che sta emergendo una prospettiva diversa sulla felicità. In passato pensavamo che per rispondere alla domanda “Come faccio a essere felice?” la cosa più difficile fosse definire il significato di “felice”. Oggi, invece, sembra che sia più importante capire cosa significa “io”.
Molti ricercatori sono convinti che ognuno di noi sia costituito da una serie di sé in competizione tra loro, e che la felicità di uno di questi sé provochi spesso l’infelicità dell’altro. Questa teoria potrebbe spiegare alcuni misteri della vita quotidiana: aiuterebbe a capire, per esempio, perché è difficile liberarsi dalle dipendenze e dai comportamenti compulsivi, e perché passiamo tanto tempo in mondi che non esistono, come le fiction tv, i romanzi e la realtà virtuale. È anche un buon punto di partenza per riflettere sulla convinzione sempre più diffusa secondo cui le persone starebbero meglio se lo stato e le imprese le aiutassero a inibire alcuni sentimenti viscerali e certe reazioni emotive.
Come tutti i nostri organi, il cervello è costituito da componenti più grandi (come l’ippocampo e la corteccia visiva), formati da unità più piccole (come le mappe della corteccia visiva), che a loro volta sono fatte di parti ancora più piccole, fino ad arrivare ai miliardi di neuroni, la cui attivazione combinata ci permette di pensare. I neuroni sono costituiti da assoni e dendriti, che consistono in parti più piccole come i bottoni terminali e i siti recettori, che a loro volta sono fatti di molecole.
Le nuove ricerche di psicologia e neuroscienza partono da questa struttura gerarchica. L’idea è che le proprietà più interessanti del tutto (l’intelligenza, la capacità di prendere decisioni, le emozioni, la sensibilità morale) possono essere analizzate in termini di interazioni tra componenti che in sé non hanno queste proprietà. Funzionano così i computer, e abbiamo buoni motivi per ritenere che anche per gli esseri umani valga lo stesso principio.
Comunità di computer
Ma non tutti sono d’accordo. Alcuni studiosi sostengono che, nonostante contenga una serie di sottosistemi neurali specializzati in compiti come il riconoscimento dei volti e la comprensione della lingua, il cervello ha anche una parte che rappresenta la persona, un sé che coordina tutti i sistemi. Come ha scritto il filosofo Jerry Fodor, “se è vero che nella mia testa c’è una comunità di computer, sarebbe bene che ci fosse qualcuno che comanda, e che quel qualcuno fossi io”.
Alcuni teorici più radicali sostengono che c’è un conflitto intrinseco tra la scienza e la vecchia concezione della coscienza e della morale: se accettiamo che il nostro cervello sia costituito da una miriade di componenti più piccoli, dobbiamo rinunciare a concetti come quello di carattere, merito, colpa e libero arbitrio. Forse dovremmo rinunciare all’idea stessa che esista un sé, un individuo che perdura nel tempo.
La teoria che mi interessa di più è una via di mezzo tra questi due estremi. È conservatrice nel senso che accetta il fatto che il cervello genera sé che perdurano nel tempo e progettano il futuro. Ma è rivoluzionaria nel senso che rinuncia all’idea che ciascuno di noi abbia un solo sé. In ogni cervello ci sono molti sé diversi che vanno e vengono. Hanno desideri diversi e lottano tra di loro per il predominio: contrattano, complottano e s’ingannano a vicenda.
L’idea che dentro di noi ci siano diversi sé non è nuova. La troviamo già in Platone, ed è stata espressa bene nel settecento dal filosofo scozzese David Hume, che ha scritto: “Non potrei paragonare l’anima meglio che a una repubblica, a uno stato, i cui diversi membri sono uniti da un vincolo reciproco di governo e di subordinazione”. Walt Whitman ce ne dà una versione più concisa: “Sono vasto, contengo moltitudini”.
L’economista Thomas Schelling, un altro premio Nobel, illustra questo concetto con un semplice aneddoto: “Da bambino vidi un film sulla spedizione in Antartide dell’ammiraglio Byrd e rimasi colpito dal fatto che da piccolo usciva di casa in maniche di camicia per abituarsi a resistere al freddo. Quella sera decisi di andare a letto con una coperta in meno. Quella decisione era stata presa da un ragazzo che aveva caldo. Durante la notte un altro ragazzo si svegliò infreddolito. Faceva troppo freddo anche per alzarsi e andare a prendere la coperta e così decise di farlo il giorno dopo. Ma ogni sera, al momento di andare a dormire, decideva sempre il ragazzo che aveva caldo e sognava l’Antartide. Ogni volta, quindi, rifaceva la stessa cosa”.
Chiunque si senta affascinato da questa teoria, però, deve ammettere che non corrisponde molto alla nostra esperienza quotidiana. In generale pensiamo a noi stessi come a individui unici. Se venissi a sapere che domattina sarò torturato, la mia reazione sarebbe di terrore, non di pietà per il poveretto che vivrà nel mio corpo in quel momento. Se ora faccio qualcosa di terribile, più tardi mi sentirò in colpa e mi vergognerò, non sarò certo arrabbiato con un’altra persona. E non potrebbe essere diversamente.
Il nostro cervello si è evoluto allo scopo di proteggere il nostro corpo e di spingerlo a riprodursi. La nostra mente, quindi, dev’essere sensibile alle necessità del corpo che permane nel tempo: i figli che ho oggi saranno miei anche domani, e se ieri qualcuno mi ha fatto un torto, oggi non mi fiderò più di lui. La società e i rapporti umani non potrebbero esistere senza questa forma di continuità.
Chiunque riuscisse a convincersi che la persona che si sveglierà nel suo letto domani è qualcun altro non potrebbe pensare al suo interesse futuro, e sentimenti come amore, vergogna, orgoglio o senso di colpa non durerebbero mai a lungo. La molteplicità dei sé diventa più intuitiva se si considerano dei periodi di tempo più ampi. I sociopsicologi hanno scoperto alcune differenze tra il modo in cui pensiamo a noi stessi e quello in cui pensiamo agli altri.
Per esempio, tendiamo ad attribuire i nostri cattivi comportamenti a circostanze sfavorevoli, e quelli degli altri alla loro natura. Ma questa mancanza di imparzialità diminuisce quando pensiamo a noi stessi in un lontano passato o futuro. In quel caso ci vediamo esattamente come vediamo gli altri. Può essere difficile pensare alla persona che occuperà il nostro corpo domani come a qualcuno di diverso da noi, ma non lo è affatto con la persona che occuperà il nostro corpo tra vent’anni.
Identità dissociata
Possiamo vedere un esempio del conflitto tra i sé in una malattia mentale nota come disturbo dissociativo dell’identità (un tempo veniva chiamata disturbo da personalità multipla). Molti ricorderanno le scene drammatiche di certi film in cui un personaggio all’improvviso si contorce, tossisce, scuote la testa e diventa un altro. Il mio preferito è quello interpretato da Edward Norton in Schegge di paura, anche se alla fine si scopre che sta fingendo.
L’identità dissociata è un problema controverso. In passato questo disturbo non veniva diagnosticato quasi mai. Il numero di casi denunciati è aumentato a partire dagli anni ottanta, soprattutto negli Stati Uniti. La crescita può essere spiegata in diversi modi. Il disturbo venne inserito per la prima volta come categoria specifica nell’edizione del 1980 del Diagnostic and statistic manual of mental disorders. In quegli stessi anni, inoltre, furono pubblicati alcuni studi sulla personalità multipla.
L’interesse nei confronti di questo disturbo era già stato alimentato nel 1973 dal romanzo Sybil e dalla sua versione cinematografica del 1976, in cui Sally Field interpretava il ruolo di una donna con 16 personalità diverse. Molti psicologi sono convinti che l’aumento dei casi non sia il frutto di una maggiore capacità diagnostica, ma dipenda dal fatto che alcuni psicanalisti spingono involontariamente i loro pazienti a creare questi sé distinti con i giochi di ruolo o con l’ipnosi.
Negli ultimi anni ci sono stati pazienti che hanno fatto causa agli analisti. Una donna è riuscita a ottenere un risarcimento di due milioni di dollari, sostenendo che il suo psicoterapeuta aveva usato una tecnica di “recupero” della memoria per convincerla che aveva più di 120 personalità, tra cui quelle di alcuni bambini, di un angelo e di un’anatra. Ma ci sono comunque molte prove – tra cui alcuni studi basati sulle immagini cerebrali – a sostegno della tesi che alcune persone passano realmente da un sé a un altro, e che quei sé hanno ricordi e personalità diversi.
Uno di questi studi ha analizzato alcune donne a cui era stato diagnosticato un disturbo dissociativo dell’identità. Alle pazienti, che sostenevano di poter passare a comando da un’identità all’altra, è stato chiesto di ascoltare una cassetta registrata mentre venivano sottoposte a una tomografia a emissione di positroni (Pet). Quando la cassetta parlava della loro esperienza traumatica, si attivavano le parti del cervello corrispondenti alla memoria autobiografica solo se la donna era passata all’identità che aveva subìto quel trauma. Se invece aveva mantenuto un’altra identità, si attivavano parti diverse del cervello e scattava l’attività neurale legata di solito all’ascolto delle esperienze di un estraneo.
Molti psicologi e filosofi sostengono che questo disturbo dovrebbe essere visto come una versione estrema della normale molteplicità dei sé. Prendiamo, per esempio, la memoria. Una delle caratteristiche del disturbo dissociativo dell’identità è l’amnesia che si verifica quando un’identità non ha accesso ai ricordi delle altre identità. Ma è noto che la memoria dipende dalle situazioni anche per le persone normali: è più facile ricordare qualcosa se siamo nelle stesse condizioni in cui ci trovavamo quando è successa.
Gli studenti rispondono meglio se vengono interrogati nella stanza in cui hanno studiato. Se una persona ha saputo qualcosa quando era arrabbiata, la ricorderà più facilmente quando sarà arrabbiata di nuovo. Anche la nostra personalità cambia in base alle situazioni. Neanche il più violento degli adolescenti si comporta nello stesso modo se è con i suoi amici o prende il tè con la nonna. Questa dipendenza dalle situazioni è più evidente quando si tratta di comportamenti sbagliati.
Negli anni venti gli psicologi di Harvard misero alla prova diecimila bambini sottoponendoli a una batteria di test attitudinali in situazioni ambigue, in cui avevano la possibilità di copiare. Scoprirono così un’incredibile mancanza di coerenza. Non sempre un bambino che tendeva a barare nello sport era disposto anche a ingannare un insegnante. Da alcuni esperimenti più recenti, condotti su gruppi di adulti, è emerso che certe piccole cose possono influire in modo sorprendente sul nostro comportamento. Un buon odore, come quello del pane fresco, rende le persone più gentili e disponibili ad aiutare uno sconosciuto. Un odore cattivo le rende più critiche nei confronti degli altri.
Questi studi confermano la tesi che in ognuno di noi ci sono molti sé – alcuni violenti, altri remissivi o rispettosi – che possono emergere in base alle diverse situazioni. Una molteplicità fondamentale per il piacere. D’altronde l’attività di svago più comune non è fare sesso, mangiare, bere, drogarsi, fare sport o stare con le persone che amiamo, ma è partecipare a esperienze irreali: leggere romanzi, guardare film in tv, sognare a occhi aperti.
Per apprezzare la narrativa è necessario passare a un altro sé, rinunciare alla propria identità per proiettarsi in quella di altre persone, assumere il loro punto di vista tanto da condividere le loro esperienze. Così possiamo godere di situazioni immaginarie che nella vita reale ci sconvolgerebbero o ci rattristerebbero. Quando Tony Soprano uccide qualcuno, reagiamo in modo diverso da come reagiremmo a un vero omicidio: accettiamo e adottiamo le premesse morali dell’universo dei Soprano. Anche se solo per un istante, diventiamo Tony Soprano.
Alcuni piaceri della fantasia implicano la creazione di sé alternativi. A volte interagiamo con questi sé come se fossero altre persone. Può sembrare una cosa terribile, e a volte lo è davvero, come quando gli schizofrenici credono di sentire delle voci. Ma la loro versione più comune è innocua.
Amici immaginari
Nei bambini definiamo queste identità alternative amici immaginari. La psicologa Marjorie Taylor fa notare tre cose. In primo luogo, contrariamente a quanto pensano molti, i bambini che hanno amici immaginari non sono asociali, solitari o psicotici borderline. Al contrario, di solito sono leggermente più socievoli di altri bambini. In secondo luogo, non si illudono che i loro amici siano reali.
Taylor ha incontrato raramente un bambino che non fosse pienamente consapevole del fatto che quel personaggio esisteva solo nella sua immaginazione. Terzo, gli amici immaginari sono davvero sé diversi. A volte hanno desideri, interessi e bisogni differenti da quelli del bambino, possono essere indisciplinati e farlo arrabbiare.
Il giornalista Adam Gopnik ha raccontato dell’amico immaginario di sua figlia, Charlie Ravioli, un ragazzino della New York bene la cui caratteristica principale è quella di essere sempre troppo occupato per giocare con lei. A volte anche gli adulti hanno amici immaginari. Taylor ha scoperto che molti autori di libri con personaggi ricorrenti sostengono, in modo piuttosto convincente, che quei personaggi hanno una loro volontà e decidono del loro destino. Ma non è raro che qualcuno crei nella propria testa un’altra persona con cui interagisce per un breve periodo di tempo.
Quando sogniamo a occhi aperti, evochiamo altre persone, che a volte fanno solo parte dell’arredo scenico (come quando sogniamo di sesso o di sport), ma altre volte hanno una funzione sociale. Ogni tanto tutti noi parliamo con persone che non sono fisicamente presenti. A volte ci piace impersonare sé alternativi. Questo fenomeno è molto comune nei bambini, che si divertono ad assumere temporaneamente l’identità di un soldato o di un leone. Ma anche gli adulti si divertono a farlo. Sembra che la possibilità di esplorare identità alternative sia uno dei motivi per cui è stata inventata internet.
La sociologa Sherry Turkle ha scoperto che molto spesso le persone inventano un avatar per esplorare le loro possibilità in un ambiente relativamente sicuro. Turkle racconta di una ragazza di 16 anni con un padre violento che si era creata diversi personaggi online – un ragazzo di 16 anni, una ragazza più forte e decisa – per cercare di capire cosa doveva fare nel mondo reale. Ma spesso nella realtà virtuale si cambia identità per il puro piacere di farlo. Un uomo può scegliere come identità alternativa quella di una donna, un eterosessuale può esplorare il mondo dell’omosessualità, una persona timida può cercare di essere più vivace.
I mondi alternativi online, come World of warcraft e Second life, sono sempre più popolari e ci sono persone che passano più tempo lì che nel mondo reale. Uno psicologo ha chiesto a una sua assistente di provare uno di quei mondi per raccontargli com’era e come si comportavano le persone. La ragazza non è più tornata, ha preferito la realtà virtuale a quella vera.
Comportamenti compulsivi
La vita sarebbe perfetta se tutti i sé che convivono in una mente facessero squadra, si alleassero per raggiungere un obiettivo comune. Di solito, però, si scontrano tra loro, e a volte danno origine a quelle che chiamiamo dipendenze o comportamenti compulsivi. Ma quella di cui stiamo parlando non è la visione tradizionale della fragilità umana. La condizione umana è sempre stata vista come una battaglia tra il bene e il male, tra ragione e sentimento, volontà e pulsioni, super-io e io.
Il simbolo di questa lotta, che abbiamo visto in migliaia di film e di cartoni animati, è una persona con un angelo su una spalla e un diavolo sull’altra. La teoria alternativa mantiene l’angelo e il diavolo, ma elimina la persona. I due sé in competizione tra loro non sono sulla nostra spalla, ma nella nostra testa: l’angelo e il diavolo, il sé che vuole essere magro e quello che vuole mangiare la torta coesistono nella stessa persona.
Sulla base delle ricerche dello psichiatra George Ainslie, possiamo cercare di capire l’interazione tra questi sé calcolando i loro rapporti di forza nel corso del tempo. Bisogna partire dal presupposto che il primo (quello che vorrebbe mangiare il dolce) sia più debole del secondo (quello che vorrebbe stare a dieta). Per quasi tutto il giorno, quello che vorrebbe stare a dieta procede imperterrito per la sua strada (diciamo che la sua forza è 5 su una scala da 1 a 10), spronato dall’obiettivo a lungo termine di perdere peso, ed è più forte di quello che vorrebbe mangiare il dolce (la cui forza è 2).
Noi ci rendiamo conto di chi sta vincendo e decidiamo di non mangiare il dolce. Ma quando si avvicina l’ora di cena, la forza di quello che vorrebbe mangiare il dolce aumenta (passa a 3, a 4), e la situazione si inverte. Alla fine il mangiatore di torte ha la meglio (arriva a 6), e diventa il nostro io cosciente. A quel punto decidiamo di mangiare il dolce. A volte un sé prevede che più tardi sarà sopraffatto da un altro, e può fare qualcosa per impedirlo.
Questo atto viene chiamato autovincolo ed è stato studiato da Thomas Schelling e dal filosofo Jon Elster. Nel caso dell’autovincolo il sé dominante complotta contro la persona che potrebbe diventare: il 5 fa in modo che il 2 non diventi 6. Ulisse vuole sentire il canto delle sirene, ma sa che lo spingerebbe a gettarsi in mare, e chiede ai suoi marinai di legarlo all’albero maestro. Le persone che sono a dieta hanno il frigo vuoto per evitare di mangiare. I fumatori che vogliono smettere chiedono ai loro amici di non dargli mai una sigaretta.
Nel suo libro sulla golosità Francine Prose racconta di donne che telefonano agli alberghi dove andranno per chiedere di vuotare il minibar della loro stanza. Di recente è stata messa in vendita una sveglia che quando suona rotola via: per spegnerla bisogna alzarsi dal letto. Possiamo trionfare sul nostro sé futuro anche dandogli informazioni incomplete o sbagliate.
Se abbiamo paura che in una certa situazione ci lasceremo prendere dal panico, possiamo negare a noi stessi informazioni importanti: non guardare giù mentre stiamo camminando su una corda, non controllare le nostre azioni se abbiamo paura di venderle al primo accenno di perdita. Siamo ritardatari cronici? Mettiamo avanti l’orologio. Tendiamo a essere gelosi? Evitiamo di chiedere al nostro partner quale dei nostri amici considera più sexy.
Di recente, in collaborazione con gli psicologi Frank Keil di Yale e Katherine Choe del Goucher college, ho studiato la comprensione dell’autovincolo da parte dei bambini. A un gruppo di piccoli dai quattro ai sette anni ho mostrato brevi filmati di persone impegnate nell’autovincolo o in altri comportamenti e gli ho chiesto di spiegare cosa stava succedendo.
I bambini capivano subito che qualcuno poteva mettere un videogioco su uno scaffale in alto per impedire a qualcun altro di arrivarci. Ma l’autovincolo li confondeva: erano disorientati quando qualcuno nascondeva il gioco dove non poteva più riprenderlo. Ma anche se non capiscono l’autovincolo, è dimostrato che i bambini lo praticano.
In uno studio degli anni settanta gli psicologi offrivano ai bambini una caramella e gli dicevano che potevano averne di più se aspettavano qualche minuto. Com’era prevedibile, aspettare era difficile, ma alcuni bambini ci riuscivano grazie all’autovincolo: distoglievano lo sguardo o coprivano la caramella per vincere il loro sé che avrebbe ceduto alla tentazione e concedere un piacere maggiore al loro sé futuro.
Per gli esseri umani adulti, tuttavia, il problema è che anche il sé che stanno cercando di vincolare ha le sue risorse. Combattere contro il sé cattivo è una faccenda seria. Cerchiamo di corromperlo, minacciarlo e ingannarlo. Ma spesso impegni vaghi come “prometto di bere solo nelle occasioni speciali” non funzionano, perché il sé cattivo è capace di sottrarsi facilmente trovando speciali tutte le occasioni.
Anche regole ferree come “non giocherò mai più a un videogioco” sono facili da infrangere, perché il sé cattivo può sostenere che sono irragionevoli o convincerci, la prima volta che cediamo, che quel sistema non può funzionare. A ogni affermazione del sé che ha deciso di mettersi a dieta, come “questa dieta sta funzionando davvero” o “devo assolutamente perdere peso”, il mangiatore di dolci può rispondere: “Non funzionerà mai” o “sono troppo vanitoso” o “si vive una volta sola”.
Il nostro sé a lungo termine legge avidamente tutto quello che trova sui vantaggi dell’esercizio fisico e di un’alimentazione sana. Il mangiatore di dolci, invece, preferisce gli articoli che dimostrano che l’obesità non è un vero problema. La carne è debole, ma a volte è anche molto furba.
Il problema dei figli
In passato era tutto più semplice. Secondo la teoria classica, esiste un unico sé che programma a lungo termine e lotta contro le passioni, i comportamenti compulsivi, gli impulsi e le dipendenze. A livello individuale e sociale è facile capire chi dovrebbe vincere, perché c’è un solo interesse in gioco, quello di una persona che combatte i suoi impulsi. E anche se è difficile sapere qual è la cosa giusta da fare, la scelta si basa comunque su un ragionamento razionale.
Se vediamo le cose in questo modo, spesso ci inganniamo su quello che ci rende felici. Prendiamo di nuovo il problema dei figli. Non solo gli studi sui diari, ma anche quelli sulla felicità coniugale dimostrano che all’inizio le coppie sono felici, lo sono meno quando nascono i figli e tornano a esserlo quando i figli se ne vanno di casa.
Come spiega lo psicologo Daniel Gilbert, “nonostante quello che leggiamo nella stampa popolare, l’unico vero sintomo della ‘sindrome del nido vuoto’ è una maggiore tendenza a sorridere”. Allora perché le persone sono convinte che i figli diano tanto piacere? Gilbert la considera un’illusione, una previsione affettiva errata. Se le persone pensano che avere figli sia una buona cosa, la società ci guadagna. Per questo siamo inondati di immagini e di storie su quanto sono meravigliosi i bambini.
La teoria della molteplicità dei sé ci offre una prospettiva diversa. Se la ricerca della felicità comporta una lotta tra i diversi sé, non possiamo più essere tanto sicuri che i nostri cambiamenti di opinione nel corso del tempo siano frutto dell’irrazionalità o di un semplice errore. Non c’è nessuna incoerenza tra una persona che attraversa faticosamente l’Amazzonia sognando di essere a casa immersa in un bagno caldo e quella che, qualche settimana dopo, è orgogliosa del suo sé che si è avventurato nella foresta pluviale.
In un certo senso la persona che è andata in Amazzonia non è la stessa che, una volta tornata a casa, ricorda quell’esperienza. Proprio come la persona sinceramente convinta che i figli siano una grande gioia non è la stessa che li trova terribilmente fastidiosi. Anche se ognuno di noi è una comunità, non tutti quelli che ne fanno parte dovrebbero avere la stessa voce in capitolo. Alcuni di loro vanno considerati come bambini piccoli e, proprio come avviene nella società, gli adulti che sono dentro di noi hanno il diritto, anzi il dovere, di tenerli a freno.
In realtà, parlare di una contrapposizione tra “bambini” e “adulti” all’interno di un individuo non è solo una metafora. Uno dei motivi per attribuire più importanza al sé a lungo termine è che in effetti è più vecchio ed esperto. Nel corso della nostra vita passiamo più tempo senza desiderare di sniffare cocaina, fumare e mangiare troppo, di quanto ne passiamo a desiderare di farlo. Questo significa che il sé a lungo termine ha più tempo per riflettere e cerca di controllare i sé a breve termine.
Come osserva Jon Elster, il sé a lungo termine che vuole restare sobrio è quello più vero, perché cerca di vincolare il sé ubriacone a breve termine. È lui l’adulto. I governi e le aziende che hanno scoperto queste tendenze hanno cominciato a offrire programmi di autovincolo. Nel Missouri migliaia di persone schiave del gioco d’azzardo hanno deciso di firmare un contratto in cui autorizzano lo stato a confiscare tutto quello che vincono e ad arrestarli se entrano di nuovo in un casinò.
Alcuni miei colleghi di Yale hanno progettato un servizio online che permette di fissarsi un obiettivo e di puntare una certa somma di denaro sulla sua realizzazione. Se la persona ci riesce, il denaro gli viene restituito, altrimenti viene dato in beneficenza o, meglio ancora , a un’organizzazione che non vorrebbe mai finanziare. Per esempio, se un democratico che si propone di perdere mezzo chilo a settimana non raggiunge l’obiettivo, può essere punito donando cento dollari alla Biblioteca presidenziale di George W. Bush.
Il prolungamento naturale di questo tipo di autovincolo è quello che l’economista Richard Thaler e il giurista Cass Sunstein chiamano “paternalismo libertario”, un movimento che mira a creare situazioni in cui le persone mantengono la loro libertà di scelta (la parte libertaria), ma sono condizionate a favore della parte migliore di loro (la parte paternalistica). Molte persone, per esempio, non risparmiano soldi per la vecchiaia perché trovano troppo oneroso e complicato scegliere un piano pensionistico.
Thaler e Sunstein suggeriscono alle aziende di invertire la situazione: fare in modo che tutti i dipendenti siano iscritti automaticamente a un piano pensionistico e stabilire che debbano fare qualcosa se vogliono uscirne. Un altro esempio è quello della donazione di organi. La maggior parte degli statunitensi dice che in caso di morte cerebrale dovuta a un incidente vorrebbe donare i suoi organi. Solo la metà, però, fa registrare questa volontà sulla patente o ha una tessera da donatore.
Thaler e Sunstein hanno proposto un altro sistema: le persone possono scegliere di non donare i propri organi, ma se non fanno niente, si presume che abbiano dato il loro consenso. Queste proposte stanno cominciando a influenzare la legge e la politica, e potrebbero farlo ancora di più in futuro.
Vincoli esterni
Cosa c’è che non va allora? Tutto quello che rende più facile autovincolarsi è benvenuto. Per scrivere questo articolo sto usando un programma che disattiva il mio collegamento a internet per un po’ di tempo, così sono costretto a scrivere invece di andare a controllare la posta o a leggere qualche blog. Si può anche potenziare il proprio io a lungo termine con dei farmaci che aiutano la concentrazione.
Il giornalista Joshua Foer dice che così riesce a scrivere senza interrompersi anche per un’ora: “Sembra che si spenga la parte del mio cervello curiosa di sapere se mi sono arrivate nuove email”. Ma se ci vincola qualcun altro, la questione è più problematica. Non sarei felice se il capo del mio dipartimento mi costringesse a prendere un farmaco, o se il governo mi multasse perché sono sovrappeso e non cerco di dimagrire.
Alcuni vincoli esterni esistono già: pensate al periodo che bisogna aspettare obbligatoriamente per ottenere un divorzio o per comprare un’arma. Nessuno ci impedisce di fare queste cose, ma siamo costretti a pensarci bene, dando al nostro sé più riflessivo la possibilità di averla vinta su quello più impulsivo. E dato che i governi e le aziende continuano a chiedere alle persone di fare delle scelte, devono pur stabilire un’opzione di default.
Se è necessario prendere delle decisioni, perché non strutturarle in modo che siano nell’interesse degli individui e della società? Il problema principale è che il sé a lungo termine non ha sempre ragione. A volte quello a breve termine non dovrebbe essere vincolato. Ovviamente è giusto liberarsi da qualsiasi dipendenza.
Quando una madre diventa dipendente dalla cocaina, sembra che il piacere della droga si impossessi di tutto il suo sistema neurale, che altrimenti si dedicherebbe al rapporto con il figlio. Quindi è giusto vincolare il suo sé a breve termine tossicodipendente. D’altra parte, dal punto di vista psicologico, anche l’amore di una madre per suo figlio può essere una dipendenza. Ma in questo caso un vincolo sarebbe considerato immorale, perché si tratta di una dipendenza giusta.
Una persona che sta diventando obesa ha bisogno di autovincolarsi di più, ma forse chi è sempre ossessivamente a dieta dovrebbe farlo di meno. Una persona che smette di guardare video porno su internet per costruire case per i poveri non la giudichiamo allo stesso modo di una che reprime il desiderio di giocare con i figli per dedicare tutte le sue energie a guadagnare un altro milione. Questo è soprattutto vero quando dobbiamo dare un giudizio morale.
Molti atti di crudeltà sono commessi da persone che non riescono a controllare i loro impulsi a breve termine o che fanno scelte – come quella di ubriacarsi – che soffocano il loro sé riflessivo. Ma possono essere commessi anche da persone intelligenti e fedeli a dei princìpi che gli consentono di ignorare la loro moralità istintiva. Azioni terroristiche come gli attacchi suicidi di solito non sono commesse in un momento di follia, ma sono il frutto di convinzioni profonde e di una lunga programmazione.
Uno degli esempi peggiori di razionalità distorta è la spiegazione che lo psichiatra Robert Jay Lifton dà del comportamento dei medici nazisti: quegli uomini avevano cercato per anni di tenere a bada le loro emozioni creandosi un “sé di Auschwitz” che impediva alla normale compassione umana di interferire con il loro lavoro. Non mi piacerebbe abitare vicino a una persona che ha un comportamento dominato dai suoi sé a breve termine. Ma c’è qualcosa di sbagliato anche in quelli che esagerano nella direzione opposta.
A livello intellettuale e personale, l’interazione tra i nostri diversi sé, dall’equilibrio tra la riflessività a lungo termine e l’impulsività a breve termine sono utili. Dobbiamo fare attenzione a non turbare questo equilibrio. La nostra comunità interna non dovrebbe essere una democrazia, ma neanche una dittatura.
(Traduzione di Bruna Tortorella)
Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2008 nel numero 770 di Internazionale.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it