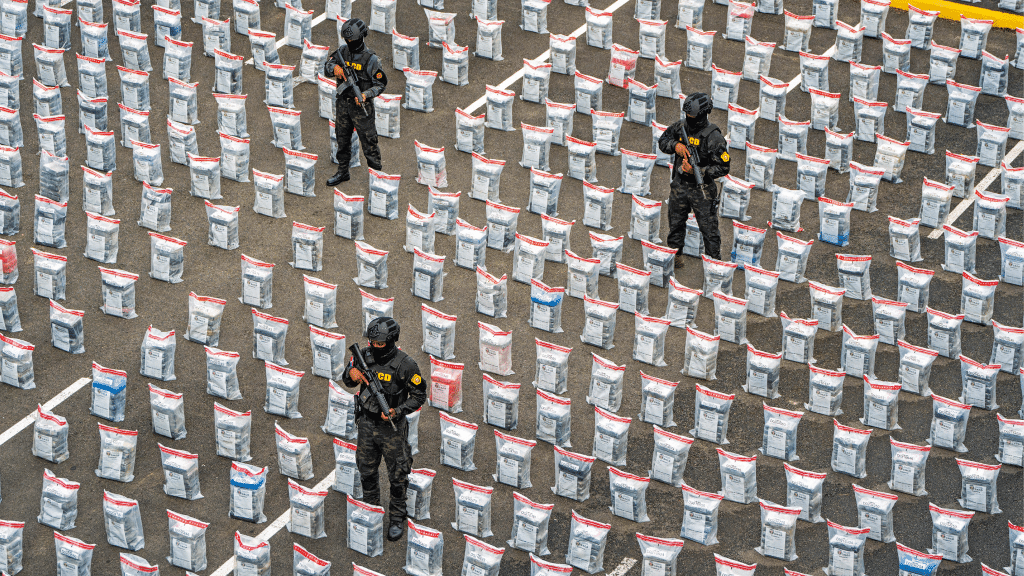Il palmarès della ottantaduesima mostra del cinema di Venezia – un’edizione nel segno della Palestina e della tragedia di Gaza come sottolineato da più parti – ha luci e ombre proprio come la selezione, in termini sia produttivi sia distributivi. Troppa America, troppe lobby, quasi un’overdose. Ne è un esempio proprio l’opera che ha vinto il Leone d’oro, Father mother sister brother di Jim Jarmusch.
Contrariamente a tanti altri, il film di Jarmusch (distribuito dalla Lucky Red) ci è piaciuto molto, anche se non è uno dei suoi capolavori.
In questo film a episodi, Jarmusch allestisce, da maestro del minimalismo, un giardino di fiori sprigionanti contenuto, che germogliano lentamente e poi fioriscono volutamente con forza nell’episodio conclusivo: da qui viene la primavera della parte finale e l’apparente minor forza dei primi due episodi, soprattutto del primo. Dietro le apparenze – il regista fa di tutto per confonderci e da un episodio all’altro ci si sposta dalle zone rurali del nordest degli Stati Uniti a Dublino e infine a Parigi – è raccontato un unico luogo, la Terra, così malmenata; e un’unica famiglia, l’umanità tutta, in cui riconosceremo tutti la nostra famiglia: quando non c’è più, chi ci ha generato rivela tutta la sua presenza. Ci voleva Jarmusch per interrompere la tendenza del cinema statunitense al nichilismo, all’asettico o a entrambi, e il Leone d’argento – premio per la miglior regia a Benny Safdie per The smashing machine (I Wonder Pictures) – ne è un’ulteriore piacevole conferma.
Se il film di Benny Safdie non ha la potente ricerca formale degli altri realizzati con il fratello Josh (speriamo tornino a far coppia), la storia vera del lottatore Mark Kerr – interpretato da un altro lottatore, Dwayne Johnson, da tempo dedito al cinema – è un altro gioiello umanistico dove l’empatia con la persona amata a un dato momento rompe la diga dell’ossessione per la ricerca del successo e straripano i sentimenti di amore e amicizia (verso la compagna ma anche verso l’amico di sempre, qui concorrente). Un gran film antiamericano, se si guarda ai temi della ricerca della ricchezza e del successo che divorano tutto nei rapporti umani, e allo stesso tempo idealmente intrecciato alla grande tradizione del cinema umanistico della Hollywood classica, da John Ford a Frank Capra.
Il Gran premio della giuria, secondo per ordine gerarchico, assegnato a The voice of Hind Rajab (I Wonder Pictures) di Kaouther Ben Hania, avrebbe potuto essere il suggello definitivo di un umanesimo ritrovato, tanto più che il film della cineasta tusinina ha nella struttura produttiva molte figure del cinema angloamericano, dall’attore Brad Pitt al cineasta di origini ebraiche Jonathan Glazer. Ma così non è. Potremmo anzi dire che è l’esatto opposto di un’opera magistrale come La zona d’interesse di Glazer. Esibizione continua di un procedimento formale – la voce di una bambina di Gaza di tre anni che parla al cellulare con i soccorittori, dall’auto in cui è rimasta intrappolata e in cui i suoi familiari sono stati uccisi dai proiettili dei militari israeliani –, l’opera di Ben Hania finisce per sabotare tutto con un procedimento asettico che vuole riprendere gli approcci concettuali di tanto cinema iraniano senza saper minimamente metterci dentro le sue finezze (la parabola antica, i dettagli che creano l’affresco o altro ancora) e creano invece solo significazioni didascaliche da docudrama: il procedimento che si vuole metafora – la stanza dei soccorritori è il paradigma dell’impotenza palestinese e internazionale, delle pastoie burocratiche e politiche – si esaurisce nello scolastico e nel meccanico prevedibile.
E paradossalmente riproduce all’interno un’asetticità da intelligenza artificiale. Mentre invece anche le opere sulle tragedie più grandi devono trasmettere una forma di bellezza: un classico sull’Olocausto come Notte e nebbia di Alain Resnais, malgrado dia conto dell’orrore più indicibile, è un’opera inesauribile. Tanti film di oggi, soprattutto quelli rivolti a un più vasto pubblico, rispetto alle opere del passato sono carenti delle vitamine dell’interiorità, della capacità di evocare delle atmosfere, di creare empatia. E troppo spesso rivederli non servirebbe a riassaporare alcuni momenti chiave o a scavare alla ricerca di nuove rivelazioni o emozioni. Inoltre il film di Ben Hania è davvero fondato su un ricatto emotivo verso chi lo guarda, giurie comprese, tanto più che fa uso delle registrazioni audio originali.
L’idea di fare un film su una tematica così devastante rivolto al grande pubblico resta buona ma speriamo in un’altra occasione poiché, purtroppo, lo sterminio criminale in corso a Gaza potrebbe durare ancora a lungo. È un fatto positivo, però, che sia stato sponsorizzato da tanti nomi noti sotto forma di produttori esecutivi: oltre a Pitt e Glazer, anche Joaquin Phoenix, Rooney Mara e Alfonso Cuarón.
Ma se il premio smentisce quanto detto dal presidente della giuria Alexander Payne sul pericolo di mescolare politica e arte (anche se in realtà il problema è il come: basti pensare a tanto cinema italiano di denuncia degli anni sessanta e settanta, come quello di Francesco Rosi), in compenso non oscura né l’appello di tanti artisti del cinema, come Marco Bellocchio, Mario Martone, Matteo Garrone, Alice e Alba Rohrwacher, Pietro Marcello, e tanti giornalisti e critici a boicottare chi sostiene la politica di Israele né la bella e ampia manifestazione di solidarietà a Gaza del Lido. E per quanto si possano fare critiche alla mostra del cinema – che non è un festival come quelli di Cannes o Locarno, ma fa parte di un’istituzione controllata dallo stato come la Biennale d’Arte – il dialogo dimostrato dal direttore artistico Alberto Barbera e l’aver lasciato liberi gli artisti di fare le loro dichiarazioni di sostegno a Gaza durante la cerimonia di premiazione dovrebbe segnare l’avvenire degli altri festival.
Troppo spazio ai grandi
Aggiungeremo ancora che il raccontare la realtà, soprattutto politica, in maniera scolastica e meccanica è stato il problema di altri film visti qui, come Il mago del Cremlino (01 Distribution) del francese Olivier Assayas , anemico e banale in tutto sulla scalata al potere di Vladimir Putin (con un grande Jude Law) o come A house of dynamite (Netflix) della pur geniale Kathryn Bigelow. Riprendendo la struttura di uno dei capolavori di Gus Van Sant – Elephant, in cui il massacro della Columbine High School del 1999 è raccontato dal punto di vista di tre studenti – nel film di Bigelow un potenziale attacco missilistico nucleare sul territorio americano è raccontato da tre punti di vista diversi, con una piccola sorpresa finale sull’identità del presidente.
La cineasta è brava e coraggiosa nel mettere in evidenza l’assurdità di un meccanismo che fallisce tecnicamente – non riesce a neutralizzare i missili in arrivo e non lascia il tempo necessario ai dirigenti politici di fare le opportune verifiche prima di scatenare la guerra nucleare totale – e nel far capire che non si fanno simulazioni sperimentali su un possibile evento di questo genere. Avvincente, il film ha però un po’ il fiato corto. Mentre invece avrebbe meritato un premio un’opera satirica viva e sfaccettata sulla famiglia sudcoreana, e altrettanto avvincente, come No other choice (Lucky Red) di Park Chan-wook.
In questo contesto, il Premio speciale della giuria a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, già vincitore di un Leone d’oro e di un Orso d’oro, sembra un po’ infilato: c’è troppa America, troppi film targati Netflix o Mubi che sembrano fare lobby. Frankenstein di Guillermo del Toro, Jay Kelly di Noah Baumbach, A house of dynamite di Kathryn Bigelow o il film di Jarmusch, targato Mubi e Yves Saint Laurent, sembrano ostruire le possibilità per gli altri, più piccoli, e di far emergere nuovi nomi, volti giovani e non legati a produzioni elefantiache (a queste va aggiunto anche Yorgos Lanthimos con Bugonia, che arriverà in sala con la Universal).
Così il premio per la miglior sceneggiatura assegnato a À pied d’œuvre (Teodora film) di Valérie Donzelli , su un fotografo di successo che volendo diventare uno scrittore finisce in povertà, non mette nel risalto dovuto una giovane cineasta che, dopo risultati alterni arriva alla piena maturità con un film breve – rispetto alle durate smisurate di grandissima parte dei titoli selezionati – dalla straordinaria intensità e profondità, sia psicologica e intima sia di denuncia sociale, che non è soltanto dovuta all’eccellente sceneggiatura scritta da Donzelli insieme al sempre ottimo Gilles Marchand, ma un piccolo capolavoro prima di tutto di regia e montaggio perfettamente e finemente cesellati.
Oppure il meraviglioso Duse (01 Distribution), che certamente avrebbe meritato uno dei massimi premi se non il Leone d’oro, e avrebbe consacrato un volto nuovo del cinema italiano, Pietro Marcello, dallo stile innovativo e fuori da tutti i registri; così come non abbiamo visto nel concorso interpreti femminili migliori di Valeria Bruni Tedeschi, che ci restituisce la grande diva come fosse una parte di sé. È stata premiata invece Xin Zhilei, protagonista di The sun rises on us all (Wanted) di Cai Shangjun, in verità dignitoso ma al quale preferiamo il pur disuguale Girl (I Wonder Pictures) dell’attrice taiwanese Shu Qi, qui debuttante alla regia, impregnato di atmosfere alla Hou Hsiao-hsien – cinema di cui l’attrice è stata parte fondamentale.
E al pur eccellente Toni Servillo, vettore di La grazia di Paolo Sorrentino, anteponiamo un attore emergente come Jacob Elordi, che riesce nell’exploit di dare al mostro di Frankenstein un’aurea non soltanto malinconica ma a tratti perfino nobile, così come Benjamin Voisin, altro bel volto da divo, riesce a restituire tutto il mistero ineffabile del protagonista di L’étranger (Bim) di François Ozon.
Il premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente andato a Luna Wedler, per Silent friend (Movies Inspired) di Ildikó Enyedi, è un riconoscimento all’interprete dell’unico personaggio ben delineato nel film della regista ungherese dall’indubbio talento figurativo. Come dispiace sia stato del tutto ignorato un altro titolo ungherese, Orphan (Movies Inspired) di László Nemes , parabola allegorica sull’Ungheria comunista degli anni cinquanta dalla grande potenza evocativa.
Infine una rivelazione nella sezione Orizzonti, dove è stato premiato per la miglior interpretazione maschile il giovane Giacomo Covi, protagonista di Un anno di scuola, secondo lungometraggio di Laura Samani. Raramente si vede in Italia un film così ben scritto e diretto.
In attesa di un palmarés che premi quel che è davvero innovativo, meritevole e fatto con umiltà (come il film di Samani), apprestiamoci a tornare in sala con gioia per scoprire i film di Venezia, Cannes e degli altri festival.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it