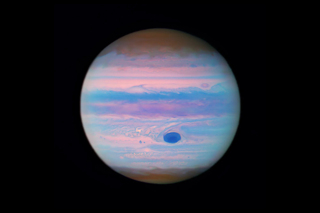Nel giro di pochi giorni, tra il 18 e il 22 settembre, il colosso statunitense dei microchip Nvidia ha annunciato due accordi che hanno fatto parlare di sé per vari motivi. Il primo riguarda l’investimento di cinque miliardi di dollari nel capitale della rivale Intel, da tempo in difficoltà, con l’obiettivo di sviluppare processori per pc e data centre. Un’operazione letteralmente impensabile fino a poco tempo fa, almeno prima che un’azienda leader come la Intel non perdesse il treno dell’intelligenza artificiale proprio a vantaggio della Nvidia e non cominciasse a bruciare miliardi di dollari. In The Nvidia way, un libro sull’azienda uscito di recente, scrive il Financial Times, si racconta che in tempi non sospetti, nel 1998, Jensen Huang, il cofondatore e amministratore delegato della Nvidia, diceva: “Quelli della Intel sono lì per farci fuori. Dobbiamo ucciderli noi prima che lo facciano loro”.
Il secondo accordo è l’alleanza con l’azienda d’intelligenza artificiale OpenAi che, in cambio di un investimento di cento miliardi, realizzerà sistemi da dieci gigawatt basati sui microchip della Nvidia per allenare i suoi modelli di nuova generazione. Molti esperti hanno espresso seri dubbi sui tempi e sull’effettiva riuscita dell’operazione, chiedendosi chi fornirà l’energia necessaria per i sistemi progettati (secondo alcune stime, potrebbero consumarne quanto quella richiesta da otto milioni di abitazioni, praticamente una metropoli come New York) oppure quanti dei cento miliardi torneranno alla Nvidia sotto forma di acquisto di processori. Alcuni fanno notare come la Nvidia, che con più di quattromila miliardi di dollari è l’azienda con il più alto valore di borsa del mondo, stia dando dei soldi alla più grande azienda non quotata del mondo (la OpenAi) per farle comprare i suoi processori ed evitare che se li faccia da sola.
L’Economist scrive che “la Silicon valley sta diventando più incestuosa che mai”. Il 25 settembre Bloomberg ha rivelato che anche la Apple potrebbe presto investire nel capitale della Intel. Ma è anche vero che accordi come quelli della Nvidia arrivano in un momento in cui l’amministrazione di Donald Trump sta esercitando pressioni fortissime perché in futuro la produzione di microchip, l’industria dell’intelligenza artificiale con le sue enormi infrastrutture e in generale l’alta tecnologia restino negli Stati Uniti. Ad agosto il governo statunitense era intervenuto direttamente comprando il 10 per cento del capitale della Intel. Il 5 settembre, inoltre, Trump aveva riunito a pranzo tutti i leader delle grandi aziende tecnologiche statunitensi (tranne Elon Musk, ormai caduto in disgrazia), che avevano fatto a gara per assicurare al presidente il loro impegno a investire centinaia di miliardi di dollari nel paese.
Ma l’influenza dello stato nell’economia non si limita all’alta tecnologia. Trump vuole “mettere al sicuro” tutti i settori che considera strategici per il paese. Il Wall Street Journal riferisce che la Casa Bianca vorrebbe usare i 550 miliardi di dollari letteralmente estorti al Giappone con il trattato commerciale concluso a luglio (ne ho parlato in questo articolo) per rafforzare vari settori manifatturieri, tra cui l’estrazione mineraria, il settore farmaceutico, la cantieristica e l’energia.
In un paese famoso come baluardo del liberismo, fa notare il Financial Times, certe notizie dovrebbero fare scalpore. Dopo aver comprato una quota della Intel, Trump ha dichiarato che il governo potrebbe anche entrare nel capitale della Lockheed Martin, un gruppo legato alle forniture militari. A luglio, inoltre, il Pentagono ha speso 400 milioni di dollari per acquisire il 15 per cento della Mp Materials, un’azienda statunitense che vuole diventare protagonista del mercato delle terre rare (un settore attualmente dominato dalla Cina).
Il quotidiano finanziario britannico parla di “nuovo capitalismo patriottico”: negli Stati Uniti sta prendendo piede “una visione mercantilistica” dell’economia, un capitalismo a guida statale, un sistema in cui le aziende restano private, non si arriva certo alla nazionalizzazione dei mezzi di produzione, ma devono adeguarsi alle direttive strategiche del governo. Vanno letti in questo senso anche i recenti accordi del settore tecnologico: il principio guida non è più unicamente il profitto, ma è affiancato dall’interesse nazionale, e in caso di conflitto è quest’ultimo che prevale. Ora molti cominciano a chiedersi se presto il capitalismo patriottico non coinvolgerà la SpaceX di Elon Musk o i cavi sottomarini di Google.
Secondo il Wall Street Journal, Trump sta chiaramente modellando il sistema statunitense sull’esempio di quello cinese: “In occidente ormai molti ammirano Pechino per la sua capacità di far decollare l’economia attraverso enormi investimenti nelle infrastrutture, nella ricerca scientifica e nella promozione dei settori industriali strategici” senza dover fare i conti con i pesi e contrappesi e i compromessi di una democrazia pluralistica. I tempi sono senza dubbio eccezionali: all’inizio del millennio si pensava che la Cina sarebbe diventata gradualmente un po’ più americana, mentre oggi sono gli Stati Uniti che stanno diventando gradualmente un po’ più cinesi.
Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.
|
Iscriviti a Economica |
La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Economica
|
|
La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it