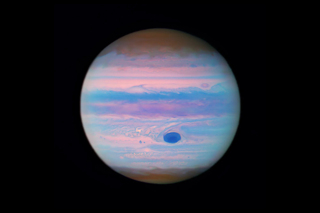Verso la fine del libro Lettera alla scuola un ragazzo delle superiori, Marco, intervista il sociologo Claudio Cippitelli, esperto di culture giovanili e dipendenze. Tra le tante cose su cui riflettono, a un certo punto Cippitelli cita un vecchio articolo del New York Times scritto da Elliot Cohen e uscito il 7 gennaio 1945, che promuoveva un “Teen-age bill of rights”: un documento rivolto agli adulti in cui si elencano dieci diritti che andrebbero riconosciuti agli adolescenti. Non ne avevo mai sentito parlare e mi ha incuriosito.
Questa “carta dei diritti” era il frutto del lavoro del Jewish board of guardians, un’organizzazione non profit legata alla comunità ebraica di New York e impegnata nell’assistenza all’infanzia e nella prevenzione della delinquenza (attiva ancora oggi come Jewish board of family and children’s services). Cohen era un intellettuale molto vicino a quella comunità. Sempre nel 1945 fondò Commentary, una rivista piuttosto influente nata con un orientamento laico e progressista che si spostò abbastanza presto su posizioni di destra (Woody Allen la prende di mira in tre film – Il dittatore dello stato libero di Bananas, Io e Annie e Crimini e misfatti).
Per il suo articolo sul New York Times Cohen prendeva spunto da un dibattito per quello che allora sembrava un oggetto misterioso: gli adolescenti. L’opinione pubblica oscillava tra “cosa non va nei nostri figli?” e “cosa non va in noi?”. Il risultato, secondo lui, erano solo degli adulti disorientati. Per limitare la confusione proponeva una raccolta di princìpi, chiamata appunto “Teen-age bill of rights”. La riporto qui, sintetizzandola e adattandola un po’.
- Il diritto di chiudere con l’infanzia
Tutti siamo stati bambini. Ma agli adolescenti non piace che gli si ricordi che erano piccoli fino a ieri, e di essere trattati come se oggi fosse ieri. I genitori spesso non vogliono riconoscere che i loro figli non sono più degli adorabili bambini. Fanno finta di non capire che quello che per loro è carino, per i figli è imbarazzante. Ci può essere il ragazzo che vuole entrare nella squadra di atletica leggera della sua scuola, per essere “uno dei grandi”. Oppure un altro che fa parte del gruppo di dibattito; per l’insegnante è convincente, sa molte cose e impara in fretta. Ma quando tornano a casa entrambi sono trattati come dei ragazzini, a cui viene ripetuto di comportarsi bene. Non c’è niente di più fastidioso della frase “dopotutto, sei ancora un bambino”.
- Il diritto di partecipare a decisioni che riguardano la propria vita
Le scelte che influenzano gli adolescenti devono essere prese soprattutto da loro, sicuramente con loro e mai al posto loro. Jack, per esempio, vuole diventare meccanico di aeroplani, o forse pilota, non lo sa ancora. In ogni caso pensa d’iscriversi a un istituto tecnico o professionale. Il padre non è d’accordo, vuole che faccia il liceo e dopo il diploma potrà pensare al suo futuro. In questo confronto non c’è un giusto o sbagliato. Ma un adulto che dice “decido io, sei troppo giovane per capire cos’è meglio per te” è un invito a nozze all’inevitabile “ma è la mia vita!”. Sarebbe più facile se il padre riconoscesse che Jack ha il diritto di dire la sua sul proprio futuro, e Jack capisse che il padre lo può aiutare a scegliere bene.
- Il diritto di sbagliare
Si tende a vedere i figli come dei ragazzi maturi un giorno e dei bambini spaventati il giorno dopo, e non si riesce a prendere sul serio la parte matura. Ma è la più importante, perché è in divenire. Ragazze e ragazzi devono essere incoraggiati, anche se il rischio è di commettere errori; questo non significa lasciare che se la cavino da soli. Se qualcosa va storto è parte del processo di apprendimento. Vale per chi sta male dopo aver fumato la prima sigaretta, come per chi fa i primi esperimenti allo specchio con il rossetto.
- Il diritto di chiedere spiegazioni sulle regole degli adulti, senza accettarle ciecamente
Gli adolescenti sanno che ci sono dei limiti alla loro libertà, fissati dalla società adulta. Questi paletti influenzano il loro comportamento, la loro esperienza a scuola, il loro lavoro (per chi lavora). La domanda che faranno inizialmente quando dovranno confrontarsi con queste limitazioni sarà: “Ma che male c’è?”. Poi con il tempo (quasi sempre) la regola smetterà di essere una restrizione e diventerà ok.
- Il diritto di divertirsi e di stare in gruppo
Gli adolescenti vogliono una vita ricca di esperienze. Cercano compagnia, svago; vogliono giocare, ballare, leggere, fare nuove amicizie. Quando la comunità non soddisfa questi bisogni, cercano di farlo da soli. Vale per i genitori come per il quartiere, o la città: se gli adulti non apprezzano che ragazze e ragazzi passino il tempo in locali seminterrati o bar per incontrarsi lontano da loro, hanno la responsabilità di offrirgli alternative, come i centri comunitari. Il coinvolgimento dei giovani dipende da quello che gli offre la società.
- Il diritto di mettere in dubbio
Opinioni e comportamenti non sono corretti solo perché vengono dagli adulti. Per gli adolescenti non ci sono questioni chiuse: hanno il diritto di fare domande e avere risposte, e di discutere a fondo sulle cose. Hanno passato la fase acuta dei perché, gli interessa il come, e hanno un approccio critico, dando pochissimo per scontato. Raramente i genitori si rendono conto che i figli ragionano con gli amici di politica, sesso, religione o rapporti tra le diverse comunità con la stessa frequenza con cui parlano del loro cantante preferito o di una partita di baseball. Escluderli dalla discussione li spingerà naturalmente a concludere che gli adulti non sentono il problema, o evitano di affrontarlo.
- Il diritto a un’età romantica
Per gli adolescenti l’amore è una cosa seria, e ci restano male se qualcuno sminuisce i loro affetti. Quando una ragazza o un ragazzo s’innamora, lo fa senza riserve. Va riconosciuto il valore di questo sentimento.
- Il diritto ad avere un’opportunità
I giovani chiedono delle occasioni, a scuola come nei percorsi professionali, e vogliono competere in modo leale per ottenerle, senza distinzione di genere, etnia o religione. Se queste opportunità gli sono negate, la frustrazione è grande, e a volte diventa esplosiva.
- Il diritto all’aiuto di professionisti, ogni volta che serve
L’adolescente cambia fisicamente e psicologicamente, in tempi molto rapidi. Quando qualcosa interferisce con la sua crescita, la sua personalità che si sta adattando o la sua salute, dovrebbe poter contare sul sostegno di professionisti. Può arrivarci accompagnata o accompagnato dai genitori o attraverso servizi della comunità.
- Il diritto di cercare e costruire la propria visione del mondo
Per ragazzi e ragazze niente è più importante di trovare il proprio posto nel mondo. È una ricerca seria, spesso dolorosa. Rispetto a questo, per un genitore è sempre meglio essere flessibile che dogmatico. Madri e padri saggi capiscono che “diritti” e “bisogni” dei figli sono sinonimi e hanno imparato l’arte di lasciare che i figli si mettano da soli alla prova.
Sono spunti abbastanza all’avanguardia se pensate che solo in quegli anni si cominciava a considerare l’adolescenza un’età autonoma. Prima non c’era neanche un termine condiviso per indicarla. Ora, con la crescita economica del dopoguerra e nuove regole sul lavoro minorile e l’istruzione obbligatoria, nel mondo occidentale una massa di quattordicenni si ritrovava alle superiori (negli Stati Uniti si passò in pochi anni dal dieci al sessanta per cento di diplomati).
Quelle ragazze e quei ragazzi hanno alimentato un nuovo immaginario, trasformato culture, attirato le aziende. Hanno obbligato il mondo della tecnologia e quello della psicologia a stare al loro passo. Anche gli insegnanti hanno provato a cambiare. Come fanno capire gli studenti di Lettera alla scuola, bisogna lavorarci su.
Questo testo è tratto dalla newsletter Doposcuola.
|
Iscriviti a Doposcuola |
La newsletter su scuola, università e ricerca. A cura di Anna Franchin. Ogni due settimane, il sabato.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Doposcuola
|
|
La newsletter su scuola, università e ricerca. A cura di Anna Franchin. Ogni due settimane, il sabato.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it