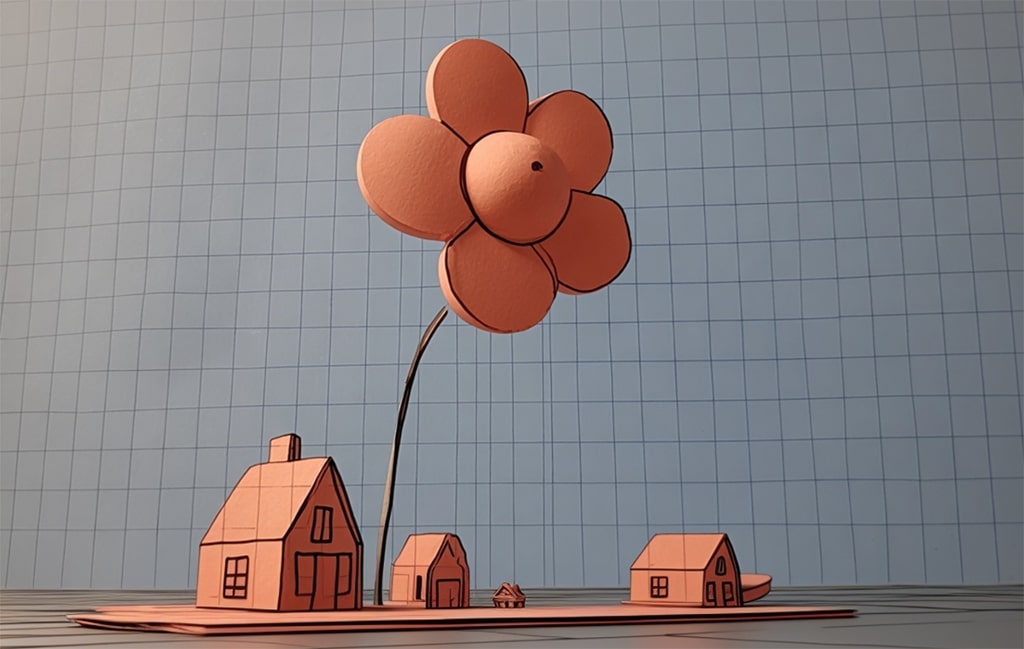“Mi puoi spiegare cos’è Meta Ai?”. È la domanda che mi ha fatto Ilaria al festival di Ferrara, all’incontro Le intelligenze che non ti aspetti. Eravamo nella sezione Fuoriclasse, quella dedicata al pubblico più giovane e, come spesso accade, le domande dei più giovani sono interessanti e sensate, persino quando sono così semplici.
Mentre il dibattito accademico si occupa di questioni che non riguardano quasi mai le persone comuni, mentre cerchiamo di usare le intelligenze artificiali generative per lavoro, di capire se possono essere un aiuto o un problema per le democrazie, se possiamo usarle per semplificare il linguaggio o per liberare il nostro tempo, Ilaria, con la sua domanda, ci costringe a essere un po’ più pragmatici.
Ad aprile 2025 l’azienda, la Meta – casa madre di Facebook, Instagram e Whatsapp – ha introdotto Meta Ai dentro WhatsApp. È la prima cosa che si vede quando si apre l’app, visto che nella barra in alto c’è scritto: “Chiedi a Meta Ai o cerca”.
Ad agosto del 2025, la Meta ha dichiarato che più di tre miliardi di persone nel mondo usano WhatsApp, il suo sistema di messaggistica. Tre anni fa, si stimava che in Italia ci fossero 37 milioni di persone registrate su WhatsApp. Probabilmente oggi sono ancora di più.
Questo significa che in Italia così come nel resto del mondo occidentale un numero impressionante di persone si è trovato un oggetto non meglio identificato, un qualcosa a cui fare domande, dentro uno strumento di uso quotidiano. Senza averlo chiesto e, in moltissimi casi, senza sapere esattamente di cosa si tratti.
La risposta semplice alla domanda di Ilaria è questa: Meta Ai è una macchina capace di usare il linguaggio umano e di rispondere a quel che chiedi.
Ma non possiamo limitarci a questo, ovviamente. Meta Ai è il nome dell’assistente virtuale che troviamo su WhatsApp, su Instagram, Messenger. È un chatbot che usa Llama, il modello di intelligenza artificiale generativa della Meta. È in grado di rispondere in varie lingue alle nostre domande. Lo fa in maniera plausibile, ma non necessariamente veritiera o corretta. Meta Ai è stata programmata dalla divisione omonima della Meta che si occupa di intelligenze artificiali.
L’assistente Meta Ai può dare informazioni di attualità citando alcune fonti o creare un piano anti-procrastinazione; può aiutare a imparare una lingua o farti domande di matematica, di chimica, di antropologia o sociologia. È molto simile a ChatGpt, Gemini e Claude. Solo che, appunto, lo trovi installato dentro a un’applicazione che usi per altri motivi.
“È un servizio opzionale”, si legge nell’avvertenza che precede ogni chat che facciamo con la Meta Ai. Ed è vero, nel senso che siamo noi a decidere se usarla o meno. Ma non nel senso che possiamo disattivarla. Così come nessuno di noi ha chiesto di avere Meta Ai dentro il proprio WhatsApp, nessuno di noi può disinstallarla: l’opzione, semplicemente, non è stata prevista dagli sviluppatori. Si può, al massimo, cancellare la chat. Sappiamo che a breve la Meta userà le chat che facciamo con Meta Ai per farci vedere pubblicità personalizzata, ma non abbiamo alcun tipo di controllo sul modo in cui questo accadrà.
Una macchina non è una persona
L’azienda precisa che “Meta Ai non può leggere gli altri messaggi nelle chat personali”, perché sono “crittografati end-to-end”. Poi raccomanda di “non condividere informazioni su di te o su altre persone che non vuoi che l’ia conservi e utilizzi” e ci informa che “condivide le informazioni con partner selezionati” per offrire risposte pertinenti.
Infine, la Meta ci garantisce che non userà le nostre interazioni con la macchina per migliorarla e ci ricorda che la macchina può sbagliare e che “alcuni messaggi potrebbero essere inesatti o inappropriati”.
Quante questioni emergono dalla domanda di Ilaria? Tantissime: ci sono di mezzo la nostra consapevolezza nell’uso della tecnologia, il modo in cui la subiamo o la padroneggiamo, l’oligopolio ristretto delle grandi aziende, la privacy, la sicurezza informatica, le nostre competenze digitali, la necessità di diffondere consapevolezza su una tecnologia pervasiva, che troviamo installata su uno strumento di massa senza grandi spiegazioni.
Nessuno ci sta insegnando a fare le domande alle macchine nel modo più efficace e utile: per lo più prevalgono divieti, paure o l’esaltazione delle capacità di questi strumenti. Eppure è proprio da qui che dobbiamo partire.
Imparare a fare le domande giuste significa, prima di tutto, capire a chi o a cosa stiamo parlando. Una macchina non è una persona: non ha coscienza, non ha esperienze così come le intendiamo noi, non ha opinioni anche se afferma di averne. Però è stata costruita, addestrata, migliorata da persone in carne e ossa, con valori, obiettivi, idee. Per questo non basta chiedere che cos’è un’assistente virtuale. Dobbiamo imparare a chiederci: chi l’ha progettato? A che scopo? Con quali dati? Quali limiti gli sono stati imposti, e da chi? E soprattutto: che impatto ha su di me, sulla mia libertà di informarmi, di decidere, di sbagliare?
Una volta che ci siamo posti questi problemi, è il momento di imparare a chiedere correttamente: di citare le fonti, per esempio. Di confutare o confermare un’idea senza adularci. E poi è il momento di ricordare che le risposte della macchina richiedono uno sforzo da parte nostra perché non sono risposte oracolari.
A scuola non sempre si insegna a fare questo tipo di domande. È difficile che se ne parli in famiglia. La politica ci arriva in ritardo, quando ci arriva, e spesso pensa solo a vietare. E così, mentre ci distraiamo a discutere se le ia scriveranno poesie migliori delle nostre, le aziende che le producono le infilano ovunque: dentro un motore di ricerca, dentro un sito di e-commerce, dentro l’assistente vocale che ci suggerisce una playlist per la sera. L’inavvertibilità sociale di questi strumenti, se non la gestiamo bene, potrebbe essere un problema che cancella tutte le opportunità che raccontiamo spesso su Artificiale.
Quella di Ilaria, alla fine, non è solo una domanda giusta. È la domanda più politica di tutte.
Questo testo è tratto dalla newsletter Artificiale.
|
Iscriviti a Artificiale |
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Artificiale
|
|
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it