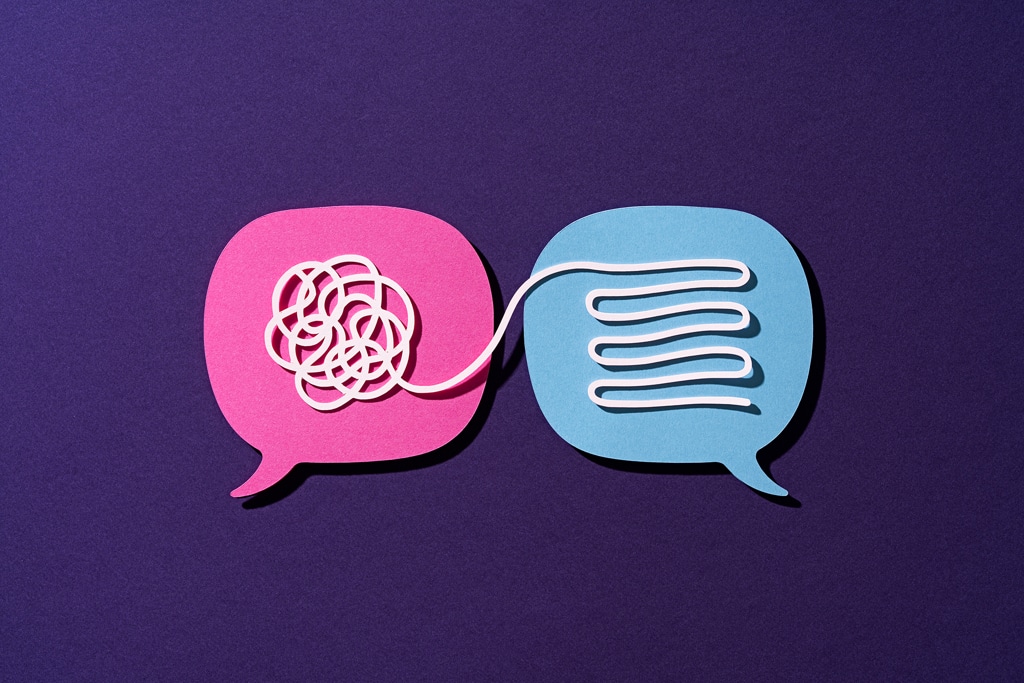“Agennaio partiamo”, si sente ripetere nel nord dell’Honduras, la zona più colpita dagli uragani Eta e Iota nelle ultime settimane. Alla violenza, alla povertà e all’inefficienza dello stato si è aggiunta la devastazione: case, campi e fabbriche allagate. Quando l’acqua scenderà, molte famiglie sfollate non avranno un posto dove tornare. Finora le ragioni principali per cercare di raggiungere gli Stati Uniti erano due: la violenza e la povertà. Nei prossimi mesi molte famiglie che abbiamo incontrato, arrampicate sui tetti delle loro case come su piccole isole in mezzo alla catastrofe, prenderanno la strada verso nord.
Da anni gli ambientalisti sottolineano il rischio di una nuova ondata di migrazioni dovuta ai cambiamenti climatici. Dall’inizio del 2020 in America Centrale ci sono stati quattro uragani e più di trenta tempeste tropicali: un record per la regione. Mentre si pensa alla ricostruzione, che sarà ostacolata dalle istituzioni deboli e dalla corruzione, migliaia di persone potrebbero partire. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrà assicurare che i migranti centroamericani nel suo paese non siano abbandonati a se stessi.
Jimmy Girón, un honduregno di 25 anni, vuole andarsene. Vive a Chamelecón, un quartiere di San Pedro Sula dominato dalle gang criminali. Non è più rientrato nella sua casa da quando l’uragano Eta ha colpito l’Honduras, all’inizio di novembre. A Chamelecón, come in molte altre zone dell’America Centrale, migrare è un rituale che si tramanda di padre in figlio. Il padre di Jimmy ha provato tante volte a raggiungere gli Stati Uniti da aver perso il conto.
In Honduras i due uragani hanno provocato almeno 91 morti (125 secondo l’esercito) e hanno colpito quasi due milioni e mezzo di persone. La situazione è simile in tutta la regione: Iota ed Eta hanno danneggiato ampie zone del Nicaragua, del Guatemala e del sud del Messico. L’Honduras chiuderà il 2020 con una perdita di 10 miliardi di dollari, l’equivalente del 50 per cento del pil del paese, a causa della pandemia e delle catastrofi naturali.
Il primo passo
Nel 1998 l’uragano Mitch provocò solo in Honduras settemila morti, ottomila persone scomparse e danni per 4,7 milioni di persone; distrusse 189 ponti, 8.600 chilometri di strade e il 70 per cento delle coltivazioni agricole, secondo la Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi. Dopo l’uragano Mitch, l’amministrazione statunitense del presidente Bill Clinton inserì l’Honduras e il Nicaragua nello status di protezione temporanea (Tps), un meccanismo legale creato nel 1990 per tutelare le persone dei paesi colpiti da conflitti armati e catastrofi naturali. Nel 2001, con George W. Bush alla Casa Bianca, si aggiunse El Salvador, colpito da due violenti terremoti.
Con quella protezione, i centroamericani riuscivano a ottenere un permesso di lavoro, a viaggiare all’estero e a non essere espulsi dagli Stati Uniti. È stato Trump a sospendere questo meccanismo, affermando che le condizioni dell’America Centrale erano migliorate. Ma era una menzogna. Biden dovrà affrontare l’aumento prevedibile della migrazione a causa delle catastrofi naturali. Il nuovo presidente fa dei bei discorsi, ma il suo passato non promette bene: è stato vicepresidente di Barack Obama nell’amministrazione che più di tutte ha espulso gli stranieri.
Mentre si discute della protezione per le vittime della crisi climatica si possono prendere decisioni in grado di salvare delle vite. Biden deve inserire i paesi centroamericani nel Tps. In previsione dell’arrivo di migranti e richiedenti asilo a cui gli uragani hanno tolto tutto, bisogna sospendere il Protocollo di protezione dei migranti, che li obbliga ad aspettare in Messico fino a che un giudice si pronuncia sul loro caso. Garantire l’accoglienza negli Stati Uniti alle vittime degli uragani è il primo passo per dimostrare che le politiche disumane di Trump fanno parte del passato. ◆ fr
Jennifer Ávila è direttrice del sito honduregno Contracorriente.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1389 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati