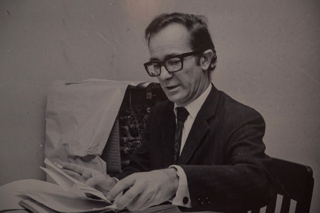Il negoziato indiretto che si apre il 6 ottobre a Sharm El-Sheik, in Egitto, presenta un vantaggio innegabile nonostante la sua enorme difficoltà: i partecipanti, sia israeliani sia palestinesi, non intendono essere considerati responsabili di un eventuale fallimento. Il motivo è evidente: nessuno vuole incorrere nella collera di Donald Trump, che si è personalmente impegnato nella trattativa e vuole farsi un’immagine di artefice della pace.
Questo fattore, psicologico molto più che politico, potrebbe permettere di raggiungere almeno un accordo sulla prima fase del piano Trump, che prevede un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani (vivi e morti) e dei prigionieri palestinesi chiusi nelle carceri israeliane. L’opinione pubblica su entrambi i fronti lo spera.
Naturalmente prudenza è d’obbligo, ma resta il fatto che questo primo risultato appare a portata di mano e sarebbe già un grandissimo successo per il presidente statunitense. Il seguito, invece, sarà più complicato perché riguarda la parte politica del piano, che presenta numerosi difetti e incoerenze.
È essenziale contestualizzare la trattativa. La situazione è cambiata all’improvviso il mese scorso, quando Benjamin Netanyahu ha ordinato il bombardamento di alcuni leader di Hamas a Doha, in Qatar. È stato un azzardo di troppo di Tel Aviv.
Aggredire il Qatar, che ospita la più grande base militare statunitense della regione (visitata all’inizio dell’anno da Trump), ha significato infatti alterare un equilibrio estremamente fragile. Per di più l’emirato ha avuto un ruolo decisivo nel negoziato con Hamas. Gli stati del golfo – compresi gli Emirati Arabi Uniti, che hanno rapporti diplomatici con Israele – l’hanno presa male, e hanno manifestato la loro rabbia all’amico e partner d’affari Donald Trump.
Per questo motivo la settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti ha costretto Netanyahu a telefonare all’emiro del Qatar e a chiedere scusa per il raid israeliano. Trump inoltre si è fatto garante della sicurezza del paese arabo, un gesto senza precedenti che mostra quanto sia importante per Washington la relazione con Doha. Davanti a questo cambio di atteggiamento degli Stati Uniti, Netanyahu ha dovuto piegarsi alla volontà di Trump.
Aspettando un errore
Anche Hamas avverte la pressione, prima di tutto del Qatar (suo principale interlocutore nel mondo arabo) e della Turchia di Erdoğan, che si preoccupa molto del suo rapporto con Trump. L’organizzazione palestinese non poteva permettersi di rifiutare in blocco il piano statunitense, soprattutto dopo che Trump ha dichiarato pubblicamente di essere pronto a sostenere Israele nella sua guerra a oltranza se Hamas respinge la sua proposta.
Tutto questo però non vale per il seguito del negoziato. Le due parti fanno passi indietro invece di avanzare. Hamas non vuole disarmarsi e ancor meno uscire di scena, mentre l’alleanza di Netanyahu con l’estrema destra rischierebbe di implodere se il piano di Trump dovesse impedire la distruzione totale di Gaza.
Non siamo ancora a questo punto. Per ora i due schieramenti faranno il possibile per non farsi rimproverare, nella speranza che l’avversario commetta un errore. Se questo permetterà la liberazione degli ostaggi e la fine del calvario per due milioni di civili a Gaza, il mondo non potrà far altro che rallegrarsi. Anche se è difficile essere ottimisti sul futuro: un cessate il fuoco non significherebbe la pace.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it