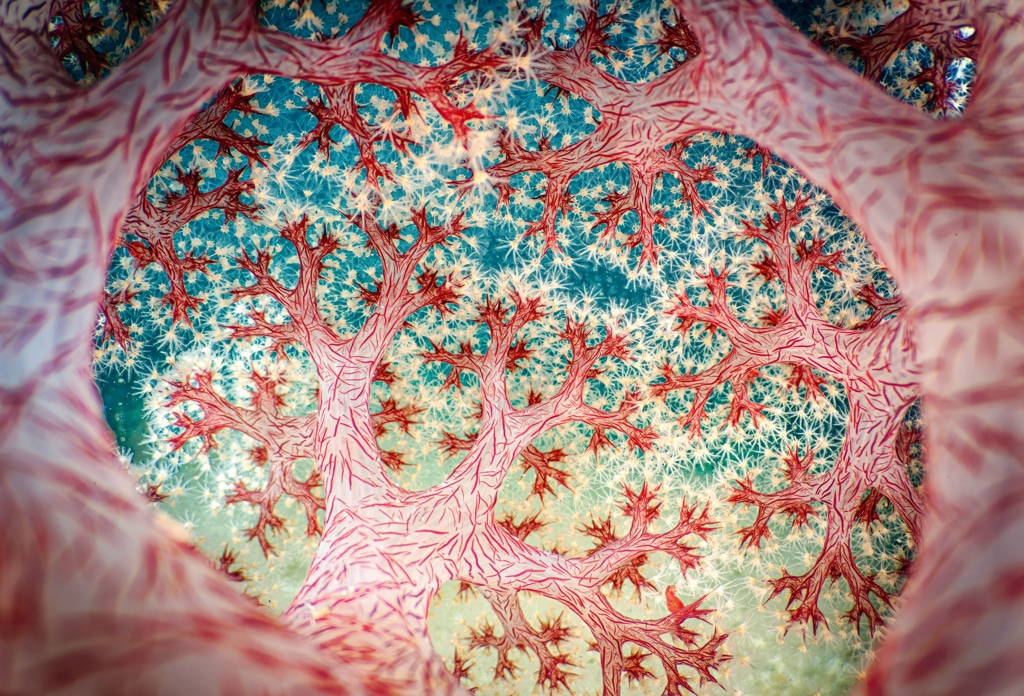A fine agosto Trump ha dato un’intervista al sito di destra Daily Caller in cui, parlando della guerra di Israele nella Striscia di Gaza e del governo Netanyahu, ha detto: “Avevano il controllo totale sul congresso, e ora non ce l’hanno più. Dovranno mettere fine a quella guerra. Magari stanno anche vincendo la guerra, ma non stanno vincendo sul fronte delle pubbliche relazioni, e questo li sta danneggiando”.
Per il presidente americano, si sa, la percezione della realtà è più importante della realtà stessa – una lezione imparata ai tempi in cui era un immobiliarista sull’orlo della rovina e poi trasferita alla politica – e quando parla di Gaza non pensa solo alla popolarità di Netanyahu ma anche e soprattutto alla sua, e alle conseguenze di un conflitto prolungato sull’opinione pubblica statunitense.
La sua determinazione nell’imporre un accordo su Gaza si spiega anche con la necessità di portare a casa una vittoria in un momento in cui l’orientamento della società statunitense sulla guerra e su Israele sembra cambiare. Di recente vari giornali hanno pubblicato analisi che descrivono un fastidio crescente nei confronti dello storico alleato, anche in settori che hanno sempre garantito un sostegno granitico. Imporsi come l’uomo che “porta la pace” – o almeno che chiude una guerra impopolare – consente a Trump di presentarsi agli elettori come il leader capace di proteggere gli interessi americani prima di quelli di Israele.
Alcuni sondaggi riportati da Politico mostrano un spostamento rilevante: più della metà degli americani – il 53 per cento – ha un’opinione negativa di Israele, e solo il 32 per cento dichiara di avere fiducia nel primo ministro Benjamin Netanyahu. Tra i democratici la distanza è particolarmente netta, con il 69 per cento che esprime un giudizio negativo, ma anche tra i repubblicani cominciano a vedersi delle crepe, in particolare tra gli elettori più giovani: tra i conservatori che hanno meno di cinquant’anni le opinioni negative su Israele sono passate dal 35 al 50 per cento in soli tre anni.
Questa dinamica si è accentuata con l’aggravarsi della guerra, che ha provocato decine di migliaia di morti palestinesi e una crisi umanitaria senza precedenti. Dopo la solidarietà iniziale seguita all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, l’opinione pubblica americana si è gradualmente raffreddata, e ha cominciato a percepire l’azione israeliana come un conflitto moralmente insostenibile e politicamente inutile. Le proteste universitarie contro la guerra, inizialmente confinate nei campus progressisti, si sono estese a una fascia più ampia della società e hanno toccato anche molti giovani conservatori, convinti che il conflitto danneggi gli interessi nazionali.
E mentre negli Stati Uniti cresce la diffidenza tra le nuove generazioni, in Israele i giovani si spostano su posizioni nazionaliste e fondamentaliste, in cui non c’è spazio per nessun compromesso con i palestinesi. È una generazione, spiega Politico, segnata dal trauma del terrorismo e dalla fine delle illusioni legate agli accordi di Oslo, che guarda con sospetto sia ai palestinesi sia alle pressioni statunitensi. “Questa è una dinamica che non cambierà la politica statunitense nel breve periodo, ma creerà maggiori tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Israele negli anni a venire”.
Movimenti rilevanti si registrano anche tra gli ebrei americani. Secondo un sondaggio del Washington Post, molti di loro disapprovano con forza il comportamento dell’alleato nella guerra a Gaza: il 61 per cento pensa che Israele abbia commesso crimini di guerra e circa 4 persone su 10 ritengono che il paese sia colpevole di genocidio nei confronti dei palestinesi. Molte delle persone che sono state intervistate più volte nel tempo hanno detto di aver inizialmente sostenuto l’incursione militare di Israele, data la brutalità dell’attacco di Hamas e la necessità di rispondere. Ma mentre la guerra andava avanti, con pochissimi progressi concreti e le notizie delle atrocità che si accumulavano, hanno cominciato a disapprovare la condotta di Israele.
Gli ebrei americani sono particolarmente scontenti dell’attuale governo israeliano. Il 68 per cento esprime un giudizio negativo sulla leadership di Netanyahu, un aumento del 20 per cento rispetto a un sondaggio del Pew research center di cinque anni fa.
Per il Washington Post questi dati sono sorprendenti, perché potrebbero suggerire la possibilità di una rottura, impensabile fino a poco tempo fa, tra la comunità ebraica statunitense e Israele; ma il giornale aggiunge che gli ebrei americani mantengono forti legami emotivi, culturali e politici con Israele e la sua identità di stato ebraico. Circa tre quarti degli ebrei americani, il 76 per cento, pensa che l’esistenza di Israele sia vitale per il futuro del popolo ebraico, e il 58 per cento afferma di avere qualcosa o molto in comune con gli ebrei israeliani.
Questa apparente contraddizione si chiarisce ripercorrendo il rapporto degli ebrei americani con il sionismo, il movimento nato per creare uno stato ebraico nella Palestina storica.
Bisogna partire dalla metà dell’ottocento, quando le prime ondate migratorie dall’Europa, principalmente da territori di lingua tedesca, fecero nascere negli Stati Uniti una comunità ebraica riformista, che metteva l’accento sull’adattamento dei princìpi dell’ebraismo alla vita moderna e dava la priorità all’assimilazione nella società statunitense. “In questa visione”, ha spiegato lo storico Mark Mazower in un saggio uscito sul Guardian, “il sionismo politico era guardato con sospetto, perché si temeva che la creazione di uno stato ebraico potesse compromettere gli sforzi degli ebrei per l’integrazione, gettando un’ombra sulla loro lealtà alla società statunitense”.
Questa posizione fu espressa in modo ufficiale in una risoluzione del movimento riformista americano nel 1898, che si dichiarava “irrimediabilmente contrario al sionismo politico” sulla base del fatto che “gli ebrei non sono una nazione ma una comunità religiosa”. Nel 1906 nacque l’American jewish committee (Ajc), fondato da un gruppo di ebrei americani di origine centroeuropea, ricchi, istruiti e ben integrati nella società, e che per molti anni è stata la più influente organizzazione ebraica degli Stati Uniti.
Durante gli anni trenta l’Ajc ribadì la linea, opponendosi alla creazione di un organismo ebraico internazionale che suggerisse un’appartenenza sovranazionale. Per il suo presidente, Joseph Proskauer, la propaganda sionista rischiava di essere “una catastrofe per gli ebrei americani”, perché alimentava il sospetto della “doppia lealtà”. L’emancipazione e l’integrazione degli ebrei nella democrazia americana restavano gli obiettivi principali.
La Shoah e la seconda guerra mondiale cambiarono radicalmente il quadro. Nel 1942 diversi gruppi ebraici si riunirono per chiedere la creazione di una “comunità ebraica” in Palestina, superando le resistenze dell’Ajc e dell’American council for judaism, altra organizzazione ebraica antisionista. Con la fondazione dello stato di Israele nel 1948, il sionismo diventò la nuova ortodossia e l’antisionismo politico si ridusse a una voce marginale.
Ma c’erano ancora figure influenti che andavano contro corrente. Come William Zukerman, giornalista ebreo americano che denunciava il “nazionalismo messianico” che a suo giudizio stava trasformando Israele in una nazione etnocentrica, indifferente ai profughi palestinesi e pericolosa per la diaspora. Zukerman fu ostracizzato e accusato di antisemitismo: un segnale precoce del fatto che le critiche a Israele stavano diventando tabù nella comunità ebraica americana.
Fino agli anni sessanta la visione che gli ebrei americani avevano di Israele continuò a essere segnata da una certa cautela
Negli anni cinquanta le relazioni tra Israele e gli ebrei americani furono tese. Il primo ministro David Ben Gurion pensava che l’emigrazione degli ebrei di tutto il mondo verso lo stato ebraico fosse un dovere morale e politico. Spinto dal timore che Israele non avesse una popolazione abbastanza numerosa, vedeva negli Stati Uniti un bacino indispensabile di “materiale umano superiore”, preferibile sotto molti aspetti ai profughi logorati e traumatizzati provenienti dall’Europa devastata dalla guerra. Jacob Blaustein, leader dell’Ajc, reagì indignato, dicendo che ebrei americani non erano “in esilio” ma cittadini degli Stati Uniti a tutti gli effetti. Nel 1950 i due si incontrarono e arrivarono a un compromesso: Blaustein accettò di sostenere Israele “nell’ambito della cittadinanza americana”, mentre Ben-Gurion, pur promettendo che non avrebbe più parlato di emigrazione degli ebrei americani, continuò a farlo.
La frattura riaffiorò nel 1952, quando il parlamento israeliano approvò una legge che dichiarava lo stato di Israele “una creazione dell’intero popolo ebraico”. L’Ajc protestò, chiedendo di cambiare la formulazione, ma fu ignorato. Israele si arrogava così un ruolo di rappresentanza globale degli ebrei, alimentando il timore che gli americani fossero accusati di fedeltà a una potenza straniera.
Fino agli anni sessanta la visione che gli ebrei americani avevano di Israele continuò a essere segnata da una certa cautela. Nel 1959 il sociologo Ben Halpern notò che, pur mostrando simpatia per Israele, pochi ebrei sentivano il proprio destino legato a quello dello stato ebraico. L’assimilazione e la paura della doppia lealtà continuavano a essere un freno.
Il punto di svolta arrivò con la guerra dei sei giorni del 1967. La vittoria rapida e spettacolare di Israele contro gli eserciti arabi suscitò un’ondata di orgoglio e identificazione tra gli ebrei americani. Il timore che Israele potesse essere distrutto aveva riaperto la ferita dell’Olocausto; ma, con la fine della guerra, quella paura si trasformò in sollievo e in una rinnovata consapevolezza del destino comune del popolo ebraico.
In quei giorni il sociologo Marshall Sklare condusse una ricerca nella comunità ebraica del midwest (che chiamò “Lakeville”), notando che molte persone avevano vissuto la guerra come un evento esistenziale, senza percepire conflitti tra il patriottismo americano e la solidarietà con Israele. Non avevano mai visitato il paese, ma sentirono di aver “partecipato alla vittoria” attraverso le donazioni e l’attivismo. Per Sklare il sostegno a Israele rispondeva a un bisogno psicologico: dare un senso positivo alla sopravvivenza dopo la Shoah. Israele divenne simbolo di rinascita e garanzia contro il ripetersi della tragedia.
Dopo il 1967 la relazione si trasformò definitivamente. L’Ajc mise da parte il suo antisionismo, superando le preoccupazioni a proposito dell’assimilazione. Il sostegno a Israele divenne un dovere identitario e politico, radicato nella memoria dell’Olocausto e nella convinzione che la sopravvivenza del popolo ebraico dipendesse dallo stato ebraico.
L’ebraismo americano, un tempo pluralista e secolarizzato, fu così “sionizzato”: la lealtà verso Israele divenne una componente naturale dell’identità ebraica negli Stati Uniti. La discussione critica lasciò progressivamente posto al consenso e all’idea che “stare con Israele” fosse parte integrante dell’essere ebreo.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it