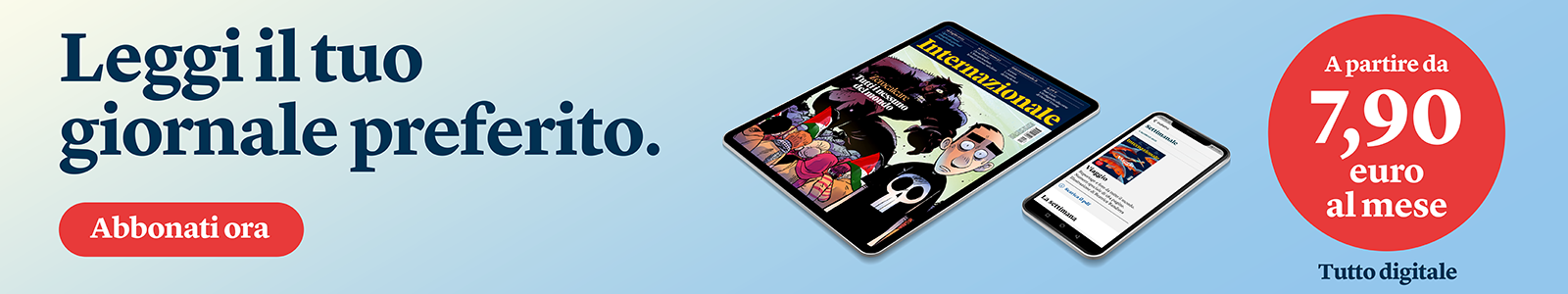Il 15 settembre, come ogni giorno da quando l’esercito israeliano ha lanciato la sua offensiva sulla città di Gaza, capitale del territorio palestinese, un’ordine di evacuazione è stato trasmesso agli abitanti di un edificio. In questo caso si trattava del più alto palazzo residenziale di Gaza, la torre Al-Ghafri, distrutta poche ore dopo. I filmati della torre che crolla sotto i colpi degli esplosivi mentre gli abitanti fuggono in preda al panico tentando di portare in salvo i loro pochi averi e la vita hanno fatto il giro del mondo.
L’esercito israeliano giustifica ogni distruzione di edifici sostenendo che Hamas li usava come centri operativi o posti di osservazione, ma non fornisce mai prove. E bisogna ricordare che ai giornalisti della stampa internazionale è proibito entrare nella Striscia di Gaza ormai da due anni, mentre i giornalisti palestinesi uccisi sono più di duecento.
Così torna a essere usato un termine che merita una spiegazione: urbicidio, letteralmente “uccisione di una città”, un neologismo creato a partire dalle radici latine di “città” e “uccidere”. Il termine non figura nei testi di diritto internazionale, a differenza di genocidio, apparso in occasione del processo di Norimberga alla fine della seconda guerra mondiale. Ma ha una storia e un significato.
Fece la sua prima comparsa nel 1963 grazie alla penna di un autore di fantascienza britannico, Michael Moorcock. Il suo uso politico, invece, si deve all’ex sindaco di Belgrado Bogdan Bogdanović, un oppositore del regime di Slobodan Milošević nella ex Jugoslavia.
Bogdanović aveva parlato di urbicidio per descrivere le battaglie dell’esercito serbo a Sarajevo, a Mostar e a Vukovar negli anni novanta. Durante il lungo assedio di Sarajevo, in particolare, le forze serbe bombardarono la capitale bosniaca dalle vette circostanti, uccidendo gli abitanti ma anche la città stessa, sprofondata nel terrore e nella privazione. Allo stesso modo, si sarebbe potuto parlare di urbicidio per descrivere Phnom Penh durante il regno dei Khmer rossi, che avevano svuotato la capitale cambogiana dei suoi abitanti; o per raccontare battaglie urbane ad Aleppo e a Homs durante la guerra civile siriana.
Pulizia etnica
A Gaza, però, il termine assume un senso più letterale e spaventoso, perché qui la distruzione è sistematica, studiata e voluta, non certo il prodotto di battaglie o danni collaterali. Senza ammetterlo, Israele rende la vita impossibile nella Striscia di Gaza, città dopo città e distruggendo palazzi, scuole, ospedali e infrastrutture.
L’esercito israeliano sta spingendo le popolazioni delle zone distrutte verso il sud del territorio, oggi drammaticamente sovrappopolato e in condizioni umanitarie terrificanti. Che succederà dopo? Il governo di Tel Aviv ha parlato a più riprese di un trasferimento (ufficialmente volontario) dei palestinesi verso destinazioni ancora introvabili. Si è parlato del Sud Sudan e del Somaliland, ma il vicino Egitto teme di essere il prescelto e non è disposto ad accettarlo.
Il corollario dell’urbicidio è la pulizia etnica. Israele si assume il rischio di essere accusato di violazioni gravi del diritto internazionale, perché anche se l’urbicidio non fa parte dei testi giuridici, distruggere infrastrutture civili e procedere a una pulizia etnica sono azioni che costituiscono crimini di guerra.
Ufficialmente l’obiettivo di Israele è ancora di distruggere Hamas, l’organizzazione che ha pianificato gli attentati del 7 ottobre 2023 in Israele. Tuttavia i bombardamenti contro le infrastrutture civili trasformano questa guerra, che presto compirà due anni, in una punizione collettiva che isola sempre di più Israele, nonostante il sostegno degli Stati Uniti ribadito il 15 settembre dal segretario di stato statunitense Marco Rubio. L’urbicidio, dunque, può proseguire senza ostacoli.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
|
Iscriviti a Mediorientale |
Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Mediorientale
|
|
Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it