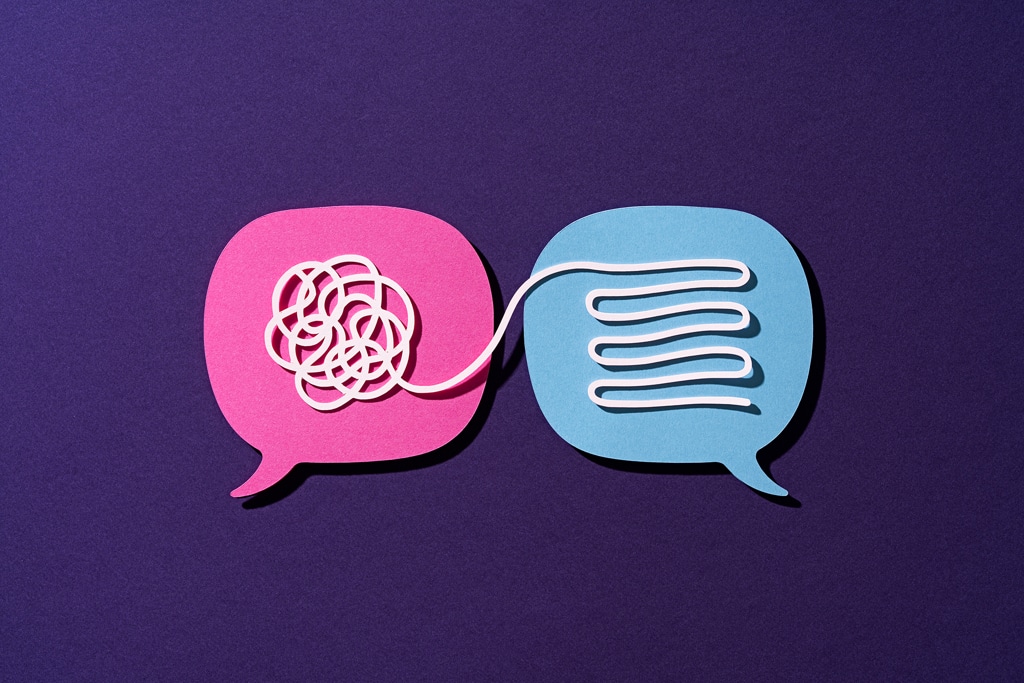Il 26 ottobre 2025 Le Monde ha pubblicato un articolo che si intitola “L’ia au bureau, entre perte de temps et perte de sens” (L’intelligenza artificiale in ufficio: tra perdita di tempo e perdita di senso). Me l’ha segnalato Alessandro, un lettore di Artificiale, che nella sua email dice: “L’ho trovato interessante perché smonta l’epica delle ia e pone alcuni problemi reali: il primo è che molti capi, che non hanno capito nulla, pensano che tutti i problemi possano essere risolti con le ia; il secondo è che non si è ancora capito come usarla”.
“Lavoro in un’azienda tecnologica”, prosegue Alessandro, “e uso quotidianamente le ia. Per scrivere codice sono fantastiche, soprattutto se hai le idee chiare. Per tutto il resto (riassunti di call, documenti, spiegazioni tecniche) non è che dia grandi soddisfazioni né davvero aiuta a essere più produttivi. Un altro segnale che la bolla degli llm si sta sgonfiando? O che bisogna puntare su ia più specializzate?”.
L’email e l’articolo di Le Monde toccano un tema interessante: le intelligenze artificiali generative vengono spesso raccontate come moltiplicatori di produttività, ma nella pratica quotidiana molte persone si accorgono che non fanno risparmiare tempo, anzi lo risucchiano.
C’è un’idea che, in effetti, accompagna ogni innovazione tecnologica: la promessa di liberare tempo. Come ha raccontato la sociologa Judy Wajcman nel saggio La tirannia del tempo: l’accelerazione della vita nel capitalismo digitale (Treccani 2020), spesso è successo l’esatto contrario: le nuove tecnologie hanno accelerato la vita, compresso le pause, colonizzato il tempo libero, alzato le aspettative. Non hanno prodotto soltanto libertà ma anche urgenza.
Wajcman, però, aggiunge un punto ancora più scomodo a questa analisi: l’accelerazione, la pressione e l’urgenza non sono neutrali. Colpiscono in modo disuguale. Chi ha potere, capitale e controllo può usare la tecnologia per stare meglio; chi non li ha, la subisce attraverso la precarietà, la sorveglianza, il controllo o la pressione costante a fare sempre di più con meno.
Richieste continue
La storia che racconta Le Monde è abbastanza comune: nelle aziende, spesso, le ia non stanno semplificando la vita di chi lavora, ma creando nuovi microcompiti. Si perde tempo in prompt, correzioni, test e revisioni. Invece di liberare il tempo delle persone si moltiplicano gli adempimenti e il carico mentale.
E questo carico, ancora una volta, non è distribuito in modo equo. Le tecnologie di incremento della produttività pesano maggiormente su chi è più controllato, non su chi controlla. Le richieste di produttività continua visto che tanto ci sono le ia generative, ricadono ancora sui precari, sui sottoposti e su chi ha un lavoro retribuito e uno, invisibile e non retribuito, di cura (spesso sono le donne).
L’innovazione, senza una cornice sociale, replica e amplifica le disuguaglianze. Questo perché le tecnologie non possono essere neutre in un ambiente estrattivo: interagiscono con potere, classe, genere, provenienza geografica, accesso alle risorse. Per questo sono strumenti intersezionali: producono effetti diversi a seconda delle posizioni sociali, economiche e culturali di chi le usa o le subisce.
Da questo punto di vista, allora, il problema è prima di tutto di competenze e di orientamento. Poi politico.
L’enorme entusiasmo che ha accompagnato l’introduzione di questi strumenti ha generato gli stessi errori che abbiamo già visto commessi con la cosiddetta rivoluzione digitale: accecati dalla promessa di produttività maggiore, si rifiuta un percorso più logico, fatto di prove, errori e miglioramenti. Si rifiuta di rallentare prima per liberare il tempo dopo.
Superintelligenza
Lavorando da qualche anno con aziende che vogliono esplorare le ia per gradi ho capito che è importante partire dalle reali necessità di un’azienda o di un’istituzione. Individuare quei pezzi di lavoro che possono essere fatti meglio se si fanno con umani e macchine che lavorano insieme; decidere che strumenti usare e come usarli; fare formazione, fare delle prove, fare dei prototipi e poi, a quel punto, adottare gli strumenti in maniera più ampia. Invece si fa tutto il contrario: compriamo diecimila licenze di un software di ia e vediamo cosa succede.
I problemi che rileva Alessandro nei riassunti delle riunioni o nelle spiegazioni tecniche si risolvono proprio con ia più specializzate. Personalmente, li ho risolti con strumenti come Pinpoint, NotebookLm e un uso che ho migliorato nel tempo dei più noti ChatGpt e Gemini. Ma ci è voluto tempo.
E, a proposito di tempo, un’altra cosa che lo consuma sono i dibattiti fuori fuoco, come quello sulla presunta superintelligenza.
Anche la speranza dei capi di aumentare la produttività è una trappola: le ia generative possono aiutarci a liberare tempo, a uscire dall’idea del sacrificio e della fatica come valori assoluti, a fare meglio con meno carico mentale. Invece di cercare una specie di pietra filosofale per il lavoro cognitivo basterebbe adottare una logica molto più sobria, che poi è quella individuata correttamente dal lettore di Artificiale quando dice che le ia “sono fantastiche soprattutto se hai le idee chiare”.
E poi bisognerebbe definire in anticipo un principio di equità e usare le macchine per ridurre veramente i carichi di lavoro invece di intensificarli. Ma questo richiederebbe di ripensare il modo in cui sono concepiti sia la gerarchia sia il mercato del lavoro. Ancora una volta: non sono le ia a rubarci il tempo. È il valore estratto da ogni cosa che facciamo. Le ia possono davvero essere abilitanti e possono davvero liberare tempo: se le si vuole usare, bisogna impegnarsi per trovare i modi più equi perché ciò accada e, soprattutto, impedire che quel tempo venga riempito con nuovi obblighi e nuove mansioni da sfruttare.
Questo articolo è tratto dalla newsletter Artificiale
|
Iscriviti a Artificiale |
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Artificiale
|
|
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it