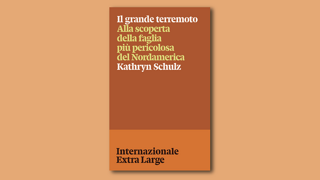Il 15 agosto 1979 James Dallas Egbert III, un ragazzo di sedici anni iscritto precocemente alla Michigan state university, negli Stati Uniti, lasciò un biglietto d’addio e poi si nascose nei tunnel di servizio del campus universitario. Sparì per più di un mese e i suoi genitori assunsero l’investigatore privato William Dear per ritrovarlo.
Dear venne a sapere che Egbert era un era un appassionato del gioco di ruolo Dungeons & dragons (D&d) e raccolse alcune voci secondo cui alcuni studenti organizzavano sessioni di gioco dal vivo proprio nei tunnel di servizio del campus.
Basandosi su queste informazioni sommarie, l’investigatore privato ipotizzò con la stampa che Egbert si fosse perso durante una di queste partite. Giornali e tv accolsero la teoria come un dato di fatto e dipinsero D&d come un “bizzarro gioco intellettuale” capace di far perdere il contatto con la realtà ai suoi giocatori, spingendoli in luoghi pericolosi.
La realtà, tuttavia, era molto diversa. La scomparsa di Egbert non aveva alcuna relazione con Dungeons & dragons. Il giovane soffriva di depressione clinica, era dipendente da droghe e subiva pressioni dai genitori per il rendimento scolastico. Il suo ingresso nei tunnel fu un vero e proprio tentativo di suicidio. Un anno dopo essere stato ritrovato, nel 1980, James Dallas Egbert III si tolse la vita.
Il 9 giugno 1982, un altro adolescente, Irving Pulling II, si suicidò in Virginia. Sua madre, Patricia Pulling, trovò la scheda del personaggio di D&d del figlio e giunse alla conclusione che la sua morte fosse stata causata da una maledizione lanciata sul suo personaggio durante una partita giocata a scuola.
Questa affermazione diventò il pilastro della sua futura campagna contro il gioco: Pulling denunciò cause per omicidio colposo contro il preside della scuola e contro l’editore del gioco Dungeons & Dragons. Le accuse furono respinte per mancanza di prove. Un’indagine successiva rivelò che la stessa Patricia Pulling, tempo prima , aveva fornito alle forze dell’ordine resoconti dettagliati di un grave disagio emotivo e di tendenze violente del figlio.
Pur senza prove, ma ampiamente cavalcata dai giornali – spesso molto frettolosi nello stabilire nessi causali tra fenomeni complessi – da libri e film, l’ostilità contro D&d si radicò profondamente nell’immaginario collettivo statunitense per molti motivi, fra cui anche l’ascesa della destra cristiana e di gruppi politicamente attivi come la Moral majority, una lobby conservatrice di matrice evangelica di cui era grande sostenitore Ronald Reagan. Per questi movimenti, Satana non era solo un simbolo del male, ma un’entità reale e attiva che minacciava i valori morali e la società statunitense.
La crescente rete di librerie cristiane e la popolarità di telepredicatori come Pat Robertson crearono un potente canale di distribuzione per queste paure, diffondendo il messaggio che l’America fosse sotto l’attacco di forze demoniache. L’evangelista Jack Chick produsse fumetti che distribuì in milioni di copie, i cosiddetti chick tracts. Uno dei più famosi, Dark dungeons, ritraeva esplicitamente Dungeons & dragons come uno strumento di reclutamento per vere e proprie sette sataniche, collegando direttamente il gioco alla narrativa del rituale satanico.
La narrazione ostile a D&d si rafforzò in seguito ad altri casi tragici. Nel 1985 il dottor Thomas Radecki, presidente della National coalition on television violence (Nctv), arrivò a sostenere di avere una lista di 28 omicidi e suicidi legati a D&d, una cifra che difese con forza durante la sua apparizione nel programma televisivo 60 minutes. Questa lista non fu mai supportata da prove concrete che dimostrassero un legame causale.
Incolpare D&d assolveva genitori, scuole, comunità, forse la società tutta dall’affrontare il proprio ruolo nel disagio di un giovane o il proprio eventuale fallimento nell’offrire un aiuto. Era più facile prendersela con un gioco che affrontare i problemi sistemici della salute mentale degli adolescenti.
Nel 2016 il New York Times ha dichiarato concluso il panico ingiustificato contro D&d. Anzi, “oggi le ansie dei genitori si sono rivolte ai video e ai videogiochi e […] D&d è un classico gioco low-tech”, scriveva Clyde Haberman, “giocato con penne, carta, dadi e miniature”. Il gioco “ha reindirizzato le miserie e le energie adolescenziali che avrebbero potuto essere destinate a usi più distruttivi”, ha aggiunto Jon Michaud sul New Yorker.
Il turno dell’ia
Veniamo ad agosto del 2025. Sono passati quarantasei anni da quando James Dallas Egbert III si nascose nei tunnel della sua università. Il disagio giovanile esiste ancora, purtroppo. E ci sono ancora episodi di suicidio.
Il 26 agosto 2025 i genitori di Adam Raine, un ragazzo suicida a sedici anni, hanno fatto causa alla OpenAi, l’azienda che produce il più famoso chatbot di intelligenza artificiale, ChatGpt. Secondo loro – che hanno stampato centinaia di pagine di conversazione fra il figlio e il chatbot – senza ChatGpt Adam sarebbe ancora vivo. I motivi di questa loro convinzione si possono leggere dettagliatamente sempre sul New York Times, che ha addirittura proposto alcuni pezzi di questo dialogo. Cosa che qui non faremo.
È molto difficile scrivere di queste cose, perché bisogna avere la lucidità di non perdere l’empatia, non giudicare, distinguere la tragedia personale dai fenomeni sociali e, allo stesso tempo, evitare nessi causali non dimostrati. Come giornalista, ho anche un codice deontologico da rispettare: mi ricorda che devo riportare le notizie che riguardano i suicidi in maniera responsabile, che devo minimizzare il rischio di spingere all’emulazione, che non devo scrivere in maniera sensazionalistica o enfatica. Che non devo semplificare o speculare sulle motivazioni del gesto.
Non sappiamo se i genitori di Adam Raine avranno soddisfazione da un giudice. Non sappiamo neanche se la OpenAi poteva fare di più: avrebbe forse dovuto bloccare qualsiasi discorso sul suicidio dentro le sue chat? Dovrebbe fare in modo – come chiedono alcuni – che nel caso in cui un adolescente ne parli parta una segnalazione alle forze dell’ordine? Una sorveglianza così pervasiva sarebbe davvero una soluzione?
Eppure abbiamo imparato tanto sulle ondate di panico ingiustificato e su quello che i giornali e gli altri mezzi d’informazione non dovrebbero fare. Sarebbe bello rinunciare alla semplificazione, ai nessi causali facili, alla superficialità e parlare, invece, delle ragioni dei disagi.
Ma le intelligenze artificiali, oggi, sono di moda e sono veloci e comode da cavalcare, come lo era negli anni ottanta Dungeons & dragons e come lo sono stati, poi, i videogiochi. Non ci sono soluzioni facili ma dubito che ci siano soluzioni nei divieti e nelle proibizioni. Oggi, per esempio, non ho potuto usare ChatGpt per rivedere questo articolo perché, siccome parla di suicidi, viola le sue policy. È poca cosa, certo, e se avessi la garanzia che questo accorgimento può salvare una vita lo accoglierei con gioia.
In realtà mi sembra semplicemente una precauzione aziendale per evitare altre cause legali. E un modo, per la società tutta, di non occuparsi dei motivi del disagio.
Se pensi di aver bisogno di aiuto o ti trovi in una situazione di emergenza, puoi chiamare il 112.
Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare Telefono amico tutti i giorni dalle 9 alle 24 al +39 02 2327 2327 oppure puoi scrivere via WhatsApp al +39 324 0117 252.
Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero verde 800 86 00 22 o al numero +39 06 7720 8977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.
Questo testo è tratto dalla newsletter Artificiale.
|
Iscriviti a Artificiale |
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Artificiale
|
|
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it