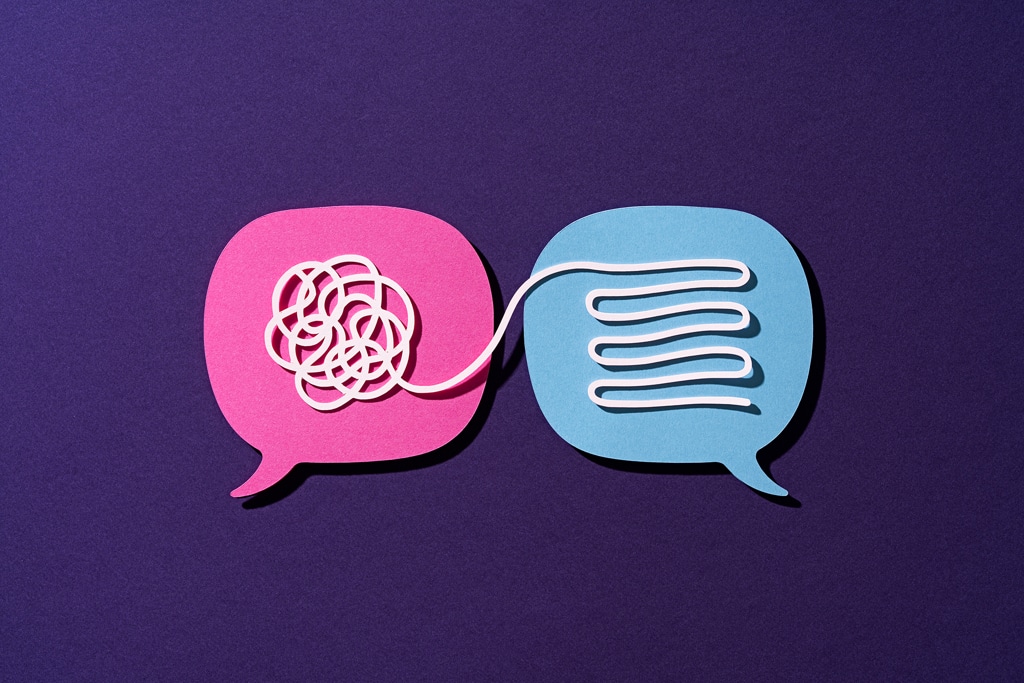Secondo un’indagine del ministero della salute, riferita a dati del 2023, in Italia il 19 per cento delle donne che comincia un percorso per uscire da situazioni in cui subiscono violenze lo fa quando accede al pronto soccorso. Per Pamela Genini, uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre scorso, questo non è avvenuto. Sappiamo che a settembre del 2024 Genini era stata al pronto soccorso di Seriate dopo un’aggressione di Soncin, e che il personale sanitario aveva seguito le procedure previste, compresa la somministrazione di un questionario per la valutazione del rischio, ma non era scattata la denuncia d’ufficio.
Ci sono due inchieste aperte per verificare che istituzioni e forze dell’ordine abbiano preso tutte le misure necessarie per tutelare Genini, ma al di là di quello che potrà emergere, il ruolo delle strutture sanitarie nel primo sostegno alle donne in situazioni critiche è confermato anche dall’aumento dei segni di violenza rilevati nelle cartelle cliniche degli accessi e dei ricoveri al pronto soccorso: secondo gli ultimi dati Istat, nel 2023 il totale degli accessi ha superato i livelli precedenti alla pandemia, tornando a valori simili al 2018 ma con un tasso più alto di violenze rilevate rispetto alla media del periodo successivo al covid (16.947 accessi per violenza, che corrispondono a 18,4 ogni diecimila, la cifra più alta registrata dal 2021).
Secondo il ministero della salute circa l’80 per cento delle strutture sanitarie ha attivato il “percorso per le donne che subiscono violenza”, seguendo le linee guida approvate con un decreto ministeriale il 24 novembre 2017. Queste linee guida prevedono che le aziende sanitarie locali, gli ospedali e i consultori siano tenuti a garantire assistenza specifica alle donne che subiscono violenza fisica, psicologica o sessuale, quando accedono ai servizi del sistema sanitario. Per esempio, accogliendole in un ambiente protetto, con operatori formati e garanzia di riservatezza, ma anche collaborando con i centri antiviolenza e le case rifugio, proteggendo i figli eventualmente coinvolti, e raccogliendo dati da trasmettere all’Istat. L’aumento degli accessi e delle diagnosi negli anni infatti non indica per forza un aumento della violenza, quanto della consapevolezza e delle competenze di medici e infermieri nell’intercettare il fenomeno.
Nonostante siano molto dettagliate, le linee guida non fanno nessun riferimento all’attivazione di sportelli antiviolenza dentro le strutture sanitarie. Gli sportelli, a differenza dei centri antiviolenza, dove si va con la consapevolezza di poter avviare un percorso di uscita dalla violenza, sono presenti in luoghi istituzionali, come le università o i tribunali, per intercettare proprio quelle situazioni in cui ci sono donne che non hanno ancora preso coscienza di vivere una situazione di abuso.
Ne è convinta Federica Scrollini, vicepresidente dell’associazione Be Free, che gestisce uno sportello antiviolenza dell’ospedale San Camillo di Roma, l’unico in Italia attivo 24 ore su 24: “Gli sportelli nei luoghi pubblici possono comunicare alla donna che il suo problema non è solo suo, ma fa parte di qualcosa che la struttura sanitaria e quindi la comunità riconosce e accoglie”.
“Non sappiamo esattamente cosa sia successo all’ospedale di Seriate, e se la presenza di operatrici avrebbe fatto la differenza nel caso di Genini. Ma nella nostra esperienza uno sportello antiviolenza sempre attivo in ospedale aiuta anche gli operatori a gestire la situazione quando è critica e chi è coinvolta non vuole ancora sporgere denuncia”, aggiunge Scrollini. “Il nostro sportello ha un’operatrice sempre presente all’interno del pronto soccorso. Non esiste un ‘codice rosa’ vero e proprio, ma un sistema per cui, anche in assenza di una necessità medica urgente, viene attivata l’allerta per l’operatrice dello sportello”.
Il “codice rosa” a cui si riferisce Scrollini è un’iniziativa nata come progetto pilota a Grosseto nel 2010, e poi estesa a tutte le aziende sanitarie toscane nel 2014. Al momento però la Toscana è l’unica regione ad averlo attivato in tutte le strutture sanitarie, asl e ospedali, e prevede un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le persone che subiscono violenza, in particolare donne, bambini e “persone discriminate”, come si legge nelle indicazioni regionali. Secondo questo protocollo nelle strutture toscane dal 2012 al 2023 è stata offerta protezione a 30.119 persone tra adulti e minori.
Per una donna che subisce violenza il passaggio in ospedale è particolarmente importante e va incentivato, per questo “lo sportello è visibile e invisibile allo stesso tempo”, spiega ancora la vicepresidente di Be Free: “Visibile perché integrato nel pronto soccorso, invisibile per ragioni di sicurezza. Ha due ingressi, doppie porte, accorgimenti architettonici che proteggono la privacy e la sicurezza delle donne. E l’operatrice indossa un camice”. Non solo per questioni di riservatezza in realtà, ma come “gesto simbolico”, aggiunge.
Non sappiamo quanti siano gli altri sportelli attivi in Italia. L’associazione Differenza Donna ne ha in carico otto in diversi ospedali di Roma e provincia, ma con orario ridotto, e l’unico modo per rintracciare altri sportelli negli ospedali italiani, o nelle istituzioni pubbliche, è cercare su un motore di ricerca. Non sono mappati come i centri antiviolenza della rete del 1522 e i dati che raccolgono non entrano nel sistema di monitoraggio dell’Istat.
L’attivazione degli sportelli dipende dalle singole aziende sanitarie, spesso con fondi temporanei, “ma con i tagli alla sanità, molti sportelli rischiano di sparire”, denuncia ancora Scrollini: “Sono iniziative indipendenti, difficili da monitorare anche sul piano dei finanziamenti. Servirebbe una ricerca nazionale per capire dove vanno i fondi, quanti sportelli esistono e come lavorano”. Ma non è mai stata avviata.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it