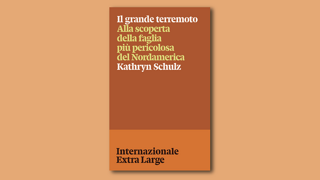Quando la premier giapponese Sanae Takaichi ha incontrato Donald Trump, la settimana scorsa, aveva una buona notizia: il governo di Tokyo sosterrà la candidatura del presidente statunitense al Nobel per la pace, seguendo l’esempio di Cambogia, Pakistan e Israele. Adulare Trump e assecondare le sue ossessioni è ormai la norma per i leader stranieri. Per fare un altro esempio, il premier britannico Keir Starmer ha approfittato del suo primo confronto con Trump alla Casa Bianca per invitarlo a fare una seconda visita di stato a Londra, un evento che ha definito “realmente storico” e “senza precedenti”.
Questo genere di comportamento servile è poco dignitoso, ma gli alleati degli Stati Uniti hanno concluso, un anno dopo la rielezione di Trump, che è indispensabile. Siamo davvero in una situazione senza precedenti nell’era moderna: la politica estera di Washington è determinata dai capricci del presidente.
I dazi agli alleati hanno compromesso l’obiettivo di isolare la Cina
Irritare Trump può avere conseguenze dolorose: i rapporti tra gli Stati Uniti e l’India sono precipitati dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi si è rifiutato di dare a Trump il merito dell’accordo di pace tra India e Pakistan. Gli Stati Uniti hanno reagito con dazi del 50 per cento sulle esportazioni indiane. Più di recente, Trump ha incrementato quelli sui prodotti canadesi, dopo che la provincia dell’Ontario ha mandato in onda uno spot televisivo che li contestava.
Gli scatti d’ira di Trump e i suoi improvvisi cambi di direzione danno l’impressione che la sua politica estera sia del tutto imprevedibile. Eppure in questi nove mesi sono emerse alcune tendenze ricorrenti.
Il presidente ha alcune ossessioni incrollabili. Ama le misure protezionistiche sul commercio (convinto che renderanno gli Stati Uniti più ricchi e potenti) e pensa che il suo paese sia stato “derubato” dagli alleati, quindi vuole rimodellare il sistema internazionale per allinearlo alla sua politica “America first” (prima l’America).
Il modo in cui gestisce i rapporti internazionali è fondato sullo scambio utilitaristico. Non c’è più posto per i discorsi retorici sui valori e la libertà dell’America, tanto cari ai suoi predecessori. Trump preferisce parlare della forza del suo paese e punta a collezionare “vittorie”, che possono essere la promessa di un grande investimento negli Stati Uniti o la prospettiva di un accordo di pace di cui lui possa prendersi il merito.
Il desiderio di Trump di essere considerato un promotore della pace sembra sincero. Potrebbe nascere da una vera avversione per la guerra. Potrebbe essere motivato dalla volontà di eguagliare Barack Obama, che nel 2009 fu (incomprensibilmente) premiato con il Nobel per la pace. Lui stesso ha detto di voler migliorare le sue chance: “Mi dicono che non sono ben piazzato, che per ora sono in fondo alla classifica”.
Strategia asiatica
Ma quest’istinto pacificatore finora è andato a fasi alterne. Il presidente e i suoi collaboratori stanno cercando di sottolineare il ruolo di primo piano nel processo che ha portato Israele e Hamas ad accettare un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e una pace duratura in Medio Oriente. Ma Trump ha anche dimostrato più volte di essere pronto a usare la forza militare. A giugno, dopo che Israele aveva attaccato le strutture nucleari iraniane, ha autorizzato una serie di raid aerei contro Teheran, una mossa che era stata valutata e regolarmente scartata dai suoi predecessori negli ultimi vent’anni. Dopo gli attacchi, si è immediatamente vantato di aver “spazzato via” le capacità nucleari iraniane. Tutte le voci scettiche nell’amministrazione sono state rapidamente messe a tacere.
A fine ottobre Trump ha promosso un nuovo accordo di pace (tra Thailandia e Cambogia), ma ha continuato la campagna di bombardamenti contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga nel mar dei Caraibi e nel Pacifico. Ha ordinato di posizionare la portaerei Gerald R. Ford nella regione, mentre si parla sempre più insistentemente di un tentativo per forzare un cambio di regime in Venezuela.
Per buona parte del mondo le politiche commerciali di Trump sono l’elemento più importante nei rapporti con gli Stati Uniti. I dazi pesantissimi annunciati da Trump nel cosiddetto giorno della liberazione, il 2 aprile 2025, sono stati ritardati o cancellati dopo la reazione ostile dei mercati. Da allora l’amministrazione Trump impone dazi a una serie di paesi. In base a calcoli spesso difficili da capire, il Regno Unito se l’è “cavata” con tariffe base del 10 per cento, mentre il Giappone e l’Unione europea si sono dovuti accontentare del 15 per cento. Le Filippine hanno incassato un 19 per cento, il Sudafrica il 30 per cento. La Cina è stata inizialmente minacciata con dazi del 100 per cento, ma dopo l’incontro fra Trump e il leader cinese Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud, è stato stabilito che i dazi medi sulle importazioni cinesi saranno del 45 per cento.
Il desiderio di Trump di fare un grande accordo con Xi ha sconvolto uno dei pochi settori della politica estera statunitense in cui democratici e repubblicani erano d’accordo. La prima amministrazione Trump aveva riportato la “competizione tra le grandi potenze” al centro, individuando la Cina come principale avversario. L’amministrazione Biden aveva proseguito sulla stessa strada, definendo la Cina “una minaccia costante” per gli Stati Uniti e cercando di coinvolgere gli alleati nella strategia per contrastarla. Ci si aspettava che Trump confermasse questa linea nel secondo mandato, tanto che in molti credevano che i dazi avrebbero colpito soprattutto Pechino, in un allineamento tra gli istinti economici del presidente e la più ampia manovra per contenere la potenza cinese. Ma alla fine le tariffe imposte a diversi alleati asiatici – Giappone, India, Taiwan, Corea del Sud – hanno compromesso il tentativo di isolare la Cina, tanto che a questo punto paesi come India e Vietnam stanno cercando di avvicinarcisi.
Come interpretare queste iniziative contrastanti? Un giorno i libri di storia parleranno di una “dottrina Trump” coerente e paragonabile alla “dottrina Truman” adottata dagli Stati Uniti all’inizio della guerra fredda? Forse non ci si può aspettare che un politico egocentrico e istintivo come Trump segua un approccio coerente in politica internazionale, ma nella sua amministrazione ci sono molte persone che cercano di definire e indirizzare il suo orientamento.
Nel novembre 2022 Majda Ruge e Jeremy Shapiro, studiosi dell’European council on foreign relations, hanno diviso questi conservatori in tre correnti: i restrainers (moderatori), i prioritisers (pragmatici) e i primacists (primatisti). Da allora queste categorie sono state adottate da molti repubblicani e continuano a essere usate dagli esperti di Washington.
Correnti alternate
I primatisti vorrebbero che gli Stati Uniti ricoprissero il loro tradizione ruolo di superpotenza mondiale, garantendo la sicurezza globale in Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina. Di questo gruppo fanno parte il segretario di stato Marco Rubio, il senatore della South Carolina Lindsey Graham e Mike Waltz, ex consigliere per la sicurezza nazionale e attuale ambasciatore alle Nazioni Unite.
I moderatori, tra cui il vicepresidente JD Vance, pensano che gli Stati Uniti dovrebbero usare in modo prudente il loro potere globale. Scottati dalla disastrosa esperienza delle guerre in Afghanistan e Iraq, nutrono una profonda diffidenza nei confronti degli alleati europei e asiatici, perché temono che possano trascinare il paese in nuove guerre.
Nel gruppo dei pragmatici, a volte chiamato “Asia first”, c’è chi è convinto che gli Stati Uniti non hanno più le risorse per ricoprire il ruolo di gendarme del mondo, e che farebbero meglio a scegliere con cura le battaglie da combattere. Dalla prospettiva di Elbridge Colby, alto funzionario del Pentagono, questo significa mettere in secondo piano la guerra in Ucraina a favore delle azioni di contenimento nei confronti della Cina in Asia.
Trump non fa parte di nessuna delle tre fazioni. Come sottolinea Shapiro, “il presidente non è interessato a queste scuole di pensiero, ma agisce in base ai suoi interessi personali”. Il risultato è che tutti e tre i gruppi hanno cercato d’influenzare la politica estera statunitense, allineandosi con i capricci del comandante in capo e al suo desiderio di “vittorie”. Ognuno ha ottenuto alcune conquiste, ma anche battute d’arresto.
“Trump ha barattato vittorie immediate con problemi a lungo termine”
I moderatori hanno promosso con entusiasmo l’idea di togliere il sostegno all’Ucraina e riavvicinarsi alla Russia di Vladimir Putin. Vance ha avuto un ruolo importante nell’umiliazione inflitta a febbraio al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj alla Casa Bianca.
Questa fazione è riuscita a convincere l’amministrazione Trump a tagliare tutti gli aiuti economici a Kiev, costringendo gli europei a riempire il vuoto. Ha anche alimentato lo scetticismo di Trump nei confronti della Nato e lo ha pressato perché chiedesse ai paesi europei di spendere di più per la loro difesa. Ma il tentativo di spingere l’amministrazione verso la Russia non ha avuto gli effetti sperati. Ad agosto Trump è rimasto deluso dall’esito dell’incontro in Alaska con Putin, mentre di recente si è riavvicinato a Zelenskyj e ha inasprito le sanzioni contro Mosca.
I moderatori hanno dovuto incassare altre sconfitte. La decisione di bombardare l’Iran ha provocato una spaccatura nel movimento Make America great again (Maga), al punto che persone influenti come il giornalista Tucker Carlson e la parlamentare Marjorie Taylor Greene hanno criticato duramente la mossa di Washington.
In una chat di gruppo in cui è stato incluso per errore un giornalista dell’Atlantic, Vance, parlando di un imminente attacco contro gli huthi in Yemen, ha scritto: “Penso che stiamo commettendo un errore. Non sopporto l’idea di salvare un’altra volta gli europei”.
I primatisti hanno accolto con entusiasmo la decisione di bombardare l’Iran, ma sono rimasti delusi quando Trump ha fermato gli attacchi, perché avrebbero voluto continuare la guerra e forzare un cambio di regime a Teheran.
Rubio, probabilmente il leader di questa fazione, spinge anche per la linea dura nei confronti del regime di Nicolás Maduro in Venezuela. Combinando questa politica con la battaglia interna contro la droga e l’immigrazione, il segretario di stato potrebbe ottenere un’altra vittoria per la sua squadra, che è anche riuscita a frenare l’istinto di Trump a uscire dalla Nato. In quest’ambito la politica attuale di Washington – restare nell’Alleanza atlantica ma costringere gli europei a spendere molto di più per la difesa – è un compromesso efficace tra moderatori e i primatisti.
Il gruppo dei pragmatici è quello che ha ottenuto meno finora. La tesi di Colby secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero trascurare il Medio Oriente e l’Europa per concentrarsi soprattutto sulla Cina sembra momentaneamente accantonata. I tagli agli aiuti militari per l’Ucraina vanno evidentemente in quella direzione, ma secondo alcune voci il dipartimento della difesa starebbe lavorando a una nuova strategia che si concentra sull’emisfero occidentale a discapito dell’Asia. Qualsiasi accordo commerciale con Pechino che sacrifichi gli interessi di Taiwan sarebbe una colpo durissimo sia per i primatisti sia per i pragmatici.
Avversari più liberi
Il modello proposto da Ruge e Shapiro è utile ma non riesce a catturare il caos di istinti e influenze che modella la politica estera del secondo mandato di Trump. Poco dopo l’insediamento, per esempio, è emerso un aspetto che quasi nessuno aveva previsto: l’affermazione di una nuova forma d’imperialismo, incarnata dal desiderio espresso da Trump di conquistare la Groenlandia e dalle minacce con cui ha fatto capire di voler annettere il Canada. Sono posizioni esagerate perfino per i primatisti, e non è ancora chiaro chi le abbia suggerite al presidente.
Al momento quest’imperialismo è stato messo da parte, ma è plausibile che dietro le quinte siano in corso manovre per sostenere le rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia. In ogni caso, a lungo andare gli Stati Uniti potrebbero pagare un prezzo alto per gli insulti nei confronti di India e Brasile, per l’imposizione di dazi agli alleati e per l’appoggio dato ai partiti europei di estrema destra.
I sostenitori di Trump liquidano le critiche a queste politiche come le solite lamentele di sinistra. Sono convinti che mostrare i muscoli abbia permesso al presidente di ottenere risultati positivi a Gaza, di cambiare in meglio la Nato e avvantaggiare gli Stati Uniti sul commercio.
Una percezione alternativa, descritta da Shapiro, è quella secondo cui Trump ha “barattato vittorie immediate con problemi a lungo termine, sperperando un capitale diplomatico accumulato in ottant’anni”. Un capitale frutto soprattutto del ruolo ricoperto dalla Casa Bianca come pilastro del sistema commerciale globale e garante della sicurezza degli alleati in Asia ed Europa. Negli anni paesi come Giappone, Regno Unito e Canada sono diventati molto dipendenti dagli Stati Uniti. Questo ha dato a Washington un potere enorme, che Trump sta usando in modo brutale, mandando un messaggio per il futuro: affidarsi all’America è una scelta rischiosa.
Di conseguenza gli alleati degli Stati Uniti stanno cominciando a tutelarsi. In alcuni casi apertamente – il primo ministro canadese Mark Carney ha promesso che farà il possibile per diversificare i rapporti commerciali del suo paese –, mentre in altri casi l’allontanamento dagli Stati Uniti è più discreto, come dimostra la scelta europea di sviluppare un sistema di difesa e capacità satellitari che possano operare indipendentemente dagli statunitensi.
I paesi che non sono alleati di Washington e non dipendono dalle sue garanzie di sicurezza sono ancora più liberi di rispondere a tono a questa aggressività. Lula, il presidente del Brasile, ha contrastato energicamente tutti i tentativi della Casa Bianca di evitare la condanna e l’incarcerazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro, alleato di Trump, mentre a quanto pare il primo ministro indiano Narendra Modi si sarebbe rifiutato di rispondere al telefono a Trump dopo lo screzio a proposito del Pakistan.
Il risultato è che gli Stati Uniti stanno perdendo influenza tra i paesi del sud globale. In un articolo pubblicato su Foreign Affairs, Richard Fontaine e Gibbs McKinley sostengono che Washington si sta inimicando stati che hanno un ruolo di primo piano nel sistema globale, sottolineando che “sta spingendo i Brics a diventare un blocco antiamericano”.
Usando la forza americana in modo nuovo e controverso, Trump dimostra che gli Stati Uniti hanno ancora un enorme potere sul palcoscenico mondiale. Ma probabilmente sta riducendo in modo significativo il potere che i suoi successori saranno in grado di esercitare. ◆ as
© The Financial Times Limited 2025. All Rights Reserved. Il Financial Times non è responsabile dell’accuratezza e della qualità di questa traduzione.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1639 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati