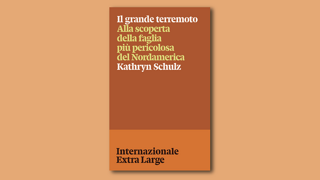Con undici voti a favore e tre astensioni, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 31 ottobre una risoluzione che rinnova per un anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara Occidentale (Minurso). E per la prima volta indica come base per futuri negoziati sullo status del territorio il piano di autonomia presentato dal Marocco nel 2007, che prevede l’autogoverno sotto la sovranità marocchina.
Il Sahara Occidentale, un’ex colonia spagnola annessa unilateralmente dal Marocco negli anni settanta, è l’ultimo territorio non decolonizzato in Africa, secondo la lista dell’Onu dei territori che non hanno ancora un governo autonomo.
Al voto del consiglio non ha partecipato l’Algeria, da sempre sostenitrice della lotta del Fronte Polisario, l’organizzazione che rivendica il diritto all’autodeterminazione dei sahrawi.
Un punto di svolta
La Minurso fu creata nel 1991 per favorire l’organizzazione di un referendum in cui il popolo sahrawi avrebbe dovuto esprimersi, scegliendo tra l’indipendenza e l’integrazione con il Marocco. Ma il voto non è mai stato organizzato.
Se oggi si fa riferimento al piano marocchino del 2007 per i futuri negoziati lo si deve all’azione diplomatica degli Stati Uniti. Il presidente statunitense Donald Trump è infatti apertamente schierato con il Marocco, che considera i territori del Sahara Occidentale le sue “province meridionali”.
È un punto di svolta in questo intricato dossier e riflette il recente allineamento diplomatico internazionale con le posizioni marocchine: negli ultimi mesi, oltre a Washington, i governi di Francia, Spagna e Regno Unito si sono espressi a favore del piano.
Non è un caso, perciò, se re Mohamed VI ha deciso di rendere il 31 ottobre una giornata di festa nazionale in Marocco, l’Aid al wahda (festa dell’unità), con “tutto quello che implica in termini di significati e riferimenti all’unità nazionale e all’integrità territoriale incrollabile del regno”, come si legge nel comunicato ufficiale.
Da parte sahrawi, la risoluzione ha suscitato grave preoccupazione, se non proprio aperte condanne. In una nota l’attivista per i diritti dei sahrawi, Aminatou Haidar, ha criticato “l’approccio discutibile del Consiglio di sicurezza alla questione del Sahara Occidentale, che si allontana dai princìpi della legalità internazionale e minaccia il diritto inalienabile di questo popolo all’autodeterminazione”.
Cinquant’anni dopo
Pochi giorni dopo il voto della risoluzione, il 6 novembre, è stato il cinquantennale della Marcia verde. Quel giorno del 1975, ricorda il giornale spagnolo ElDiario.es, “trecentocinquantamila civili marocchini, per lo più contadini, marciarono dal loro paese verso il Sahara Occidentale. Erano stati reclutati dal re Hassan II, che cercava di approfittare dell’imminente morte del dittatore spagnolo Francisco Franco per appropriarsi illegalmente di quella che fino ad allora era stata la cinquantatreesima provincia spagnola”.
“L’obiettivo”, continua il ElDiario.es, “era fare pressioni, se non proprio un’occupazione, per ‘recuperare’ un territorio che, secondo quanto sosteneva Hassan II, gli apparteneva da prima della colonizzazione. Qualche giorno dopo la marcia, il 14 novembre 1975, il ricatto marocchino diede i suoi frutti e la Spagna firmò gli accordi tripartiti di Madrid, con cui cedeva illegalmente il Sahara Occidentale al Marocco e alla Mauritania”.
Dopo la firma, il Marocco occupò militarmente il territorio e, poco dopo, scoppiò un conflitto con il Fronte Polisario, ancora oggi senza soluzione. Nel 1976 infatti il Polisario proclamò nel Sahara Occidentale la Repubblica araba saharawi democratica (Rasd) e scoppiò una guerra con Marocco e Mauritania. Successivamente, il governo mauritano rinunciò alle sue rivendicazioni, ma il Marocco continuò a mantenere il controllo su una buona parte del territorio.
“Negli ultimi cinquant’anni Rabat ha mantenuto uno stallo politico, in cui è riuscita a guadagnare gradualmente terreno e a legittimare l’occupazione illegale”, conclude un attivista sahrawi intervistato dal giornale spagnolo. “Il ravvicinamento diplomatico con Israele non solo le ha garantito il sostegno degli Stati Uniti, ma anche l’accesso a tecnologie militari israeliane all’avanguardia. E, usando l’immigrazione come strumento di pressione, è riuscita a convincere il governo spagnolo di Pedro Sánchez ad accettare le sue proposte di autonomia controllata”.
Nel 1980, ricorda Alex McDonald su Middle East Eye, il Marocco cominciò a costruire il berm, un muro di sabbia militarizzato lungo 2.700 chilometri, che oggi divide la parte del Sahara Occidentale controllata dal regno, dal resto del territorio (circa il 20 per cento) in mano al Fronte Polisario. “Gli attivisti sahrawi che vivono nella parte marocchina subiscono la repressione – tra le donne sono stati denunciati abusi e violenze sessuali da parte della polizia – mentre centinaia di migliaia di persone vivono nei campi profughi nel deserto in Algeria, totalmente dipendenti dall’Onu e dal governo di Algeri”, scrive McDonald.
Una causa sacrificabile
Il Marocco si è affrettato a sviluppare economicamente il Sahara Occidentale, ricco di risorse ittiche e fosfati. Inoltre località come Dakhla, sull’oceano Atlantico, hanno un forte potenziale turistico.
Un anno fa i sahrawi hanno ottenuto una vittoria quando la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato gli accordi agricoli e di pesca firmati nel 2019 dal Marocco e da Bruxelles, perché non rispettavano i diritti dei sahrawi, stabilendo che i prodotti della regione dovevano riportare come provenienza “Sahara Occidentale” e non “Marocco”. Ma è stata una goccia nel mare.
Negli anni “numerose aziende francesi, spagnole, israeliane e statunitensi hanno intensificato la loro collaborazione con Rabat per sfruttare le risorse del Sahara Occidentale”, ricorda Middle East Eye, secondo cui un settore particolarmente redditizio sono le energie rinnovabili, in particolare quella eolica.
“Anche se si facesse il referendum dei sahrawi, resta una domanda fondamentale: chi potrà votare?”, nota l’analista politico Adlène Mohammedi, del centro studi Aesma di Parigi, intervistato dal quotidiano olandese Nrc. “Il Marocco contesta la definizione di popolo sahrawi. Secondo Rabat, queste persone sono principalmente marocchini, anche se circa duecentomila di loro vivono in esilio nei campi algerini. Allo stesso tempo, non vanno persi di vista gli interessi economici. Il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara Occidentale apre le porte al commercio e agli investimenti. E questo rende la causa sahrawi facilmente sacrificabile per vari paesi dell’Onu”.
|
Iscriviti a Africana |
Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Africana
|
|
Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it