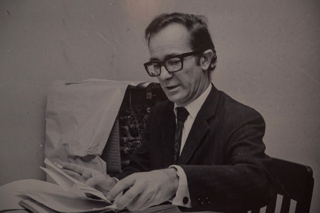Che i sogni abbiano un significato nascosto è un’antica convinzione. Il libro della Genesi, scritto circa 2.500 anni fa, racconta che Giuseppe, figlio di Giacobbe, interpretava i sogni del faraone egizio: le vacche grasse e quelle magre preannunciavano anni di abbondanza e di carestia. In Cina, invece, l’opera più nota sui sogni è lo Zhou Gong jie meng, scritto cinquecento anni prima, che contiene spiegazioni di sogni strani e fantastici. Ma è solo dal 1899, con L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, che i sogni sono diventati oggetto di indagini scientifiche.
Da allora sono stati fatti passi avanti. L’enfasi posta da Freud sugli impulsi violenti e sulla repressione sessuale, che sarebbero all’origine dei sogni, appare oggi datata. L’ipotesi è che i sogni riflettano l’esperienza quotidiana, perché consolidano i ricordi o mettono alla prova idee da realizzare nelle ore di veglia. Questa somiglianza tra sogni e realtà, che gli psicologi chiamano ipotesi della continuità, non è però confermata empiricamente. Gli scarsi dati disponibili provengono da studi clinici e non dall’esame di persone sane di mente, e i partecipanti coinvolti sono pochi.
Contenuto emotivo
Non è il caso della più recente indagine sul tema. Alessandro Fogli dell’università Roma Tre e Luca Maria Aiello e Daniele Quercia dei Nokia Bell Labs di Cambridge, nel Regno Unito, hanno esaminato migliaia di sogni di persone sane di mente. E, come spiegano su Royal Society Open Science, hanno trovato alcune conferme all’ipotesi della continuità.
Il metodo più usato per valutare i sogni è la scala Hall-Van de Castle, basata su descrizioni dei personaggi e delle loro interazioni, come pure del contenuto emotivo. La scala attribuisce punteggi che permettono di valutare aspetti diversi, come la quantità di incontri piacevoli, sessuali e violenti presenti nei sogni.
Questo sistema, però, richiede tempi lunghi e dipende dal narratore, per cui punteggi assegnati da persone diverse non sono del tutto equiparabili. La novità introdotta da Fogli, Aiello e Quercia è stata l’automatizzazione grazie a un algoritmo di analisi del linguaggio noto come albero sintattico, in grado di elaborare migliaia di racconti in modo coerente.
I resoconti dei sogni provengono dalla DreamBank dell’università della California a Santa Cruz, che ne custodisce 24.035, scritti tra il 1910 e il 2017. Oltre alle descrizioni dei sogni ci sono età, sesso e una breve biografia degli autori. I tre ricercatori volevano dimostrare che gli uomini sognano in modo diverso rispetto alle donne, che i sogni si evolvono con l’età, che le esperienze personali cruciali ne modificano l’andamento e che riflettono l’aggressività quotidiana percepita.
Quanto alle differenze di genere, gli uomini fanno sogni più violenti delle donne. Per quanto riguarda l’età, i ricercatori hanno visto che i sogni si modificano passando dall’adolescenza all’età adulta. Secondo l’algoritmo, l’esperienza quotidiana incide profondamente sui sogni. Un veterano della guerra del Vietnam faceva sogni violenti più spesso di chi non aveva mai fatto parte dell’esercito. I sogni dei non vedenti, che spesso nella quotidianità dipendono dall’aiuto degli altri, erano i più pacifici in assoluto.
I ricercatori hanno poi chiesto all’algoritmo di analizzare le differenze nei sogni da un decennio all’altro (a cominciare dagli anni sessanta perché per il periodo precedente non avevano abbastanza materiale), scoprendo che la violenza e l’aggressività raggiungevano il picco negli anni sessanta, per poi diminuire nei decenni seguenti. In effetti quello è stato un decennio particolarmente violento per gli Stati Uniti, caratterizzato da omicidi politici, dalla minaccia della distruzione nucleare e dalla guerra del Vietnam.
La nuova ricerca sembra quindi confermare l’ipotesi della continuità. Ovviamente, non poteva rispondere alla domanda più profonda sulla reale funzione dei sogni. In attesa di capire se un sistema computazionale possa indagare anche su questo aspetto, nel caso sognassimo vacche magre sarà meglio rifornire la dispensa. Non si sa mai. ◆ sdf
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1375 di Internazionale, a pagina 98. Compra questo numero | Abbonati