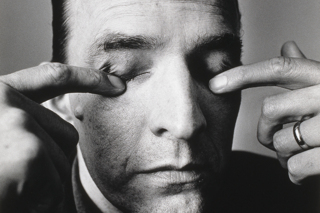Pierfrancesco Celada è un fotografo italiano che ha trascorso molti anni a Hong Kong prima di tornare a vivere in Italia, a Venezia, nel 2022. I suoi lavori sono osservazioni solitarie della città: un flaneur con la macchina fotografica al collo che sembra essere attratto dalle solitudini.
Qualche anno fa il suo Instagrampier, già vincitore nel 2017 del concorso Happiness on the move e pubblicato sul numero 1213 di Internazionale, ha fatto sorridere molti perché proponeva un’umanità variegata su un molo pubblico per il trasporto di merci a Hong Kong, frequentato quotidianamente da fotografi, instagrammer e gente comune che si scattavano selfie da condividere sui social media. Un affresco ironico del molo come luogo di transizione tra realtà e mondo virtuale, rampa di lancio dell’autorappresentazione da far vagare nell’etere, una specie di ritratto condiviso della vita contemporanea, dove gli eteronomi sono diventati avatar.
Il libro sarebbe dovuto essere pubblicato dalla casa editrice tedesca Peperoni Books ma quando, nel 2018, il direttore Hannes Wanderer è morto, la produzione si è bloccata e Celada ha dovuto riorganizzarsi. Così si è fatto coraggio e ha deciso di cominciare a produrre i suoi libri da solo con la Muddy island: il primo titolo è stato appunto Instagrampier, nel 2021.
Alla domanda su come sia nato il nome della casa editrice – Muddy island, cioè isola fangosa – l’autore risponde: “Negli ultimi cinque anni abbiamo vissuto su una piccola isola a 25 minuti di traghetto da Hong Kong. L’isola di Lamma è abitata da pescatori, non ci sono macchine ed è immersa nella natura. Lama in portoghese significa fango. A causa di un errore di traduzione delle mappe, si è creduto che lama fosse il nome dell’isola, invece era solo la descrizione delle acque che la circondavano. Però da lì è nata Lamma island, che vuol dire appunto fangosa. Ora che vivo a Venezia, a Murano, mi sembra che il nome resti attuale”, sorride.
Nell’ultimo anno la Muddy island ha dato alle stampe tre nuovi libri, One a day e Walking circles, entrambi nati durante la pandemia di covid-19, quando Hong Kong aveva adottato una politica molto rigorosa per contenere i contagi, e When I feel down I take a train to the happy valley (quando mi sento triste prendo un treno per la valle felice). Quest’ultimo titolo è particolarmente evocativo: sembra la nota di un diario, un appunto preso in un momento di fatica. È invece il risultato di un’esplorazione durata otto anni, una raccolta di quello che la città ha attraversato e che il fotografo ha potuto documentare stando lì.
“Ho vissuto a Hong Kong dal 2014 al 2022. È un luogo di forti contrasti, un ambiente urbano claustrofobico circondato dall’acqua e da una natura incontaminata. Il libro racconta questo periodo storico, è una riflessione sulla vita in città: una megalopoli così densamente popolata, con tutte le difficoltà del caso: costruzioni, tanti grattacieli che nascondono il cielo, quindi c’è anche un senso di oppressione della città sull’individuo”.
Parallelamente l’ex colonia britannica ha vissuto degli eventi importanti: la “rivoluzione degli ombrelli” nel 2014, protesta pacifica per il diritto al suffragio universale, simbolicamente rappresentata dagli ombrelli usati contro i lacrimogeni della polizia, e poi ancora le proteste del 2019 contro il governo di Pechino. Una doppia lettura, dunque: da una parte la vita in una grande metropoli, dall’altra la crisi di identità e le difficoltà dovute a un periodo storico complicato per Hong Kong.
Spiega Celada che “in realtà Happy valley è un quartiere di Hong Kong molto anonimo, una zona dormitorio, però c’è un tram che spesso attraversa il distretto degli affari della città con scritto sul display ‘Happy valley’. A me è sempre piaciuta l’idea che vedendo passare questo tram potessi scorgere la possibilità di un posto felice, anche per un secondo”.
Le immagini del libro, perlopiù verticali, mostrano una società atomizzata, piena di particelle disgregate, con tagli di luce che ne enfatizzano le sagome. Che siano soli o in compagnia, gli individui sono spesso chinati sui propri cellulari, sembrano estranei alla collettività, in un discorso tutto incentrato sulla poetica del frammento.
“Quello che cerco di solito è proporre delle rappresentazioni non letterali di quello che succede per lasciare a chi guarda la possibilità di decidere che cosa può accadere. Le mie sono più delle metafore visive. Le immagini dei ragazzi con l’ombrello vengono dai momenti di protesta che ho seguito quotidianamente. Non ci sono didascalie, c’è un breve testo di descrizione della mia esperienza in quel periodo”.
In questo scenario, il miraggio di una valle felice da raggiungere in tram diventa una chimera e insieme un viaggio verso qualcosa che sembra alla portata di tutti.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it