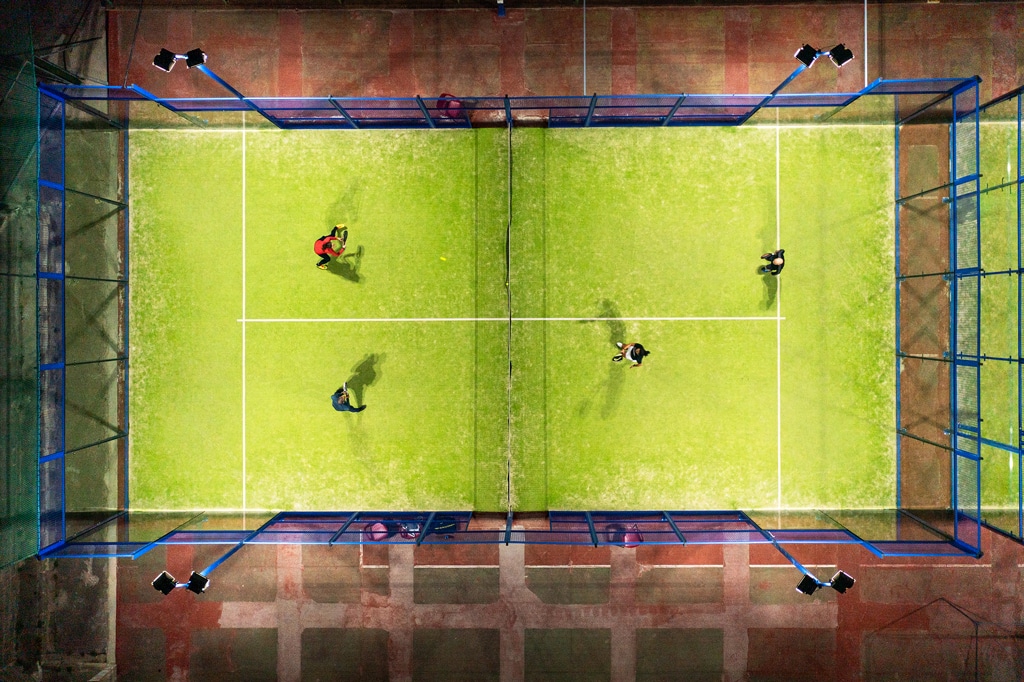Quando sarò primo ministro (avete poco da ridere, nessuno è al sicuro), la mia prima decisione sarà abolire l’insegnamento di Freud per i maturandi. Vi assicuro che non c’entra la cancel culture. Va bene familiarizzarsi con la fase anale a venticinque anni, oppure a ottanta, perché no? Ma quando ci si rivolge a persone che stanno costruendo la propria identità e la propria sessualità, non si associa la parola “fallico” al desiderio. Non si definisce geniale un’invenzione bislacca come l’invidia del pene. Non si turbano i primi fremiti adolescenziali infliggendo ai giovani l’idea che in realtà il loro primo amore è stato verso un genitore. Insomma, accademici, quante altre generazioni volete traumatizzare?
Va detto che quando ero adolescente io, l’eredità di Freud era onnipresente (e di critiche non se ne sentivano). Le riviste per ragazze incoraggiavano ruoli sessuali piuttosto tradizionali, avallati dall’inoppugnabile “consiglio dello psicologo”.
In questo mondo pre-Womanizer, la questione centrale era legata all’orgasmo vaginale (ovviamente). Per godere, una donna doveva abbandonarsi a un uomo, lasciarsi fare, mollare la presa. Bisognava ricevere. L’atteggiamento passivo era connaturato alla femminilità e, a torto o a ragione, la teoria freudiana sembrava giustificare questo dato di fatto. Stando a certe testimonianze, si potevano ancora incrociare dei brontosauri, all’alba, sulla linea 4 della metropolitana di Parigi.
Trent’anni dopo, mi ritrovo sbalordita dal ribaltamento di questo paradigma. Le donne occupano chiaramente il ruolo primario nella sfera sessuale. Sono attive ventiquattr’ore su ventiquattro: s’informano, praticano, dirigono, rimorchiano, scaricano, rimettono in discussione, protestano. Allenano i muscoli del pavimento pelvico, mettono a confronto i sex toys, e quando è ora di pagare il conto, mettono mano al portafogli.
Questo controllo è talmente totale e intransigente da lasciarle spossate. Fra la critica alle restrizioni e l’esasperazione di fronte ai carichi emotivi e mentali della sessualità, non è che la donna attiva rimpiange i tempi in cui era passiva? Qualche volta (specie nelle cerchie più conservatrici). Ma il successo delle idee femministe resta indiscutibile.
Un cambiamento duraturo
Certi uomini, dal canto loro, sembrano aver gettato la spugna. Smarriti e incerti, dopo il #metoo, non hanno più il coraggio di fare il primo passo (è l’opinione del 54 per cento delle donne francesi, stando a un sondaggio dell’Institut français d’opinion publique del 2024). Nell’ambito della contraccezione maschile, i progressi sono stati assai modesti. In quello della capacità seduttiva, si registra un aumento degli uomini che vanno in palestra ad allenare i muscoli, ma non si può parlare di uno sforzo significativo. Guardando poi ai produttori di contenuti per adulti e ai sexy shop, si nota che tendono a trascurare il pubblico maschile: perché prendersi la briga di attirarlo, quando sono le donne quelle che seguono, leggono e fanno shopping?
In ogni caso, ci sono chiari segni di scontento. Certi uomini si lamentano di aver perduto la capacità di agire (“Non si può più dire niente”, “Non si può più rimorchiare”, “Lei mi dice sempre di no”). Altri si sentono profondamente inibiti, e non nascondono che preferivano i bei vecchi tempi.
Nonostante queste riluttanze, la norma dell’uomo-soggetto e della donna oggetto è crollata. Si tratta di un cambiamento duraturo: tutti i bambini nati in Francia nell’ultimo quarto di secolo sono cresciuti in un mondo in cui le donne sono sessualmente attive. Neppure il più incallito dei maschilisti oserebbe pretendere che, per raggiungere l’orgasmo, una donna debba abbandonarsi e allargare le gambe.
D’altronde, con un po’ di malafede (sapete che è la specialità della casa), si potrebbe enfatizzare ancora di più il ribaltamento della norma attivo/passiva. Non dimentichiamo che la vagina è un muscolo, e il pene no. L’orgasmo femminile viene intensificato dall’allenamento muscolare (del pavimento pelvico), mentre l’erezione deve arrivare e basta. L’eiaculazione, poi, è un riflesso. Gli orgasmi femminili sono facilitati dalla masturbazione esterna, mentre quelli maschili sono più intensi quando gli uomini si lasciano penetrare. Per contro, le donne usano meno supporti “passivi” per eccitarsi, mentre gli uomini si accontentano di consumare fantasie pornografiche fabbricate non si sa bene come, e rivolte al pubblico più ampio possibile (vedete com’è facile?).
Restare fluidi
Bene, ora che ho infierito a sufficienza, torniamo al nostro ribaltamento tra attivo e passivo. Se la rivoluzione in atto mi lascia perplessa, è perché fino a due minuti fa (in tempo percepito), la passività sessuale delle donne era considerata un fatto evidente. Per questo motivo era terribilmente difficile metterla in discussione. La passività era ritenuta naturale, un fatto scientifico: la vagina era un buco, quindi le donne recavano in sé un’assenza che dovevano essere gli uomini a colmare. Il corpo poteva, e dunque doveva, essere penetrato (e da un pene, non da una spazzola per capelli).
Il messaggio che mi arriva da questa rivoluzione è che le certezze hanno una scadenza, e capita che si rivoltino come guanti. Se può succedere nel giro di tre decenni, può succedere anche in tre anni o tre mesi. Questa accelerazione del tempo delle idee (brillantemente descritta dal filosofo tedesco Hartmut Rosa) deve spingerci a rimanere, almeno noi, fluidi.
Da un lato questa fluidità può darci l’impressione di uno smarrimento totale. Dall’altro, l’instabilità ci fornisce l’occasione per esercitare una libertà più ampia: se le vostre percezioni erotiche o i vostri ragionamenti logici non corrispondono a quello che leggete nei libri o sui giornali, non è poi tanto grave. Forse siete solo in anticipo di due o tre decenni su un ribaltamento di paradigma che vi darà ragione.
Tale esigenza di fluidità richiede un grande sforzo di umiltà. Bisogna poter dire che le nostre pratiche sessuali non ci trasformano automaticamente in esperti (se non della nostra sessualità individuale). Bisogna poter ammettere di essersi sbagliati, essere disposti a rimettersi in discussione, e riconoscere che le evidenze imparate sui banchi di scuola saranno sostituite da altre evidenze che a loro volta andranno discusse e criticate. Bisogna infine poter dire che non siamo responsabili dei luoghi comuni che ci mettono in testa, nel momento in cui li mettono, ma che siamo assolutamente responsabili di quelli che decidiamo di conservare e continuiamo a tramandare.
Occupare una posizione attiva
È chiaro, tuttavia, che il ribaltamento delle norme pone una questione assai più urgente: se appena trent’anni fa si potevano definire le donne “naturalmente” passive, in quali altre fesserie continuiamo a sguazzare qui e ora? Dobbiamo smettere di fidarci di tutto e tutti? Perché il rischio è quello di trovarci a fare i conti con un dibattito sessuale svuotato di ogni senso o che si limita al relativismo (“ognuno fa come gli pare”, “ognuno vive la realtà che più gli conviene”). Per non parlare delle fake news che l’intelligenza artificiale andrà a vomitare sul tema della sessualità negli anni a venire!
Penso che l’unica posizione sostenibile sia coltivare la propria cultura scientifica: capire come si formano i discorsi, i sondaggi e gli articoli specializzati, leggere le clausole scritte in piccolo, interessarsi ai pregiudizi dei ricercatori, paragonare i diversi studi, chiedersi sempre chi abbia interesse a considerare questo o quel fatto come una prova.
Insomma, è necessario occupare una posizione attiva. Ed è per questo, a mio avviso, che nei corsi di filosofia andrebbe insegnato il senso critico. All’ultimo anno. Al posto di Freud e dei suoi simboli fallici. E per la mia candidatura alla carica di primo ministro, vi terrò aggiornati.
(Traduzione di Francesco Graziosi)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it