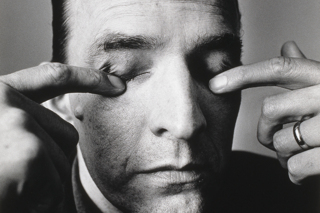Al numero 90 di via Coroglio, nel cuore dell’ex area industriale di Bagnoli, c’è una terrazza sul mare che nel fine settimana si affolla di giovani sportivi e frequentatori più anziani, arrivati per un aperitivo a pochi passi dalla spiaggia. È la terrazza del Circolo Ilva, inaugurato poco dopo l’edificazione delle acciaierie nel 1905 e ancora attivo. Non sono molti gli abitanti del quartiere, però, che possono godersi questo luogo.
Il circolo ha avuto un ruolo importante nella storia della Bagnoli industriale: all’inizio per gli impiegati e gli sportivi che qui facevano canottaggio, lotta libera, ginnastica e giocavano a calcio; successivamente anche per gli operai e le loro famiglie, con attività sociali come il cinema, il teatro o la colonia estiva per i figli dei lavoratori. Oggi, che dell’industria è rimasta solo l’archeologia, il circolo è gestito da un’associazione sportiva dilettantistica, con un accesso alle attività regolato da iscrizioni e quote non esattamente popolari.
Sabato 8 novembre, per la seconda volta in pochi mesi, la terrazza è stata pacificamente invasa da circa duecento persone, per lo più bagnolesi, che protestavano contro l’organizzazione della Coppa America di vela e contro la sottrazione di un pezzo di litorale agli abitanti. L’arrivo di bandiere, accompagnato da cori e interventi al megafono, ha movimentato la mattinata del circolo, dove si stava svolgendo una mostra fotografica sulla storia della fabbrica.
“Qui rivendichiamo un legame col quartiere che non c’è più”, spiega Aldo Velo, ex delegato della Fiom (il sindacato degli operai metalmeccanici) delle acciaierie Italsider. Bagnolese di nascita, Velo ha partecipato alle lotte operaie e del territorio dalla fine degli anni sessanta. “Ci siamo battuti in fabbrica per avere voce nei processi produttivi, per l’eliminazione delle paghe di classe e della monetizzazione del rischio; ma fuori abbiamo lottato per l’ambiente, per il territorio, e dopo per restituire un mare pulito e gratuito al quartiere. Oggi il circolo è un luogo privato, pieno di cancelli e barriere, un posto che con la classe operaia non c’entra niente”.
I manifestanti lo hanno invaso anche perché è una delle strutture coinvolte nell’organizzazione della Coppa America. Il decreto legge 96 del 2025, sulle “disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi”, ha infatti prorogato in vista della gara la permanenza della struttura sulla spiaggia, che invece secondo il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (Praru) andrebbe destinata a un uso pubblico e gratuito, senza cancelli o ingressi a pagamento per l’accesso al mare: “Sport sano e gratuito, mare libero per tutti e non ristoranti e bar panoramici per chi paga una tessera!”, urla una giovane manifestante tra gli applausi.
Una deindustrializzazione infinita
Per spiegare quello che sta succedendo oggi a Bagnoli bisognerebbe ripercorrere tutta la storia del polo industriale, lunga più di un secolo e fatta di emancipazione sociale e devastazione ambientale, lavoro e lutti, sviluppo economico e sfruttamento. Più semplice è invece constatare che, dalla chiusura degli impianti, nei primi anni novanta, a oggi, il processo di deindustrializzazione ha portato a novecento milioni di euro di risorse pubbliche clamorosamente dilapidati, a bonifiche mai fatte o fatte male, e alla costruzione di poche opere diventate cattedrali nel deserto o andate in rovina. Centinaia di carotaggi, consulenze, indagini della magistratura, facevano intanto percorrere alla “rigenerazione” strade contorte per tornare sempre al punto di partenza. La classe politica si è limitata a giocare una gigantesca partita a Monopoli in cui si bruciavano soldi e tempo senza mai realmente muovere un passo verso la creazione di una nuova identità. E ha fallito di volta in volta tutti i percorsi di sviluppo, dall’industria leggera al turismo sostenibile, dallo sport alla cultura.
Nel 2014 l’area di Bagnoli-Coroglio, considerata sito di interesse nazionale, è stata commissariata dal governo Renzi, un intervento che ha suscitato le durissime proteste dei comitati territoriali, dal momento che toglieva al consiglio comunale il suo ruolo nella pianificazione urbanistica, attribuendo le decisioni al governo, all’agenzia per gli investimenti Invitalia e al commissario straordinario. Dal 2021 il commissario è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e lo sperpero è diventato perfino più veloce.
“Fino alla primavera 2024”, spiega Dario Oropallo, attivista dell’Osservatorio popolare sulla bonifica e la rigenerazione urbana di Bagnoli, “siamo riusciti a mantenere rapporti costruttivi, anche se molto altalenanti, con la struttura commissariale. Questi rapporti si sono poi deteriorati a causa di una serie di interventi che hanno completamente modificato i progetti esistenti, andando a colpire quegli elementi del piano che erano frutto di trent’anni di lotte sul territorio”.
Da più di un anno, in effetti, i comitati denunciano le evoluzioni degli interventi di bonifica e rigenerazione, evidenziando le connessioni tra questione ambientale, sviluppo urbano e turistificazione della città, e le conseguenze per la sicurezza in relazione al bradisismo, che negli ultimi tre anni ha registrato una forte accelerazione tra Bagnoli e Pozzuoli.
Un discusso cambio di marcia
Nel luglio 2024 la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il sindaco Manfredi (in veste di commissario) firmano un protocollo di intesa che finanzia bonifica e rigenerazione con un miliardo e 218 milioni di euro. Per la prima volta vengono individuate tutte le risorse necessarie per attuare il Praru, ma il prezzo da pagare è alto: pochi giorni prima di quella firma, infatti, il governo ha modificato una legge fondamentale per gli equilibri del piano (la 582 del 18 novembre 1996), eliminando la parte che prevedeva di riportare la linea di costa alla forma dell’epoca preindustriale per ridare una spiaggia alla città, e imponeva quindi di rimuovere dal mare un’enorme colmata, un’inquinatissima piattaforma fatta di cemento e scarti industriali.
Allo stesso tempo, il sindaco Manfredi e il governo annunciavano che Bagnoli sarebbe diventata un luogo chiave dell’edizione 2027 della Coppa America, una competizione sponsorizzata dai più grandi gruppi economici internazionali. Troppo facile immaginare il luogo scelto per ospitare le officine, gli hangar per le imbarcazioni e il villaggio per gli atleti: è proprio quella colmata “blindata” dall’intervento sulla legge 582, che rimarrà per sempre lì dov’è, privando il territorio di quasi un chilometro di spiaggia.
“In questi trent’anni”, spiega Giuliano Esposito, del Comitato mare libero Napoli, “i napoletani hanno detto in tutti i modi che su quel litorale vogliono una spiaggia libera. Nel 2013, dopo aver raccolto quindicimila firme di sostegno, è stata approvata una delibera comunale poi rimasta inapplicata, e anche gli strumenti urbanistici ordinari parlano di restituzione del litorale agli abitanti. Mantenendo la colmata è impossibile, senza contare che gli interventi progettati per la Coppa America rischiano di diventare strutturali: la balneabilità potrebbe essere compromessa definitivamente, sacrificando quello specchio d’acqua per farne un porto per gli yacht”.
I comitati non sono gli unici a denunciare il delicato rapporto tra la gara di vela e lo sviluppo del territorio. Anche se sarà usata come acceleratore per gli interventi di bonifica, secondo molti analisti sarà soprattutto una “vetrina” per attrarre grandi investimenti privati sulla rigenerazione, e ancor di più uno strumento per modificare gli indirizzi urbanistici esistenti e aggirare i vincoli ambientali. Una direzione che mostra tutta la difficoltà dell’intera classe politica locale e nazionale nell’immaginare per questo territorio un modello che vada oltre la politica dei grandi eventi e i tentativi di attirare grandi investitori privati costi quel che costi.
In un recente articolo pubblicato su Altreconomia, per esempio, la studiosa di politiche urbane Lucia Tozzi ha mostrato come la coppa sia tutt’altro che un affare dal punto di vista economico, tanto che Napoli sembra essere stata scelta anche per l’assenza di concorrenti. Barcellona e Valencia, che avevano ospitato le ultime edizioni, hanno rinunciato dopo grandi polemiche sullo spreco di risorse pubbliche causato dalla manifestazione. Le squadre più importanti delle ultime edizioni, intanto, a cominciare dalla statunitense American Magic, stanno via via annunciando che non parteciperanno all’edizione napoletana.
Dal disastro politico a quello ambientale
Benedetto De Vivo, geologo e professore ordinario di geochimica ambientale, a proposito del dragaggio dei sedimenti marini vicino alla colmata, necessario per far svolgere la competizione, ha scritto che nell’area ci sono sostanze inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici e pliclorobifenili) che è pericoloso smuovere, perché “combinandosi con il cloro, producono diossine, ovvero sostanze cancerogene” e “se si combinano con lo stagno o il mercurio, formano altre sostanze cancerogene di prima categoria”: dibutilstagno, tributilstagno e metilmercurio.
Le operazioni per l’avvio della Coppa America, in sostanza, rischiano di creare un disastro ambientale di cui nessuno sembra voler rispondere. La direzione generale valutazioni ambientali del ministero dell’ambiente, anzi, ha dato il via libera alla “procedura sprint”, grazie alla quale si eviterà persino il rilascio della valutazione di impatto ambientale.
Quella flegrea è, infine, una terra vulcanica, e in questo complesso intrecciarsi di questioni urbane e ambientali il bradisismo potrebbe costituire un ulteriore elemento per una “rigenerazione insostenibile”: “Dopo una prima fase di abbandono del quartiere da parte di quegli abitanti che non hanno ricevuto nessun aiuto economico per sostenere i danni provocati dalle scosse”, spiegano gli attivisti dell’Assemblea popolare, “solo oggi il ministro per la protezione civile annuncia un miliardo e mezzo di finanziamenti dalla Banca europea per gli investimenti, per interventi di miglioramento sismico. L’impressione è che, senza strumenti per garantire agli abitanti storici del territorio di rimanere, si andrà verso un restyling degli immobili a beneficio di chi può spendere e consumare di più”.
Verso le elezioni
La mattinata novembrina è ormai agli sgoccioli, con l’orologio del circolo che segna quasi le tredici. L’inaugurazione della mostra fotografica è terminata, il sole scalda ancora la terrazza, e i manifestanti non sembrano intenzionati ad andarsene. Al megafono c’è di nuovo Aldo Velo, con i suoi capelli bianchi e il portaocchiali della Fiom, che insieme a pochi altri rappresenta la memoria operaia del territorio.
I vecchi caschi gialli e gli attivisti più giovani vorrebbero un modello di sviluppo diverso, meno aggressivo, che tuteli i grandi spazi pubblici come il bosco, la spiaggia e il grande Parco dello sport, e freni l’assalto turistico. È una lotta difficile in un quartiere dove si vive in un limbo senza certezze, tra il rischio di trovarsi fuori di casa per una scossa di terremoto o perché l’area, invece di diventare più sicura, diventerà troppo costosa.
Passerà ancora un po’ di tempo prima che il gruppo di manifestanti si incammini verso il centro di Bagnoli, mentre qualcuno riferisce dai social media le prossime iniziative in vista delle elezioni regionali. Il favorito per la carica di presidente è Roberto Fico, sostenuto dai cinquestelle, dal Partito democratico e dal sindaco-commissario Manfredi. È già stato da queste parti e ha annunciato che tornerà presto. Il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è stato alla Mostra d’Oltremare il 14 novembre con Giorgia Meloni, la presidente del consiglio che, in un modo o nell’altro, può vantarsi di aver “sbloccato Bagnoli”. Su come andare avanti, a dispetto di ciò che vorrebbero gli abitanti, le forze politiche sembrano essere tutte d’accordo.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it