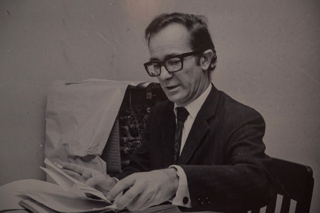Nel cuore della foresta di argan, a trenta chilometri dalla costa occidentale del Marocco, c’è la cooperativa di donne Tamount. È lontana dai circuiti turistici e i visitatori di passaggio sono pochi. Appese alle pareti ci sono le foto del re Mohammed VI, mentre un manifesto spiega le tappe della lavorazione dei frutti di argan e della produzione dell’olio.
“All’inizio eravamo 33 donne, oggi siamo 21”, dice Taraabt, presidente della cooperativa. “Quando le cose andavano bene vendevamo 480 taniche da 25 litri ogni anno, ora arriviamo a malapena a cento. Esportavamo in Francia, Svezia, Arabia Saudita, Libano. Oggi lavoriamo solo con i turisti, ma gli autobus che arrivano qui sono sempre meno. Non riusciamo a smaltire neanche la quantità già prodotta: sette mesi fa abbiamo fatto un debito di 170mila dirham (circa quarantamila euro) per comprare i frutti. Per ora abbiamo usato metà di questa scorta, ma non abbiamo ancora venduto niente”.
L’albero di argan (Argania spinosa) cresce nel sudovest del Marocco, in un triangolo di terra compreso tra le città di Essaouira, Agadir e Taroudant. Per secoli l’olio prodotto dai suoi frutti è stato usato dal popolo berbero come rimedio tradizionale, prodotto di bellezza o ingrediente per la cucina.
Quando l’industria ha scoperto le sue proprietà salutari e cosmetiche, le aziende internazionali se ne sono improvvisamente interessate: descritto come “oro liquido” dalle riviste di bellezza e di economia, l’olio di argan si trova ora in molti dei prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati.
Il mercato globale dell’olio di argan è in espansione: si prevede che crescerà fino a superare i 700 milioni di dollari entro il 2030, rispetto ai circa trecento del 2022. Il prodotto è pubblicizzato non solo come elisir di bellezza, ma anche come motore dello sviluppo economico, sociale e ambientale delle aree rurali del Marocco, dove le donne, riunite in cooperative lo estraggono con metodi tradizionali. Ma oggi qualcosa è cambiato: il settore è controllato da grandi multinazionali che si riforniscono attraverso intermediari, mentre molte cooperative locali stanno chiudendo.
“Dopo ventidue anni ho dovuto interrompere le attività: continuare a lavorare ci costa più che bloccare la produzione”, racconta Ulysses Müller, imprenditore svizzero che in Marocco ha fondato la società Sidi Yassine, rifornendo marchi come L’Occitane e Weleda. “Ci chiedono di comprare olio di argan a un prezzo che quasi non copre i costi di produzione. Il margine per noi è pari a zero”.
Una tradizione in pericolo
Il frutto dell’argan si presenta come una noce molto dura, che al suo interno contiene alcune mandorle da cui si estrae l’olio. Tradizionalmente la raccolta avveniva manualmente, le donne aprivano una per una le noci spaccandole con due pietre, e poi passavano alla macinazione e alla spremitura.
Con l’aumento della domanda, il governo marocchino ha avviato diversi programmi per sviluppare il settore. Nel 2003 è nato il progetto Arganier, che ha finanziato cooperative produttrici di argan con fondi dell’Unione europea e dell’Agenzia marocchina per lo sviluppo sociale. Nel 2005 il re del Marocco ha lanciato l’Iniziativa nazionale per lo sviluppo umano (Indh), che semplifica la procedura per formare delle cooperative: in pochi anni si è arrivati a contarne più di mille.
Nel 2014 l’argan e il metodo tradizionale di estrazione dell’olio sono stati inseriti nella lista del patrimonio dell’umanità dell’Unesco: è stato il coronamento finale di un processo che in pochi anni ha portato un frutto poco conosciuto come l’argan a diventare un ingrediente onnipresente nei prodotti di bellezza.
Sembrava una gallina dalle uova d’oro, ma nel giro di pochi anni il vento è cambiato: le multinazionali sono entrate nel settore creando una nuova rete di intermediari che hanno conquistato parti sempre più importanti del mercato. Quando si tratta di comprare i frutti “i grandi industriali hanno un enorme potere d’acquisto”, spiega Omar Agodim del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). “Grazie alla loro forza, possono influenzare i prezzi”.
Per estrarre l’olio, queste aziende hanno costruito fabbriche con macchinari che velocizzano il processo: con le economie di scala riescono a mantenere i prezzi bassi, e le cooperative non riescono a reggere la concorrenza.
Non solo: i lockdown decisi per fermare la pandemia di covid-19 hanno favorito chi poteva comprare e conservare grandi quantità di frutti. “Alcuni operatori hanno scelto di accumulare riserve”, spiega Jamila Idbourous, presidente dell’Unione delle cooperative femminili per la produzione di olio di argan. “Solo chi disponeva di certe risorse economiche è riuscito a sopravvivere. I clienti che non potevano più rifornirsi dalle cooperative si sono rivolti agli industriali. Oggi tutti vogliono la loro parte nella catena del valore e c’è sempre meno spazio per le donne, che non hanno mezzi né capitale circolante”.
Nei suq il frutto dell’argan oggi si vende a 13 dirham al chilo (circa 1,2 euro), un prezzo sei volte più alto di prima del Covid. L’aumento si deve anche ai cambiamenti climatici, che hanno influito sulla quantità e sulla qualità delle noci, oggi sempre più piccole.
L’Argania spinosa è un albero molto resistente, che ben si adatta al clima arido della zona, ma la siccità severa che ha colpito il territorio negli ultimi anni ha avuto un impatto molto forte. Si calcola che nell’ultimo secolo la foresta di argan abbia perso circa il 50 per cento della sua superficie totale, cioè 600 ettari all’anno.
Una filiera a beneficio di pochi
Rompere la noce dell’argan è l’unico passaggio della filiera che ancora oggi si fa manualmente: nelle cooperative, le donne impiegate in questa attività lavorano sei giorni su sette, pagate a cottimo in base alla quantità di mandorle che riescono a estrarre. Non sono dipendenti ma socie, eppure non riescono a emanciparsi da una condizione di povertà: molte di loro sono analfabete, e il loro compenso va dai 30 ai 50 dirham per ogni chilo di mandorle prodotte (circa 3-4 euro), senza avere diritto alle ferie o alla malattia.
“Guadagniamo cinquecento dirham al mese quando va bene (meno di ciquanta euro) mentre prima della pandemia arrivavamo anche al doppio”, racconta Amina (nome di fantasia), socia della cooperativa nata all’interno della società Efas. “Se dovessimo sopravvivere con il nostro stipendio non resisteremmo due giorni, per fortuna possiamo contare sull’aiuto dei nostri mariti”.
Lo stabilimento della Efas si affaccia sulla strada principale del villaggio di Aghraisse. Tutto intorno si attorciglia un dedalo di strade sterrate, con case basse in argilla. È qui che vivono quasi tutte le donne impiegate nella cooperativa, tra cui Amina.
L’antropologa Bernadette Montanari, che per anni ha studiato la filiera dell’argan, scrive che “in alcune cooperative, le donne rappresentano semplicemente una forza lavoro, a volte impiegata senza retribuzione”. Mentre la ricercatrice Wendy Perry denuncia che i profitti si fanno soprattutto ai vertici della filiera, con “ricompense irregolari e scarse per il lavoro manuale delle donne”. A beneficiare del modello delle cooperative insomma sarebbero solo le socie con ruoli decisionali, provenienti dalla classe media e con un certo livello di istruzione.
Due mercati paralleli
Oggi l’olio di argan sembra dividersi in due mercati paralleli: il primo è indirizzato all’industria cosmetica e ai supermercati, il secondo è per i turisti. “Nelle pubblicità sono le donne a macinare il prodotto a mano, mentre la verità è che le aziende cosmetiche usano impianti all’avanguardia, capaci di soddisfare precisi standard di qualità”, spiega la professoressa Monique Simmonds, chimica dei Royal botanical gardens di Kew, nel Regno Unito.
Gran parte dell’olio che troviamo in Europa si estrae con metodi molto lontani da quelli tradizionali, che ormai sono relegati a strumento di marketing per attirare visitatori. La fetta maggiore dei guadagni va in realtà a grandi azi che portano la produzione in Europa: la più importante è la francese Olvea, con un fatturato annuo di duecento milioni di euro. Poi ci sono l’olandese ARGANisme, la marocchina ZineGlob e l’israeliana MoroccoOil. Le donne marocchine e le cooperative sono totalmente escluse da questo business.
“Il mercato dell’argan è diventato incontrollabile, le multinazionali hanno un potere enorme e le piccole cooperative non riescono a competere”, spiega Eleonora Jaibi, che in Italia ha fondato la linea solidale Noura Racconti Cosmetici, che usa varie materie prime naturali ma non l’olio di argan. “È molto complesso orientarsi tra i produttori. A differenza di trent’anni fa, oggi tutti conoscono l’argan, ma questo non contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità”.
Dello stesso parere è Luciano Cadelano dell’azienda agrocosmetica italiana Simplement Argan. “I prezzi di mercato sono schizzati alle stelle”, dice. “Oggi le cooperative vendono l’olio puro a 60 euro al litro, mentre la grande distribuzione organizzata vorrebbe pagarlo 20-22 euro al litro, per poi rivenderlo a più di 100. Non è sostenibile”.
Tra i prodotti italiani attenti ai diritti e alla sostenibilità ci sono anche quelli di Altromercato, che per la linea cosmetica Natyr usa l’olio di argan prodotto dal gruppo marocchino Targanine, lo stesso fornitore dell’Oreal e della Basf. Del gruppo fanno parte oggi sei cooperative: una è la Taitmatine, situata a Tiout, nella regione di Agadir.
“Guadagno circa 350 dirham al mese (33 euro), lavoro cinque, sei, a volte sette giorni alla settimana”, racconta Fatima, una delle socie della Taitmatine, mentre cammina sulla strada sterrata che la porta verso casa dopo la preghiera del pomeriggio. “Qualche anno fa era diverso: le donne riuscivano a comprarsi un terreno o una casa grazie al loro lavoro, la cooperativa faceva utili e li redistribuiva. Oggi non si guadagna più”.
Se la situazione è difficile per le cooperative, lo è ancora di più per le donne che non ne fanno parte come Aicha, che per vivere schiaccia le noci di argan a casa sua. L’ampio soggiorno è arredato in modo spartano, i tappeti ricoprono parte del pavimento e da un lato si trovano gli strumenti del mestiere: una pietra grande e una piccola, un cesto di frutta e uno di gusci.
“Se ne avessi l’opportunità, mi piacerebbe lavorare in una cooperativa o crearne una nel mio villaggio”, dice Aicha. Per ora vende direttamente a un grossista che paga 80 dirham (circa 7,50 euro) per cinque chili di mandorle: sa che non sta facendo un buon affare, ma non ha modo di negoziare. “Fin da piccole abbiamo sempre avuto l’olio di argan a casa”, conclude. “Lo producevano le nostre nonne. Ma oggi non lo regaliamo più, non lo mangiamo più e non lo vendiamo più. Tutto ciò che ci resta è il suo profumo”.
Questo articolo è stato realizzato con il sostegno di Journalismfund Europe.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it