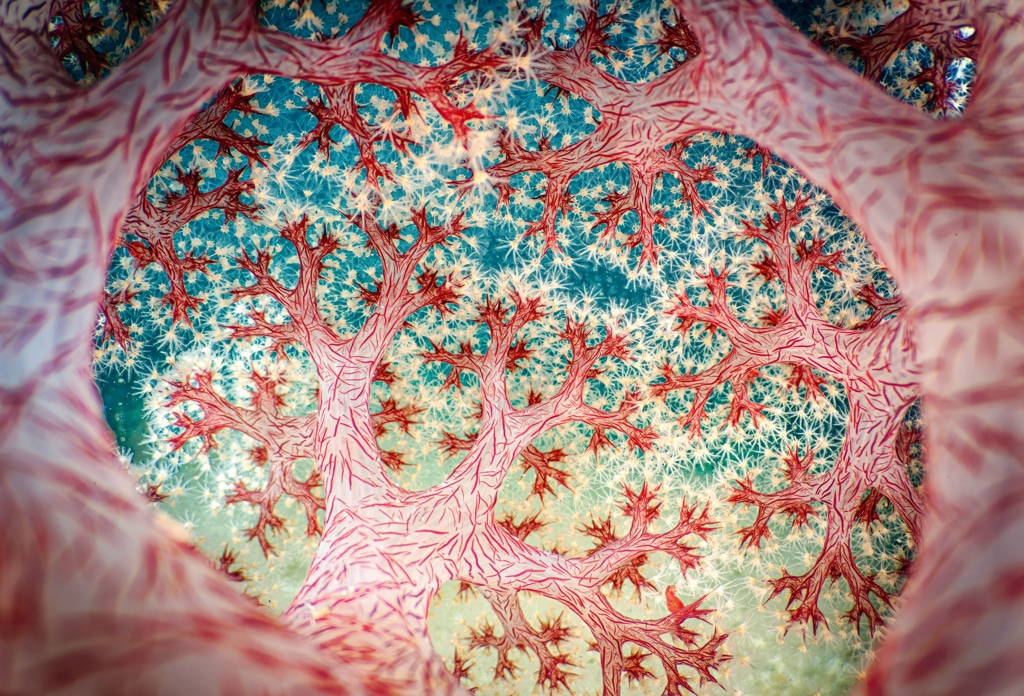Per anni il declino della potenza statunitense è stato raccontato più o meno così: dopo la fine della guerra fredda gli Stati Uniti sono rimasti l’unica grande potenza internazionale, con un’influenza politica, militare e culturale apparentemente impareggiabile; ma a partire dagli anni duemila, a causa di un serie di scelte scellerate, hanno bruciato molto del loro credito e della loro reputazione e hanno portato buona parte del mondo a contestare l’egemonia americana. A quel punto, scossi dalle conseguenze di interventi militari che erano costati migliaia di miliardi di dollari, avevano causato la morte di decine di migliaia di statunitensi e seminato caos geopolitico – e dopo essere stati colpiti duramente dalla recessione globale – hanno cominciato a chiudersi in se stessi.
Negli anni gli esempi della debolezza di Washington si sono moltiplicati – l’impotenza di Obama di fronte al dramma siriano, la fragilità della politica e delle istituzioni davanti alle interferenze russe del 2016, il modo in cui Trump si è fatto portare a spasso dal regime nordcoreano nel suo primo mandato, il disastroso ritiro dall’Afghanistan, la perdita d’influenza in America Latina, l’incapacità di Biden di mettere un freno all’alleato israeliano – mentre le “potenze emergenti” hanno recuperato rapidamente terreno e in alcuni casi colmato il vuoto lasciato da Washington.
Poi è cominciato il secondo mandato di Trump, che in poco tempo, con modi spicci e spesso brutali, ha ricordato quanto possa essere reale ed esteso il potere globale degli Stati Uniti: ha costretto i paesi europei ad aumentare le spese militari, ha ridimensionato l’Iran bombardando i suoi siti nucleari, ha imposto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ha cominciato a minacciare il regime venezuelano, principale spina nel fianco di Washington in America Latina negli ultimi decenni, e molto altro.
A questo punto viene da chiedersi se la spregiudicata iperattività degli Stati Uniti di oggi sia il segno di un ritorno prepotente al ruolo di dominatore internazionale o il colpo di coda di una potenza inevitabilmente in declino, in un contesto geopolitico in cui il baricentro si allontana dall’occidente. Ho trovato qualche spunto interessante in due articoli usciti di recente.
Il primo l’ha scritto Marco D’Eramo, è uscito su Limes e sulla New Left Review. D’Eramo fa notare che i dibattiti sul tramonto dell’impero americano sono cominciati molto prima degli attentati dell’11 settembre 2001, degli interventi in Afghanistan e in Iraq. “Si parla del ‘declino americano’ da prima che io nascessi: un ritornello che accompagna ogni guerra e ogni crisi, con tale frequenza che un arguto commentatore del New Yorker una volta ha osservato che i ‘declinisti’ di oggi dovrebbero cominciare con lo spiegare perché quelli di ieri avevano torto”. Ogni guerra persa, ogni crisi economica o politica ha alimentato la narrazione del “declino”, ma l’America è sempre riemersa più potente.
Tutto il dibattito, secondo l’autore, è condizionato da un malinteso di fondo, molto diffuso soprattutto tra i commentatori europei: l’idea che gli Stati Uniti siano disposti a rinunciare alla loro influenza politica, economica e militare. Per D’Eramo nessuna classe dirigente rinuncia volontariamente al potere. Tutte le fazioni politiche statunitensi continuano ad avere l’obiettivo di conservare e ampliare l’influenza di Washington, per questo si accusano a vicenda di indebolire la posizione del paese nel mondo.
Oggi, per la prima volta da secoli, nessuna nazione cresce abbastanza da cambiare gli equilibri globali
La vera discussione quindi riguarda non se mantenere l’egemonia ma come amministrarla: usando il soft power e i mercati, come propongono i politici e i pensatori liberal, o con l’unilateralismo militare e protezionista del trumpismo.
In questo contesto la politica estera di Trump non rappresenterebbe un’eccezione ma la radicalizzazione del progetto imperiale. La spinta a mettere fine alla globalizzazione non sarebbe un segno di ritirata ma una riconfigurazione: l’impero si chiude a difesa del suo centro, scaricando costi e instabilità sugli alleati. In questo quadro l’Europa, incapace di autonomia, resta subordinata al dominio statunitense, accettando spese militari e politiche economiche imposte da Washington.
D’Eramo conclude che la vera vulnerabilità degli Stati Uniti non nasce da una minaccia esterna ma dall’ipertrofia del loro potere: una potenza tanto estesa da illudersi di poter agire senza limiti, sostenendo un dominio che genera al tempo stesso forza e disordine. La “deglobalizzazione”, la militarizzazione dell’economia e l’imposizione di crisi agli alleati non sono segni di rinuncia, ma di un sistema che si difende dal proprio stesso eccesso. Intanto, una nuova élite globalizzata – i miliardari della tecnologia e della finanza – ha separato il proprio destino da quello degli Stati Uniti, trasformando l’impero in una macchina senza centro politico né coesione sociale. È in questa frattura interna, più che nella competizione esterna, che si manifesta il vero declino americano.
Ascesa inesorabile
Anche il secondo articolo, scritto da Michael Beckley su Foreign Affairs, mette in discussione la narrazione sul declino statunitense, ma prendendola dall’altra faccia della medaglia: la presunta inesorabilità dell’ascesa delle cosiddette potenze emergenti.
Secondo Beckley, sta per concludersi l’“età dei poteri emergenti”, cioè quella fase storica, iniziata con la rivoluzione industriale e durata più di due secoli, in cui l’aumento della produttività, della popolazione e della potenza militare ha alimentato l’ascesa geopolitica di nuovi attori internazionali. “Oggi, per la prima volta da secoli, nessuna nazione cresce abbastanza da cambiare gli equilibri globali. La produttività ristagna, le popolazioni invecchiano e le conquiste territoriali sono sempre più costose e impraticabili”.
La Cina, ultimo grande paese “in ascesa”, ha raggiunto il suo apice: l’economia rallenta, la popolazione cala, il debito esplode e la crescita è sostenuta da investimenti improduttivi e sovvenzioni pubbliche. Il suo modello, fondato sull’autarchia e sul controllo statale, mostra gravi limiti, tra cui scarsa istruzione, crisi immobiliare e consumo interno debole. Allo stesso tempo, gli altri centri di potere – Europa, Russia, Giappone – vivono una declino demografico e tecnologico. L’India ha una popolazione giovane, ma non dispone del livello di istruzione, delle competenze e delle istituzioni necessarie per trasformare questa risorsa demografica in un vero punto di forza. Intanto i paesi del sud del mondo sono gravati da debiti, instabilità, guerre e disoccupazione giovanile.
Gli Stati Uniti avranno sempre più problemi a causa del debito pubblico e della polarizzazione politica; inoltre la linea di Trump su aiuti esteri e commercio rischia di far allontanare alcuni alleati. Ma, sostiene Beckley, restano il solo paese con fondamenta solide: hanno un grande mercato interno, un livello molto alto di innovazione, energia a basso costo e un vantaggio strategico in settori chiave come intelligenza artificiale e i semiconduttori. E intanto il dollaro continua a dominare le riserve mondiali, il settore bancario e il mercato dei cambi.
Per Beckley siamo entrati in una fase di “stagnazione” dell’ordine internazionale. Una situazione che nel breve periodo può alimentare una serie di minacce: la militarizzazione delle potenze in declino (come Russia e Cina), il collasso di stati fragili in Africa e Medio Oriente e l’ascesa delle forze illiberali nelle democrazie occidentali, alimentata da disuguaglianze e crisi migratorie.
“Ma nel lungo periodo la stagnazione potrebbe avere effetti positivi, riducendo il rischio di guerre simili a quelle che hanno segnato l’ottocento e il novecento: senza potenze emergenti pronte a sfidare quelle dominanti, diminuisce la probabilità di conflitti globali. L’invecchiamento, inoltre, potrebbe favorire quella che alcuni studiosi definiscono ‘pace geriatrica’: le società più anziane sono meno inclini all’aggressione e più concentrate sul benessere interno”.
Questo testo è tratto dalla newsletter Americana.
|
Iscriviti a Americana |
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Americana
|
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it