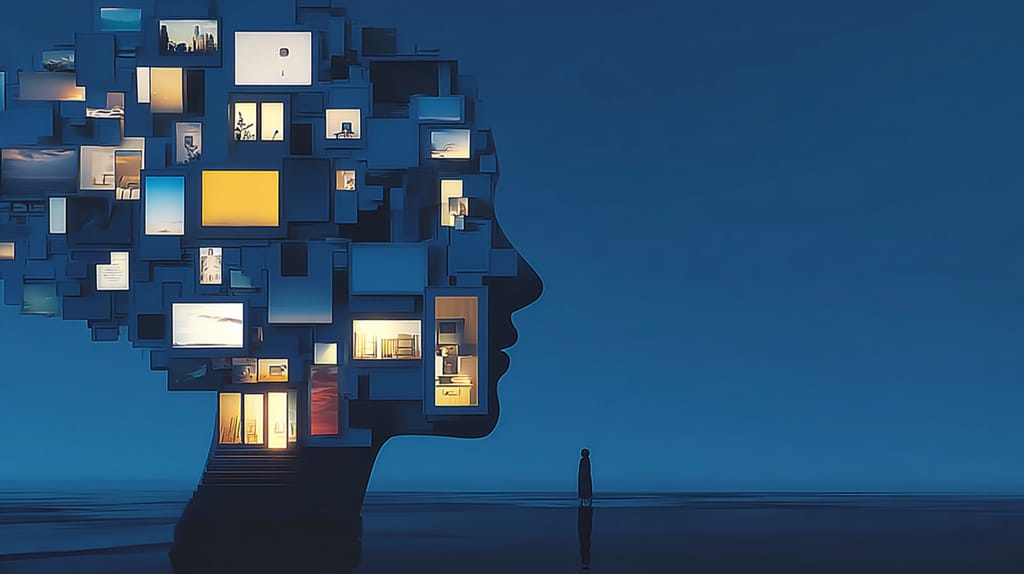Se ci chiedessero di rispondere d’istinto alla domanda “come stiamo usando le intelligenze artificiali”, molte persone direbbero: per non lavorare, per trovare scorciatoie, affidarci a oracoli, barare, copiare e così via. Abbiamo letto che la Deloitte ha consegnato al governo australiano un rapporto che conteneva alcuni errori perché era stato fatto con un uso improprio delle intelligenze artificiali generative e così, immediatamente, generalizziamo. Il problema è che quello è un fatto eclatante: fa notizia perché ha tutte le caratteristiche per indignare, stupire e suscitare emozioni negative. Eppure dovremmo sapere che generalizzare non è mai una buona idea: i dati, infatti, raccontano una storia molto diversa.
La Anthropic e la OpenAi, che producono rispettivamente i modelli Claude e ChatGpt, hanno pubblicato due studi che raccontano come vengono usati i loro strumenti. Sono due ricerche complementari, condotte tra la fine del 2024 e l’estate del 2025 analizzando milioni di conversazioni reali. Entrambe le aziende garantiscono che la privacy delle conversazioni analizzate è stata tutelata: dicono che nessun essere umano ha letto i messaggi delle persone e che le chat sono state anonimizzate, aggregate e poi trattate attraverso sistemi di sicurezza che impediscono di risalire ai singoli individui.
La Anthropic ha usato un’infrastruttura chiamata Clio, un ambiente di analisi chiuso che consente di osservare tendenze collettive senza violare la riservatezza dei dati. La OpenAi ha usato una data clean room, un ambiente digitale anonimizzato, per studiare campioni casuali di messaggi inviati da chi usa ChatGpt.
Uso collaborativo
Lo studio della Anthropic su Claude è di nicchia: il modello è usato da trenta milioni di persone tutti i mesi, un numero ristretto su scala globale. L’uso del modello si concentra nelle professioni che richiedono pensiero analitico, precisione, capacità di scrittura. Il 37 per cento delle conversazioni riguarda lavori informatici o matematici, un altro 10 per cento l’arte, il design e i mezzi di comunicazione. Le richieste di aiuto per lavori manuali o fisici, al contrario, sono quasi completamente assenti: è un dato coerente con la natura di queste macchine, che producono oggetti digitali e non hanno corpo.
Solo il 43 per cento delle interazioni ha fatto fare alla macchina un lavoro da zero: comporre un’email, generare codice. Il resto, la maggioranza, rientra in un uso di tipo collaborativo: le persone chiedono a Claude di migliorare, correggere, lo usano come strumento di revisione e apprendimento. È una forma di aumento delle capacità umane, più che di sostituzione: alcune operazioni, quando possibile, vengono automatizzate, altre diventano più rapide grazie alla collaborazione con la macchina.
Nei ruoli in cui serve una preparazione medio-alta dell’uso di strumenti digitali, — per esempio programmatrici, ricercatori, designer — l’uso delle ia è più frequente e più efficace. Al contrario, nelle professioni che richiedono presenza sul campo, relazione e cura, dalle mansioni manuali alla chirurgia specialistica, la presenza dell’ia è praticamente nulla.
Il rapporto della OpenAi su ChatGpt racconta un’altra storia, più quotidiana, perché ChatGpt è il chatbot più diffuso nel mondo. Alla fine di luglio del 2025 la piattaforma contava settecento milioni di utenti attivi alla settimana: circa il 10 per cento della popolazione adulta mondiale. Ogni settimana vengono inviati a ChatGpt diciotto miliardi di messaggi. Ma la maggior parte di queste conversazioni non riguarda il lavoro. Nel giugno del 2025, il 70 per cento dei messaggi era classificato come “non professionale”: consigli pratici, curiosità, dubbi personali, conversazioni su scuola, salute, cucina, viaggi. Solo il 27 per cento aveva a che fare con compiti professionali. A metà del 2024 la quota di uso lavorativo era ancora superiore al 50 per cento anche su ChatGpt. Dopo un anno la proporzione si è rovesciata,
ChatGpt, in sostanza, è diventato molte cose diverse: una specie di allenatore per studio e riflessione o un’alternativa al motore di ricerca. Quasi l’80 per cento delle interazioni, infatti, rientra in tre grandi categorie: guida pratica, scrittura e ricerca di informazioni. ChatGpt è stato usato anche come correttore di bozze, consulente, insegnante paziente. L’uso più diffuso resta, sì, quello legato alla scrittura e alla produzione di testi, ma non necessariamente alla scrittura professionale. E anche qui, come per Claude, le persone non chiedono testi pronti all’uso, ma modifiche, sintesi, traduzioni, valutazioni. Si delega meno, si collabora di più.
Fare meglio
Il cambiamento che si può notare, poi, non è solo tecnico ma è anche sociale. Nei primi mesi del 2023 la maggioranza delle persone che usavano ChatGpt erano maschi. Oggi c’è molto più equilibrio, con una leggera prevalenza femminile, come ci si dovrebbe aspettare da una tecnologia diffusa quasi universalmente. Le persone più giovani lo usano molto per studiare, le più anziane per lavoro o per consultare informazioni. Cresce anche l’uso nei paesi a reddito medio, dove la chat potrebbe diventare anche una forma di istruzione e apprendimento accessibili.
Anche il tipo di domande è cambiato. Nelle conversazioni analizzate, quasi la metà rientra nella categoria asking, cioè richieste di spiegazioni o di orientamento. Il 40 per cento, invece, chiede di fare qualcosa: scrivere, programmare, riassumere.
In altre parole, non stiamo chiedendo alle macchine di lavorare al posto nostro, come temono in molti, ma di aiutarci a fare meglio. È un passaggio culturale importante, che va dall’esecuzione alla conversazione e che sconfessa molte delle paure dei catastrofisti.
Ci sono i rischi, ovvio. Ma, a giudicare da questi studi e dal modo in cui vengono usati questi strumenti, spontaneamente e senza che le persone abbiano una preparazione pregeressa, il rischio più grosso è spaventare tutti, vietare. Abilitarci a usare le macchine, conoscendone i problemi e i punti di forza, è un’idea più interessante dei divieti. Anche perché le intelligenze artificiali non scelgono le domande e non ci obbligano ad accettare le loro risposte.
Questo testo è tratto dalla newsletter Artificiale.
|
Iscriviti a Artificiale |
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Artificiale
|
|
Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it