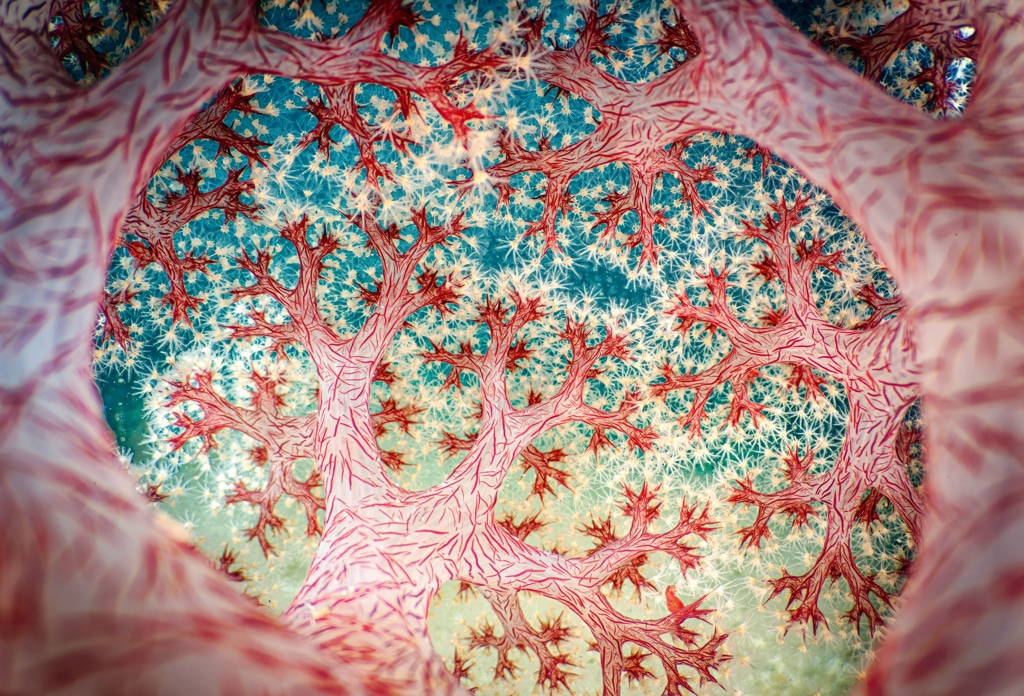L’artista si gira una sigaretta e mi stringe la mano. È molto cordiale. “Dico ai miei figli che fumare è una cosa di un’altra epoca, dei nonni. Una cosa che non appartiene al tempo presente. E loro ridono”. Con i suoi baffi, sembra il figlio segreto di Georges Clemenceau e Pierre Vassiliu. Ha un aspetto un po’ desueto, il tipo che avrebbe potuto interpretare un ladro di biciclette in un film degli anni settanta, con divani in pelle, moquette alle pareti e colonna sonora di Piero Umiliani. Lui si difende da ogni feticismo del passato. È troppo intelligente per cadere in questa trappola, e troppo coinvolto nei cambiamenti del mondo. Il suo mondo.
Chi è? È Andrea Laszlo De Simone, musicista italiano, che stranamente i miei amici italiani non conoscono, ma che da questa parte delle Alpi è venerato. Lo incontro a Parigi, all’inizio di luglio, nella sede della Ekler & Hamburger Records, la sua etichetta francese: un luminoso museo pop vintage, situato all’ultimo piano di un edificio nel X arrondissement. Mi scuso perché non parlo la lingua di Pasolini; lui preferisce ricorrere al francese, che parla con un accento affascinante, e la presenza di un’interprete compensa qualche lacuna. “Dopotutto, sono io che vengo in Francia, è normale che mi adatti”, si giustifica. Scommetto che se fossi andato a casa sua, mi avrebbe detto la stessa cosa, sostenendo che, in quanto ospite, era il minimo che potesse fare per accogliermi.
De Simone vive alla periferia di Torino. Dopo il tour promozionale in Francia per l’uscita di Una lunghissima ombra, il suo nuovo album pubblicato il 17 ottobre, tornerà in Italia per trascorrere l’estate con la sua famiglia su una spiaggia in Abruzzo. Ma oggi prende molto sul serio questo incontro, che continuerà ad allontanarsi dall’argomento del disco a favore di grandi riflessioni sul tempo, la creazione e il progresso. Una serie di riflessioni cupe, a tratti, ma mai opprimenti. Lui quasi se la gode. Alla domanda se abbia nostalgia di un tempo perduto, più indolente, come potrebbe far pensare la materia anacronistica della sua musica, molto orchestrale e apparentemente rétro, risponde di no, proprio per niente: “Guardo sempre avanti e sono felice ogni mattina. Dev’essere insopportabile, tra l’altro. T’immagini cosa vuol dire svegliarsi ogni giorno accanto a qualcuno che è sempre contento?”.
Facciamo un passo indietro: è grazie all’uscita dell’ep Immensità, nel 2019, che ho scoperto il lavoro di questo musicista autodidatta, che all’epoca aveva già all’attivo due album, Ecce homo (2012) e Uomo donna (2017). L’oggetto è l’equivalente discografico di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, una specie di tentativo sereno e grandioso di misurare l’universo racchiudendolo in un 33 giri, fonte inesauribile di meraviglia.
“Come la cucina o la falegnameria, la musica è un’arte che pratico con tutta la passione del mondo”
La musica dei ricordi
De Simone non ascolta quasi mai musica. Di recente ha scoperto gli Air grazie al figlio piccolo, e i giornalisti eruditi, fan di Lucio Battisti, hanno tentato invano di parlare di italo-pop. Chiedergli quali artisti lo abbiano ispirato, quindi, è inutile: “Non è una questione di ego mal riposto, è solo che per me la musica non è qualcosa da ascoltare, ma qualcosa da fare. Mi dico che, quando sarò più vecchio, quando non avrò più idee o quando la passione sarà svanita, avrò l’occasione di leggere tutti i libri, vedere tutti i film e ascoltare tutti i dischi del mondo. E sarà meraviglioso”. E continua: “La mia musica è soprattutto piena dei miei ricordi”.
Non riesco a credergli. Irmin Schmidt, tastierista del gruppo rock tedesco Can, mi aveva detto la stessa cosa parlando del suo brano Rapido de noir, in cui evocava, attraverso artifici strumentali che riproducevano il rumore lancinante dei binari, i viaggi in treno notturno della sua infanzia. Tuttavia, a differenza di Irmin, De Simone non è un discepolo di Stockhausen, e l’unica discendenza a cui si ricollega è strettamente familiare: anche suo fratello è musicista e suo padre, fotografo amatoriale, gli ha fatto scoprire un intero filone del cinema italiano. “Mio padre e io siamo professionisti, solo che il nostro modo di imparare e creare è empirico. Secondo me la professionalità non vuol dire il dominio della tecnica, ma l’idea che potresti morire per ottenere il risultato che cerchi di raggiungere. Come la cucina o la falegnameria, la musica è un’arte che pratico con tutta la passione del mondo”.
Il suo primo strumento è stato la batteria. Non per una passione per il ritmo, ma per l’illusione di dominare il tempo, dice. “L’unica frustrazione, quando componi alla batteria, è l’assenza di melodia. Ma hai il potere di fare delle pause e quindi di creare movimento. L’importante è il movimento”, precisa. È l’effetto che produce la sua musica, in particolare l’ultimo album: una massa cosmogonica che si muove nello spazio e che, con frammenti di registrazioni ambientali, sembra scorrere attraverso il tempo in un flusso della memoria.
Nel cinema
In passato De Simone lavorava come montatore per video istituzionali, clip musicali e documentari. Non ha mai abbandonato il rapporto con le immagini, dal punto di vista esistenziale e professionale. Nel 2023 ha firmato la colonna sonora dell’ultimo film di Thomas Cailley, The animal kingdom: “Non volevo legarmi a una casa discografica. Lavoravo di giorno e componevo di notte, un equilibrio che mi andava benissimo. Mescolare lavoro e passione mi spaventava, temevo che diventassero la stessa cosa. Ma poi ho capito che la musica poteva rimanere la mia passione. Il mio lavoro ora è venderla”.
Oltre la vetrata che ci separa dalla stanza accanto, indica con il dito il suo amico e manager, Daniele Citriniti, che ricambia il saluto: “È lui che ha fatto ascoltare la mia musica, senza dirmelo. Abbiamo litigato molto. Ma oggi lo ringrazio”. Non riesco a immaginarlo mentre litiga. “Se c’è una cosa che la musica permette è l’instaurazione di un regime autoritario. E quando si tratta di creazione musicale sono il peggiore degli autocrati. Nessuno mi tratterebbe mai come mi tratto in studio. Nella vita, ovviamente, sono profondamente democratico, con una tendenza comunista”, ride.
De Simone ha rinunciato al palcoscenico dopo i suoi ultimi due concerti, tenuti il 1 e 2 dicembre 2021 al Trans Musicales di Rennes, che hanno lasciato molti a bocca aperta. “I musicisti avevano studiato minuziosamente tutte le parti che avevo scritto, con rispetto e attenzione, senza cercare d’intervenire per cambiare nulla. Li ringrazio per non avermi messo in una posizione di dominio, perché non sono in grado di dire di no e, allo stesso tempo, non sarei in grado di tollerare il minimo cambiamento”.
“Tornando a Rennes, non sono mai riuscito a formalizzare ciò che quelle due serate hanno rappresentato per me, se non che sono un ricordo molto bello”, aggiunge il cantautore. “Non sono né un attore né un interprete. Sul palco so solo essere me stesso, e questo può essere difficile, data la mia timidezza. Non ho il narcisismo necessario per questo esercizio. O diciamo che, se sono narcisista, non è lì che si manifesta. E poi, come tutte le cose un po’ speciali, è un’attività che non puoi fare tutti i giorni. Il rischio, con il palcoscenico, è che diventi qualcosa di normale, poi noioso e infine assurdo, per cui sei costretto a diventare un interprete. Come un animale in un circo. Io sono più felice in studio e con i miei figli”.
◆ 1986 Nasce a Torino.
◆ 2006 Suona la batteria nella band Nadàr Solo, che ha fondato insieme al fratello.
◆ 2017 Pubblica con l’etichetta 42 Records l’album Uomo donna, acclamato dalla critica italiana.
◆ 2024 Vince il Premio César, prestigioso riconoscimento dell’industria cinematografica francese, per la colonna sonora del film The animal kingdom di Thomas Cailley.
La discussione devia dal disco e ci porta sul terreno della ricerca della verità nella creazione: “Se ora sostenessi che esiste una verità, sembrerei quasi religioso e dogmatico; se ti dicessi che non esiste, potresti accusarmi di mentire. Penso che l’onestà sia un valore molto più importante della verità. Prendiamo l’ultimo album: è personale, ma non autobiografico. Allora, cosa conta di più? La verità o l’onestà? Se è autobiografico, è solo dal punto di vista del ricordo delle emozioni. Tutte le mie canzoni più positive sono state scritte quando ero triste, perché avevo bisogno di consolazione. E viceversa, quelle più tristi sono state registrate quando ero in grado di sopportare la gravità del dolore”.
Cambia il messaggio
Verità e autoritarismo, due linee oblique che attraversano la nostra epoca. Negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Italia, dove Giorgia Meloni ha messo le grinfie sulle istituzioni culturali del paese. Ci vuole un bel po’ di canzoni tristi per sopportare il dolore in circostanze simili.
Gli chiedo se vuole parlare dello spettro del fascismo che minaccia il suo paese, lui che poco prima mi diceva di definirsi comunista. Senza citarmi direttamente Antonio Gramsci, che forse ha letto al liceo, De Simone mi espone una teoria vicina al concetto di egemonia culturale coniato dal filosofo italiano: “Stiamo assistendo alla scomparsa della sinistra e dei suoi ideali perché non possono più essere diffusi attraverso questo strumento che rifiuta il pensiero complesso”, afferma indicando il suo telefono. “La destra, al contrario, può usare questi strumenti, perché il suo messaggio è profondamente populista. Abbiamo rinunciato alla nostra privacy e, di conseguenza, i valori della libertà sono cambiati: abbiamo la libertà di vedere quello che vogliamo e di acquistare quello che vogliamo, ma abbiamo trascurato la libertà di pensiero, fornendo tutti i dettagli della nostra esistenza intima a macchine che hanno come obiettivo la manipolazione. È letteralmente l’eredità del fascismo. Quando cambia la qualità del messaggio, cambia il mondo”.
La qualità del messaggio può essere compromessa, ma la qualità del desiderio di Andrea Laszlo De Simone potrebbe ristabilire una parvenza di equilibrio. Dopo quasi due ore di discussione, mi stringe di nuovo la mano e va a girarsi un’altra sigaretta. “Lo so bene / La vita è breve e pure stretta / Ma la tua mente è una grande sarta / Che cuce in fretta / Il tempo di una sigaretta”, cantava in Vivo, un brano pubblicato durante la pandemia. Dietro i suoi baffi, lo sguardo perso nell’immensità, De Simone ricama un mondo migliore. Fumare salva, in fin dei conti. ◆ adg
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1640 di Internazionale, a pagina 74. Compra questo numero | Abbonati