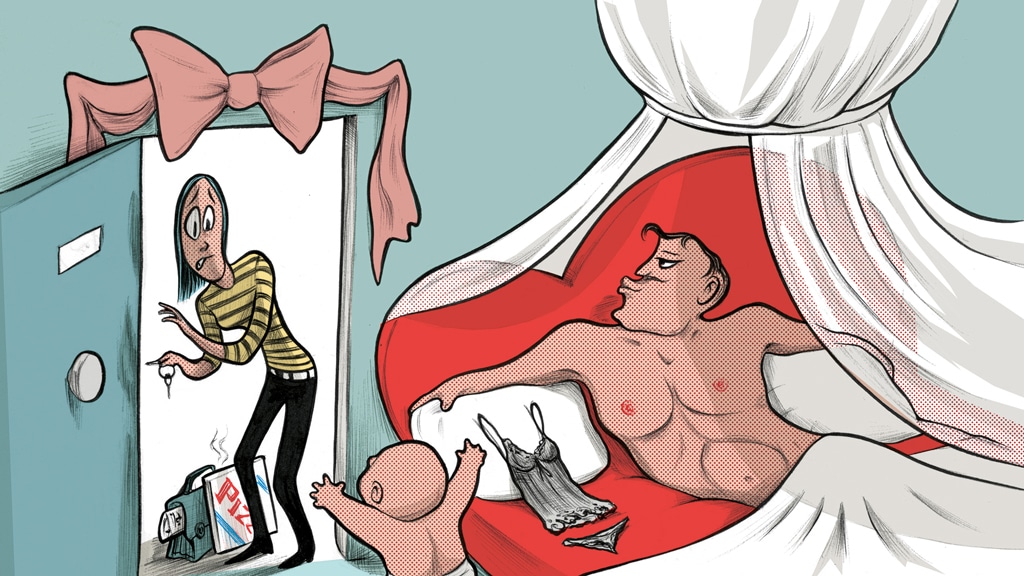Il primo ministro Shinzō Abe ha annunciato le dimissioni a causa del peggioramento del suo stato di salute. In questo modo fa calare il sipario sul suo governo con una mossa improvvisa, in un momento in cui l’esecutivo fatica a rispondere alla pandemia e sembra arrivato a un’impasse.
Il 28 agosto, durante una conferenza stampa, Abe ha spiegato che a giugno sono emersi segnali di un ritorno della colite ulcerosa di cui soffre fin da ragazzo. Di fronte alla necessità di gestire la crisi del covid-19, la decisione di Abe era inevitabile. La risposta del suo governo alla pandemia ha vissuto fasi alterne. Le mascherine in tessuto inviate per posta alle famiglie – soprannominate ironicamente sui social network Abenomask in riferimento alla Abenomics, la politica economica promossa dalla sua amministrazione – e il video pubblicato sul Twitter in cui il primo ministro si rilassa nella sua casa elegante mentre la popolazione viene invitata a non uscire per evitare i contagi, hanno suscitato forti critiche. Il bonus da 100mila yen (800 euro) promesso a tutti i cittadini è stato rinviato dopo alcune modifiche al piano originale.
In estate il Giappone ha registrato un aumento dei casi di covid-19 che ha raggiunto l’apice alla fine di luglio. Ma negli ultimi mesi Abe ha fatto ben poco per contrastarlo. Durante le sessioni regolari della dieta (il parlamento), il governo Abe ha stanziato diecimila miliardi di yen per la lotta contro la pandemia, ma non ha accolto la richiesta dell’opposizione di fornire un piano di spesa prima della chiusura delle attività parlamentari a giugno. L’opposizione ha chiesto la convocazione di una sessione straordinaria, ma la coalizione di governo l’ha respinta e non ha permesso al primo ministro di partecipare alle riunioni fuori sessione.
Mentre il virus continuava a diffondersi alimentando la preoccupazione dei giapponesi, per quasi settanta giorni Abe non ha organizzato neanche una conferenza stampa per parlare dell’epidemia. Nei sondaggi più del sessanta per cento degli intervistati ha dichiarato di non apprezzare la risposta del governo all’emergenza sanitaria. Le dimissioni di Abe arrivano in un momento in cui la fiducia nei sui confronti è in forte calo.
Pochi risultati dall’Abenomics
Da quando è tornato al governo, nel 2012, Abe ha guidato l’esecutivo per 2.800 giorni consecutivi, diventando il primo ministro rimasto in carica più a lungo nella storia del paese. La sua permanenza al potere ha messo fine a un periodo di caos in cui sei primi ministri si erano dimessi ognuno dopo circa un anno di mandato. La prima esperienza da premier di Abe si era conclusa poco dopo che aveva invitato il paese a “lasciarsi alle spalle il regime postbellico”. Imparando da quell’amara lezione, nel secondo mandato si è concentrato sulla ripresa economica, allontanandosi dalle campagne ideologiche. Questo gli ha fatto guadagnare l’appoggio dei giapponesi.
Mettendo l’accento sull’economia attraverso il lancio dell’Abenomics, il cui obiettivo era quello di mettere fine alla deflazione, Abe è riuscito a mantenere un consenso stabile. L’aver portato il Partito liberaldemocratico (Pld) a sei vittorie elettorali consecutive, incluso il trionfo nelle elezioni per la camera del 2012 con cui ha riconquistato la maggioranza, è stata la forza motrice della sua amministrazione. In seguito l’opinione pubblica si è divisa sia sulla modifica della legge sulla difesa, che ha autorizzato le forze armate a intervenire all’estero in aiuto di paesi alleati, sia sull’introduzione della legge per la protezione del segreto di stato. In entrambi i casi il governo ha potuto imporsi alla dieta grazie alla maggioranza in entrambe le camere.
Di recente, però, la situazione di stallo ha gettato un’ombra sul modo in cui il governo Abe ha gestito la politica interna e la diplomazia. L’impasse è diventata evidente con la mancanza di risultati apprezzabili dell’Abenomics. Da un anno e mezzo il Giappone è entrato in recessione, e nonostante Abe avesse promesso di “risolvere definitivamente le questioni diplomatiche postbelliche”, il suo governo non è riuscito a trovare soluzioni per problemi come quello dei cittadini giapponesi rapiti dalla Corea del Nord negli anni ottanta e la disputa con la Russia sulle isole Curili.
Nel frattempo il conflitto tra il governo di Tokyo e la prefettura di Okinawa si è inasprito a causa del trasferimento di una base aerea statunitense da una zona all’altra dell’isola. Inoltre Abe non è riuscito a portare avanti il dibattito sulla riforma della costituzione, un obiettivo che ha perseguito per anni.
Un altro effetto negativo del lungo governo di Abe, durato sette anni e otto mesi, è la distorsione nata dal potere del primo ministro. I burocrati più anziani si sono abituati a ingraziarsi il governo anticipandone le richieste. Esempi di questo fenomeno sono la vendita di terreni a un prezzo fortemente ridotto al proprietario della scuola di Osaka Moritomo gakuen, legato alla moglie di Abe, e la festa annuale della fioritura dei ciliegi organizzata dal primo ministro, a cui nel 2019 sono stati invitati, a spese dei contribuenti, molti esponenti delle organizzazioni locali che sostengono Abe. Quando il primo ministro è stato accusato di aver usato il suo potere per ottenere guadagni personali, come nello scandalo della Moritomo, i documenti pubblici sconvenienti sono stati modificati o eliminati.
La tendenza di Abe a indebolire il parlamento è stata evidente. Il primo ministro ha mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dell’opposizione e non ha voluto ascoltarne le obiezioni, sottraendosi al dibattito su cui basa la democrazia.
Anche se è riuscito a mantenere il potere per molti anni, Abe lascia un’eredità negativa in termini di azione politica e stile di governo. Presto il Pld sceglierà il prossimo presidente. Con la crisi sanitaria che incombe è indispensabile selezionare al più presto il nuovo leader. Il problema è che la guida del paese non dovrebbe essere scelta con trattative a porte chiuse.
Il Giappone è alle prese con diverse sfide, tra cui ridare impulso a un’economia colpita dalla pandemia e una situazione internazionale sempre più imprevedibile a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. È essenziale creare, attraverso un dibattito aperto, un nuovo modo di governare per affrontare nel modo migliore le emergenze del paese. ◆ as
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1374 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati