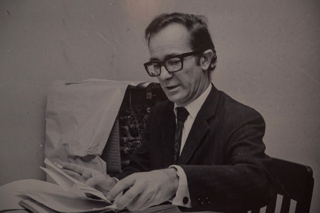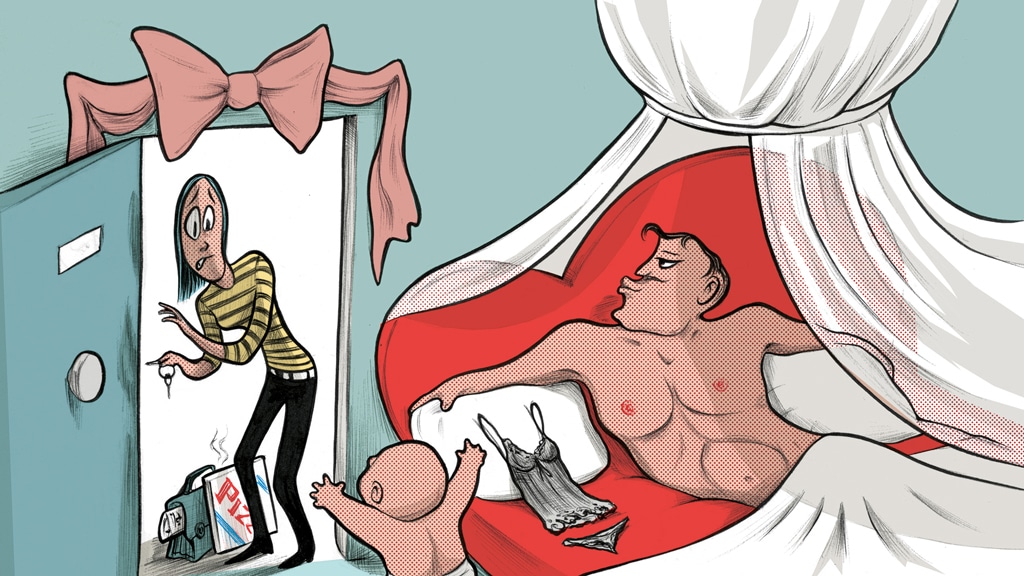Sono tempi complicati per la letteratura. Di anno in anno le vendite dei libri diminuiscono, aggravando una situazione che è peggiorata dopo i buoni numeri registrati durante la pandemia di covid-19. La centralità di romanzi e saggi nel consumo culturale è da tempo messa in discussione da altri prodotti, a partire dalle serie tv. Lo è anche quella degli intellettuali, la cui voce davanti alle tragedie di oggi rimane inascoltata, come ha scritto la giornalista turca Ece Temelkuran. Inoltre, l’azione predatoria dei social network sulla nostra attenzione, insieme alla possibilità di essere sempre esposti agli stimoli che ci arrivano da internet, ha ridotto di gran lunga il tempo e la capacità di concentrarsi su letture lunghe e complesse.
“Oggi la natura della lettura è cambiata”, ha scritto Joshua Rothman sul New Yorker in un saggio piuttosto discusso (online, ovviamente). Molti leggono ancora libri e giornali di carta, ma altri ci rinunciano per trascorrere “le serate su Apple news e Substack, prima di lasciarsi trasportare dal fiume pigro di Reddit”. Inoltre, “la presenza in agguato di YouTube, Fortnite, Netflix e altre piattaforme fa sì che, una volta cominciato a leggere, bisogna continuamente scegliere di non interrompersi”.
Secondo alcuni studiosi si sarebbe addirittura chiusa la cosiddetta parentesi Gutenberg, cioè l’epoca inaugurata dall’invenzione della stampa. Lo storico Walter Ong sostiene che ci sia un ritorno a una sorta di “oralità secondaria”, caratterizzata da una comunicazione più fluida, decentralizzata e colloquiale. “Invece di leggere libri, ne discutiamo nei commenti”, scrive Rothman. “L’ascesa di podcast, newsletter e meme ha dato credito a questa visione”. Uno qualsiasi delle migliaia di podcast che affollano internet “potrebbe essere interpretato come l’equivalente di un paio di persone attorno a un falò, che trasmettono la conoscenza attraverso la conversazione”.
E allora che posto ha la letteratura in questo nuovo scenario? A questa domanda ha dato una risposta interessante Teju Cole nel suo nuovo libro Carta nera. Scrivere in tempi bui (Einaudi 2025).
Inquadrare Cole non è semplice. Recensendo il suo ultimo romanzo Tremore (Einaudi 2024), il New York Times lo ha definito “romanziere, saggista, critico, fotografo e docente”, aggiungendo che “la maggior parte degli scrittori o degli artisti si accontenterebbe di uno o due di questi titoli”, ma non lui.
Il romanzo Città aperta (Einaudi 2013), costruito sulle digressioni filosofiche e le passeggiate a New York di un personaggio che somiglia molto all’autore, lo aveva fatto conoscere a livello internazionale, spingendo diversi critici ad accostare il suo nome a quello di classici come W. G. Sebald. I suoi lavori fotografici, esposti in tutto il mondo e raccolti in vari libri, somigliano a degli appunti di viaggio, in cui le foto sono spunti per ulteriori riflessioni e digressioni.
Carta nera permette di entrare nella sua testa, facendo intravedere come si formano certe sue idee e analisi. Si va dal reportage al memoir, fino all’elegia per figure chiave come John Berger ed Edward Said. La scrittura non rinuncia al lirismo e ad accenni di enfasi, ma tutto è sempre misurato in nome della chiarezza.
Cole usa il colore nero per parlare di razzismo, ma anche di Caravaggio e di cosa significhi appunto scrivere in tempi bui. Uno dei saggi più belli s’intitola “Portare e farsi portare” e si interroga sul ruolo della letteratura oggi.
La premessa è intrisa di un certo scetticismo: “Si sente spesso dire che i lettori forti sono più saggi o più gentili, che la letteratura genera empatia. Sarà vero? A me non sembra. Avendo osservato la politica estera dei cosiddetti paesi evoluti, non posso davvero fidarmi di nessuna teoria che si compiace della capacità della letteratura di ispirare empatia. A volte mi pare anzi il contrario, che più libri abbiamo a casa nostra, più probabilità abbiamo di bombardare la casa degli altri”.
La letteratura, secondo Cole, lavora a un livello “più infinitesimale”: “Non può porre fine alla persecuzione degli esseri umani o di chi tenta di soccorrerli. La letteratura non ferma le bombe. A prescindere dalla raffinatezza dei contenuti non cambia la mentalità dei piccoli fascisti che ancora una volta infestano il vecchio continente”.
E allora a cosa serve “tutto questo sforzo, questo lavoro, la fatica per trovare la parola giusta, la traduzione ideale? La mia risposta è questa: la letteratura può salvare una vita. Solo una vita per volta”. Cole parla di vite al singolare, ma un passaggio di un codice della Mishnah, uno dei testi fondamentali dell’ebraismo, gli consente di allargare il discorso: “Per le scritture, chiunque distrugga una sola vita è come se avesse distrutto il mondo intero”.
In quella cosa discreta chiamata letteratura, dice Cole, si trovano parole che ricordano “l’importanza di negare le frontiere e di traghettare i miei simili sull’altra sponda, l’importanza di chi porta altrove anche me”. Per capire meglio questa importanza bisogna immaginare di trovarsi in un’emergenza: “Una casa in fiamme, una barca che affonda, un processo, un cammino infinito, il pianeta che cambia. Di fronte al pericolo, non si può pensare solo a se stessi. Bisogna portare, e farsi portare”.
È un’idea che riempie la letteratura di senso, perfino in tempi in cui sembra spinta ai margini. E che può funzionare anche al di fuori delle emergenze. Quel “portare, e farsi portare” di cui parla Cole si può verificare anche nelle cose più minute della vita, nei momenti meno decisivi. Nei giorni di gran confusione di un adolescente, o in quelli di solitudine di un adulto, la letteratura può garantire a tutti, o almeno lasciare intravedere, “un po’ di possibile” per non soffocare, volendo citare il filosofo francese Gilles Deleuze.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it