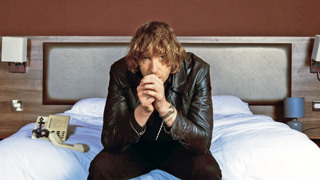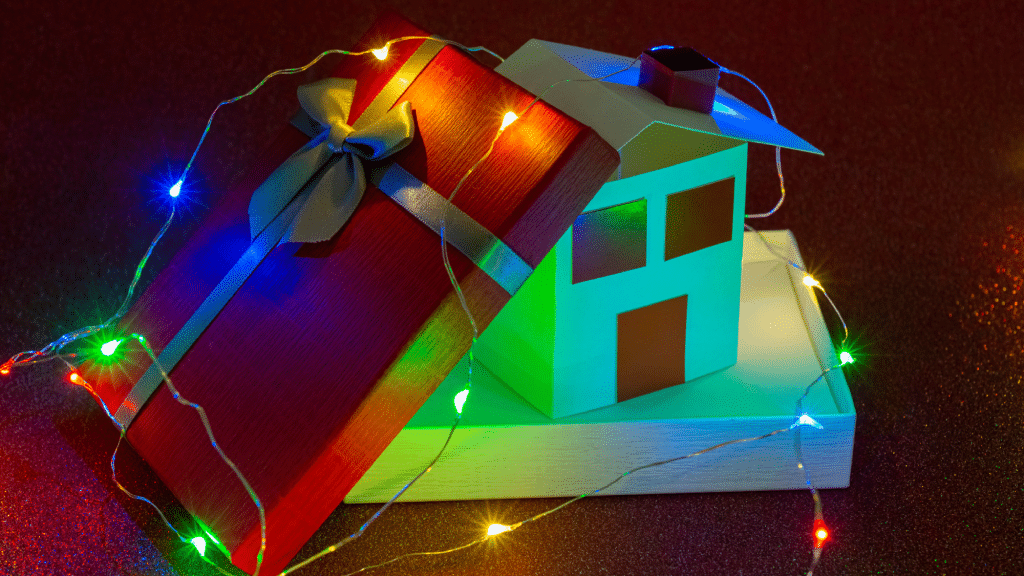Arriva in sala un film travolgente, anche perché davvero sorprendente, dal ritmo che cresce e poi decresce per meglio farlo crescere di nuovo, pieno di invenzioni e colpi di scena. Un capolavoro che ci dice molto sugli Stati Uniti e sul mondo di oggi con una precisione quasi inaudita. È Una battaglia dopo l’altra, scritto, diretto, montato e coprodotto da Paul Thomas Anderson, con un cast forte ma anche vario, le cui star – Leonardo Di Caprio e Benicio Del Toro – interpretano personaggi lontani dall’eroismo o dal machismo di tante loro interpretazioni del passato, oppure (come Sean Penn) incarnano personaggi con queste caratteristiche ma spingendole fino alla caricatura.
Questa importante produzione della Warner Bros, la più costosa da anni per Anderson, affronta temi di attualità brucianti dopo l’omicidio negli Stati Uniti dell’influencer di estrema destra Charlie Kirk, per il quale un Donald Trump grottesco quanto scatenato ha cercato di incolpare un clima d’odio che ha attribuito al Partito democratico e alla sinistra statunitensi, in realtà da anni bersaglio di azioni, talvolta riuscite, altre volte fallimentari, dell’estrema destra paramilitare più o meno suprematista (ne ricordiamo qui velocemente alcune: l’uomo che ha preso di mira e ucciso la deputata democratica Melissa Hortman era un sostenitore di Trump; l’uomo che ha preso di mira la casa del governatore democratico Josh Shapiro era un sostenitore di Trump; l’uomo che ha preso di mira e ucciso il figlio della giudice distrettuale nominato da Obama, Esther Salas, era un sostenitore di Trump; l’uomo che ha tentato di rapire Nancy Pelosi e ha aggredito suo marito era un sostenitore di Trump; gli uomini condannati per aver tentato di rapire la governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer, alla vigilia della campagna presidenziale del 2020, erano sostenitori di Trump).
Il film, molto liberamente ispirato al romanzo Vineland (1990) di Thomas Pynchon (ed è la seconda volta che il regista si basa su un testo del genio del romanzo postmoderno, dopo Vizio di forma del 2014, dove peraltro è già presente la tematica del suprematismo) ci narra di un padre di famiglia adiposo e in vestaglia, pigro se non stanco – Bob Ferguson (Leonardo Di Caprio) – ma che sedici anni prima era stato un uomo scattante e coraggioso: un attivista dei diritti civili che insieme ad altri aveva formato un gruppo armato, French 75, dove il confine tra terrorismo e azione dimostratrice molto marcata era labile, con l’intento di difendere i diritti delle minoranze, e soprattutto quelli di rifugiati e immigrati clandestini. Ma poi tutto va all’aria.
La sua compagna, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), una afroamericana da cui Bob ha appena avuto una figlia, intreccia una relazione con Steven J. Lockjaw (Sean Penn), colonnello di una sorta di polizia militare che si sovrappone alla polizia di stato (l’Fbi è del tutto assente, aspetto non trascurabile).
Quando Perfidia viene arrestata il colonnello le offre la possibilità di ricostruirsi una nuova vita se farà i nomi dei suoi compagni, questo mentre Bob riesce a portare via la bambina. E di queste due temporalità è quest’ultima, frenetica, con cui il film si apre, mentre la seconda si apre con il volto dolce e pulito di un’adolescente, Wilma (Chase Infiniti, una bella rivelazione), figlia di Perfidia e Bob, convinta che la madre sia un’eroina della rivoluzione.
Ma Wilma è davvero figlia di Bob o è invece di Lockjaw? La purezza bianca (suprematista) è stata contaminata generando una meticcia?
La follia di un esercito messo al servizio (inconsapevole) di affari personali e penetrato da un gruppo di ricchi suprematisti, in cui Lockjaw aspira a entrare, porta ad un crescendo di ritmo nell’azione (la quantità di stuntman nel film è impressionante) speculare alla follia di un’azione repressiva inumana quanto esagerata, il cui vero movente pare soltanto l’odio di fondo tra due Americhe antitetiche. E qui indubbiamente è bellissima la parte con i latinos e il capo (Benicio Del Toro) della loro organizzazione, pacifica ma capillare, volta ad aiutare gli immigrati irregolari: siamo infatti al confine con il Messico. E la visione in lingua originale restituisce non soltanto la vivacità, ma soprattutto la frattura storico-linguistica con gli Stati Uniti del passato.
Del resto, girato tra il Texas e soprattutto la California, in realtà non si capisce bene dove siamo, o meglio quando, in quale America, al contrario dei lungometraggi precedenti di Anderson, sempre ambientati nel passato con precisione, come Licorice Pizza, ambientato durante la crisi petrolifera del 1973.
Sintesi fallimentare
Un po’ film atemporale, in realtà è un film sul tempo nel suo senso più lato e ampio: sul tempo di oggi, qui metaforizzato (e allo stesso tempo proiettato) in una sorta di semiucronia e distopia in cui s’incrociano altri tempi recenti, in particolare gli Stati Uniti degli anni settanta e il cinema di quel decennio (la new Hollywood) creando così una sorta di dialogo (e concorrenza) con la cinematografia di Quentin Tarantino, compreso il suo ultimo lungometraggio, C’era una volta a Hollywood, (2019) in cui Tarantino rompeva i rapporti di luogo e di spazio mediante i set del cinema (che fu).
Bob Ferguson sembra figlio di quegli anni e al contempo il figlio di quel che fu chiamato “riflusso”, il disimpegno e l’implosione di ogni tensione ideale, tra la fine dei settanta e i primi ottanta. Ferguson ne è la sintesi. Com’è la sintesi, molto umana, tra i nuovi Stati Uniti e i vecchi, un po’ maschilisti, ma che intendevano la virilità con fierezza per proteggere chi aveva bisogno di essere protetto. E ora è un rottame, un Tom Cruise “fottutamente” fallimentare.
Il tempo in verità è qui una sorta di non tempo, perché statico. Non nel senso letterale ma piuttosto figurato. Un tempo amorfo, mediocre, quello di una civiltà che dopo aver corso tanto e in tutte le direzioni è ora una palude stanca, una palude ideologica come di vita; ma al contempo è un tempo in movimento, per via delle nuove generazioni e per la frenesia dell’azione che travolge malgrado tutto l’imbranato e maldestro Bob Ferguson, un’azione turbinosa e travolgente via via fino all’eccesso, che diventa azione iperbolica nella seconda parte e non soltanto adrenalinica per i suoi ritmi, che dopo piccole pause tornano a un crescendo al cardiopalma, un crescendo quasi isterico e specchio degli Stati Uniti di oggi che devono ricomporsi tra modernità e tradizione, classicismo e radicalità di rottura con il tempo passato delle nuove generazioni, così poco attente a una definizione dei generi immobile per sempre.
Come anche qui sul piano filmico. Dove a un certo punto il film pare un western di Sam Peckimpah o di Sergio Leone in trasferta in un’altra epoca, in un convento texano, ma tra monache anziché monaci.
Ma se tutto è iperbolico e a bordo di superbolidi rombanti, simbolo della potenza passata del paese, è perché tutto è insensatamente iperviolento. Quanto sono violenti gli americani, diceva Anna Magnani in occasione del suo viaggio negli Stati Uniti. Violenti nei modi, nel modo di essere e non soltanto nelle strade, nei quartieri poveri, nei ghetti delle metropoli.
Un paese in tilt
Ecco la questione. La violenza degli Stati Uniti che tanto ci diverte al cinema e che tanto ci agghiaccia nella realtà. Una violenza congenita, che non tramonta mai e che sembra stia per mandare il paese in tilt. La violenza è il vero padre fondatore del cosiddetto faro della democrazia occidentale?
Ci sono due Americhe che vanno a velocità sempre più diverse, sempre più opposte. Due culture che si oppongono, forse inconciliabili, forse no. Una seconda guerra civile potenziale dove la farsa è vicina (La seconda guerra civile americana di Joe Dante, 1997) quanto la tragedia con rinascita traumatica (Civil war di Alex Garland, 2024).
La vita è difficile per tutti, per una madre traditrice come per le amiche e gli amici no-gender di Wilma, che si troveranno a dover fare scelte non dissimili per sopravvivere a un potere coercitivo e implacabile, ottuso e in buona sostanza fascista, per cultura e metodi. E nondimeno, la violenza del potere non finisce bene – almeno quella incarnata da Sean Penn – in un finale sull’ineluttabilità della rivoluzione, del cambiamento, ma caldo e umano, che trova la giusta sintesi e chiusura nel personaggio di Bob, forse proprio perché imperfetto, ma umano. Come viene detto all’inizio a Bob, riferendosi alla madre di Wilma: “Lei corre mentre tu ti sei fermato”.
Non sempre è bene correre, perché oltre un certo punto non si sa più dove si va. A un dato momento è bene fermarsi e tornare indietro.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it