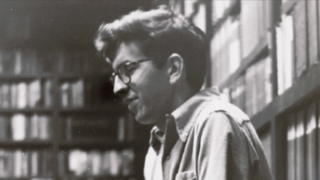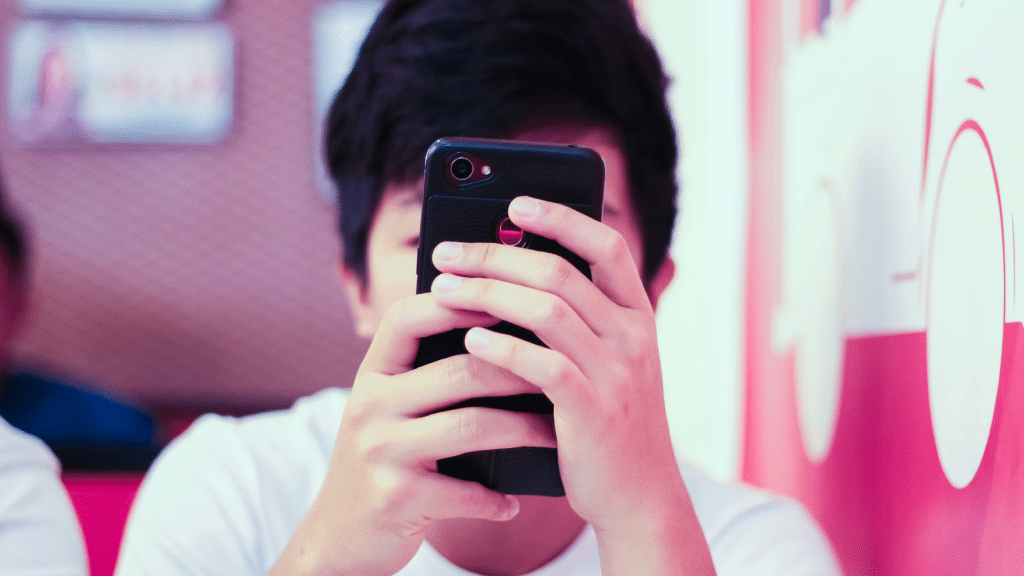L’11 novembre l’accademico e scrittore Sebastian Ben Daniel stava facendo lezione d’informatica all’università Ben Gurion della città di Beersheva, nel sud d’Israele. Improvvisamente nell’aula ha fatto irruzione un gruppo di militanti del movimento di estrema destra Im Tirtzu, guidato da Almog Cohen, parlamentare e rappresentante dell’ufficio del primo ministro israeliano. Come mostra un video pubblicato online, Cohen ha interrotto la lezione gridando minacciosamente e accusando Ben Daniel, notoriamente critico verso le politiche del governo israeliano, di “commenti antisemiti” per aver denunciato le azioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. L’università – che qualche mese fa aveva sospeso brevemente Ben Daniel a causa dei suoi duri commenti contro i soldati, chiamati “assassini di bambini” – ha condannato l’azione di Cohen.
Il 6 novembre Alec Yefremov, professore di educazione civica in un liceo di Tel Aviv, stava assistendo alla cerimonia di laurea della sorella all’università ebraica di Gerusalemme. Sulle gradinate era seduto anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che festeggiava la laurea della moglie. Quando l’ha visto, Yefremov si è alzato in piedi e gli ha gridato contro, accusandolo di essere un razzista e un seguace del rabbino di estrema destra Meir Kahane e di Baruch Goldstein, autore di una strage di palestinesi a Hebron nel 1994.
Come si vede in un video, Yefremov è stato allontanato dalle guardie di sicurezza dell’università. In seguito è stato portato via dalla polizia in manette, è stato perquisito e interrogato con l’accusa di “insulto a un pubblico ufficiale” e “disturbo dell’ordine pubblico”, e infine rilasciato con un divieto di accedere al campus universitario per quindici giorni. L’università ha condannato l’arresto di Yefremov e sotto la pressione dei politici di opposizione la polizia ha avviato un’indagine interna.
Questi due episodi sono definiti dall’esperta e docente di sociologia e antropologia Yael Berda come “espressioni dello stesso fenomeno” e riflesso dell’erosione “del confine tra autorità legittima e crudo potere”. In un articolo sul sito indipendente +972 Magazine, Berda richiama il concetto di “doppio stato” elaborato nel 1941 dal politologo ebreo-tedesco Ernst Fraenkel. Si tratta di una condizione in cui lo stato gestisce contemporaneamente due sistemi: uno “di diritto” che fa riferimento alle leggi, alle procedure e ai regolamenti, e uno “di eccezione”, che agisce con autorità assoluta in nome della sicurezza, dell’interesse nazionale e dell’ordine pubblico.
Secondo Berda le azioni contro Yefremov e Ben Daniel sono più di un attacco alla libertà accademica. Illustrano infatti il meccanismo in base al quale la retorica del controllo, della sorveglianza e del “nemico interno” sta diventando uno strumento per gestire la società, usato non più solo contro i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, ma anche dentro Israele nei confronti di cittadini ebrei. Il modello da tempo in vigore nei territori occupati – legge militare accanto a legge civile, potere illimitato accanto a istituzioni formali – si sta diffondendo dentro Israele “quasi senza resistenza”, avverte Berda. E quando il sistema di diritto e quello di eccezione “operano in tandem, la distinzione tra ‘legale’ e ‘ammissibile’ crolla”.
Se il mondo accademico adotta il linguaggio dell’ordine, della sicurezza e del patriottismo, conclude Berda, non è più in grado di articolare un’opposizione efficace al potere e finisce per cedere autorità e legittimità allo stato: “E non ha senso chiedere al regime di smettere di considerarci nemici, perché un meccanismo che produce nemici ha bisogno di loro per giustificare la propria esistenza”.
Questi episodi sono avvenuti in Israele, dove il clima politico e sociale è segnato dalla guerra scatenata nella Striscia di Gaza e da spaccature e tensioni risalenti a ben prima del 7 ottobre 2023. Ma a parte la violenza e l’aggressività che caratterizzano un paese militarizzato e governato da estremisti di destra che fanno apertamente appello alla pulizia etnica dei palestinesi, la questione ci riguarda molto più da vicino di quanto si possa pensare.
Nell’aperta e pluralista Francia, il 13 e 14 novembre doveva svolgersi un convegno internazionale intitolato “La Palestina e l’Europa: il peso del passato e le dinamiche contemporanee”. Organizzato dallo storico Henry Laurens e dal Centre arabe de recherches et d’études politiques, doveva ospitare al Collège de France, prestigiosa istituzione culturale del paese, i più importanti storici e accademici internazionali esperti del tema, oltre a personalità come la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese e l’ex ministro degli esteri francese Dominique de Villepin. Il 9 novembre, però, l’amministratore del Collège de France, il filologo e biblista svizzero Thomas Römer, ha annullato l’evento.
Pressioni per prendere questa decisione erano arrivate dal ministro dell’istruzione Philippe Baptiste in seguito a una campagna diffamatoria lanciata dal giornale di destra Le Point e dall’organizzazione filoisraeliana Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo, e amplificata dai social media vicini all’estrema destra francese. Si affermava, senza fornire prove, che il convegno fosse un’iniziativa a sostegno di Hamas e, come ha scritto Le Point in un articolo pubblicato il 7 novembre, “senza alcun dubbio filopalestinese, antisionista e decoloniale”. Il ministero si è giustificato con il pretesto di “garantire il rigore scientifico”.
In un intervento su Le Monde, un gruppo di professori del Collège de France ha criticato la decisione, che “fa prevalere in modo sproporzionato le questioni della sicurezza sul rispetto della libertà accademica, oggetto di minacce crescenti in molte parti del mondo”. L’annullamento di una manifestazione scientifica votata dall’assemblea dei professori “è un precedente di un’estrema gravità” – si legge nell’intervento – perché “indebolisce la possibilità di dibattiti scientifici e intellettuali su questioni sociali”, che diventano oggetto di interventi politici, mediatici o di parte. È a rischio la libertà accademica, che “protegge un bene non solo pubblico, ma anche comune, e che quindi crea una responsabilità collettiva nei confronti del sapere”.
Su L’Orient-Le Jour la ricercatrice Hana Jaber, direttrice della Fondazione Lokman Slim, nota che la decisione del Collège de France fa parte di un cambiamento più profondo: “Una battaglia di narrazioni in cui la semplificazione ideologica tende a soffocare ogni razionalità argomentativa”. Jaber fa riferimento all’ultima opera di Laurens, Question juive, problème arabe (1798-2001) , che definisce “un esercizio di aumento della complessità”.
Facendo risalire la genealogia della “questione ebraica” all’Europa dell’ottocento, Laurens mostra come il sionismo s’inserisca in questo contesto prima di svilupparsi in Palestina con il contributo determinante delle potenze europee e le conseguenze che conosciamo: immigrazione di coloni con un progetto nazionale esclusivo, espropriazione della popolazione palestinese, resistenza locale e poi regionale, ricomposizione delle identità arabe. Tutto questo ricorda “una realtà essenziale: non si tratta di un conflitto ‘islamo-ebraico’, ma dello scontro tra due progetti nazionali incompatibili sullo stesso territorio, caratterizzati da un profondo squilibrio strutturale nei rapporti di forza”. Ed è proprio quello che i governi occidentali si rifiutano di riconoscere.
Hèla Yousfi, che insegna all’università Dauphine-Psl di Parigi, scrive su The New Arab che questo “episodio politico” non è isolato, ma s’inserisce in un “più ampio contesto di censura e repressione del lavoro accademico sulla Palestina, che si è intensificato dal 7 ottobre 2023”. In Francia sono stati cancellati vari eventi accademici, le mobilitazioni degli studenti sono state represse, la ricerca universitaria ostacolata e gli esperti di studi mediorientali spesso accusati di “antisemitismo” e “apologia del terrorismo”.
Ma a essere colpite e screditate sono anche altre aree di ricerca, come quelle sul genere e sulla razza e quelle che riguardano gli studi postcoloniali e decoloniali. Questi assalti alla libertà accademica, commenta Yousfi, dimostrano “il desiderio di esercitare un maggiore controllo sulla produzione di conoscenza e sulla ricerca in Francia, nonché un contesto politico sempre più autoritario”. Secondo lei l’attuale “rinascita del fascismo in occidente non può essere compresa senza riconoscere il suo profondo intreccio con l’imperialismo e la violenza coloniale”.
La questione non è solo geopolitica, ma rivela quanto profondamente la libertà accademica sia influenzata dall’eredità coloniale e dalle gerarchie razziali: “Le popolazioni razzializzate, in particolare arabi e musulmani, sono inquadrate come nemici interni, e il dibattito critico sulla guerra genocida di Israele – sempre codificata come una questione musulmana o araba – è presentato come una minaccia all’ordine pubblico o all’unità nazionale”.
Ho chiesto un commento a Catherine Cornet, arabista e collaboratrice di Internazionale, che in queste settimane ha seguito da vicino la vicenda. Secondo lei la polemica “va ben oltre le frontiere del mondo accademico” ed è indicativa del “dibattito polarizzato e bloccato” in Francia. Infatti è la prima volta dai tempi di Napoleone III che il Collège de France si piega a pressioni politiche così esplicite. Il convegno, sottolinea Cornet, aveva un taglio decisamente storico e si proponeva di mettere in luce le radici europee della questione ebraica, seguendo l’importante libro di Laurens, che è “apparso visibilmente scosso” dalla cancellazione di un evento che aveva accuratamente preparato.
Alla fine il convegno si è svolto comunque il 13 novembre nella piccola sala del Centre arabe de recherches et d’études politiques di Parigi, seguito da una cinquantina di persone in presenza e da più di cinquecento nella diretta online (qui la registrazione su YouTube). La sessione di chiusura è stata tenuta da Francesca Albanese e Dominique de Villepin insieme all’ex alto rappresentante degli affari esteri dell’Unione europea Josep Borrell. Nel suo intervento Albanese ha detto che il genocidio a Gaza “sta svelando” un’Europa che non considera “la guerra una tragedia da prevenire, come se la dominazione e la violenza fossero nell’ordine naturale delle cose e non un fallimento dell’umanità”.
Questo testo è tratto dalla newsletter Mediorientale.
|
Iscriviti a Mediorientale |
Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Mediorientale
|
|
Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it