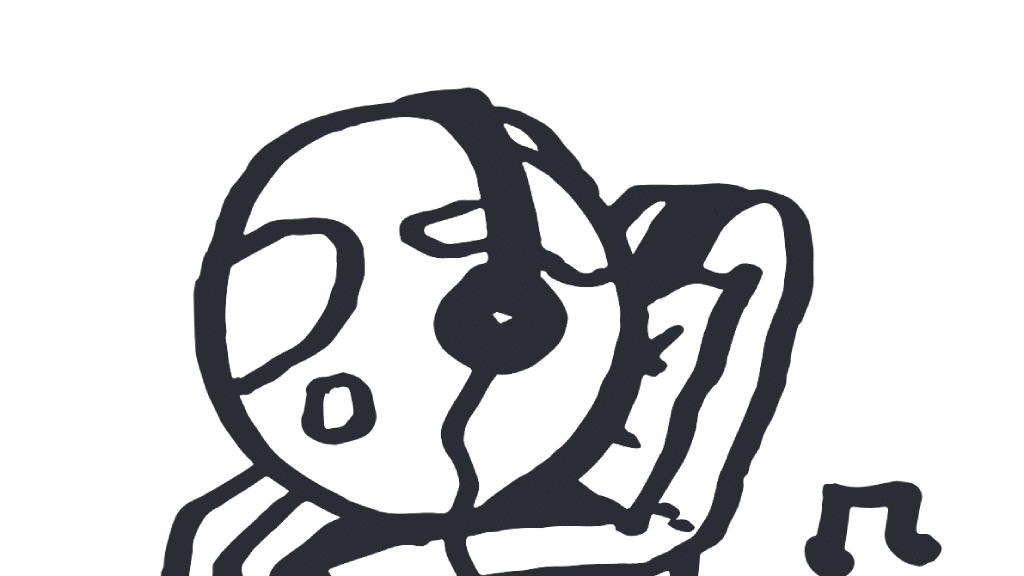Il Tapón del Darién (il tappo del Darién) è una fitta giungla che separa la Colombia e Panamá. Considerata praticamente invalicabile per secoli a causa della presenza di animali feroci, serpenti velenosi e pericoli naturali, negli ultimi anni è diventata una delle rotte più usate dai migranti per raggiungere gli Stati Uniti attraverso l’America Centrale e il Messico. Ma alle difficoltà di un tempo si sono aggiunte quelle legate alla presenza delle organizzazioni criminali e dei trafficanti di persone, che guadagnano dallo sfruttamento dei migranti.
Nel 2024 più di 300mila persone hanno attraversato a piedi la giungla, con un aumento preoccupante del numero di bambini: oltre trentamila solo nei primi quattro mesi dell’anno secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), di cui almeno duemila non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Molti muoiono durante il cammino e molte donne partoriscono nel Darién.
Da qualche mese, dopo che Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca alla fine di gennaio, la situazione sta cambiando e nella regione arrivano soprattutto migranti che affrontano il viaggio inverso, dagli Stati Uniti attraverso il Messico fino a Panamá, passando per il Guatemala, l’Honduras, il Nicaragua e la Costa Rica. La maggior parte sono venezuelani che hanno deciso di rientrare nel loro paese perché la politica migratoria del presidente statunitense ha complicato ulteriormente una condizione già precaria.
Alcuni hanno aspettato per mesi in Messico di essere ricevuti dalle autorità migratorie, dopo aver chiesto un appuntamento tramite l’app Cbp One, ma alla fine hanno desistito. Altri erano già negli Stati Uniti quando le espulsioni ordinate da Trump, soprattutto di venezuelani accusati dall’amministrazione repubblicana di far parte del gruppo criminale Tren de Aragua, li hanno convinti che fosse più sicuro lasciare il paese per evitare di essere espulsi e trasferiti forzatamente nel megarcere in Salvador come centinaia di loro connazionali.
Luz Angela Rivera, che da tre anni viveva nello stato dello Utah, ha raccontato a Le Monde: “Stavamo aspettando i nostri documenti, ma con Trump la vita è diventata un inferno. Mio marito, che lavorava sedici ore al giorno in una fabbrica di mattoni, ha perso il lavoro. Avevamo paura di parlare spagnolo per strada. Abbiamo preferito andarcene prima di essere espulsi, e molte persone stanno per fare lo stesso”.
Le barche con a bordo i migranti fanno scalo a Puerto Obaldia, a Panamá, per le formalità burocratiche, e poi a La Miel, l’ultimo villaggio panamense prima del confine con la Colombia, completamente circondato dalla giungla. “Uomini, donne e bambini esausti devono salire 254 gradini, con borse e valigie, per raggiungere la frontiera, per poi scenderne altri 270 fino alla spiaggia di Sapzurro, a dieci minuti di mare da Capurganá”, scrive Marie Delcas sul quotidiano francese.
I migranti denunciano lentezze e ostacoli imposti dalle autorità locali, che sembrano agire più per interesse economico che per motivazioni umanitarie. Il piccolo ufficio migratorio di Capurganá, in Colombia, è sovraccarico di lavoro: “Le interruzioni di corrente non facilitano il compito dei tre funzionari presenti. I migranti devono aspettare giorni per poter raggiungere Necoclí, sull’altra sponda del Golfo di Urabá. Quest’ultima traversata avviene con il regolare servizio di traghetto usato dai turisti. Poi da lì di solito le persone proseguono in autobus verso la loro destinazione finale”.
Celeste Tamayo, una venezuelana di 32 anni, riferendosi alle mafie che sfruttano i migranti, ha detto che “ci sarebbe costato meno partire in aereo, ma le autorità messicane non lasciano viaggiare chi non ha un passaporto o un salvacondotto dell’ambasciata di Caracas. E non abbiamo mai visto i voli umanitari promessi dal governo del presidente Nicolás Maduro”.
Tamayo si riferisce al programma Vuelve a la patria, torna in patria, lanciato nel 2018 per garantire un ritorno ordinato e sicuro nel paese latinoamericano. Da allora circa tremila venezuelani sono rientrati dagli Stati Uniti con i voli organizzati dal governo, non molti in realtà a fronte dei più di sette milioni di venezuelani emigrati dal 2013 a causa della crisi economica, sociale e politica. Oggi, nonostante la gioia di ritrovare i propri affetti, sono tanti a temere la situazione che troveranno in Venezuela.
Dopo le elezioni presidenziali dello scorso luglio, vinte da Maduro con l’accusa di brogli, la speranza di un cambiamento politico è svanita e l’economia deve fare i conti con le nuove sanzioni che la Casa Bianca ha imposto al governo e con i dazi sul petrolio venezuelano. Come ha detto a Le Monde Jorge Luis Videla, un meccanico venezuelano, “Trump ci caccia dagli Stati Uniti e ci affama in Venezuela”.
Questo testo è tratto dalla newsletter Sudamericana.
|
Iscriviti a Sudamericana |
Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Sudamericana
|
|
Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.
|
| Iscriviti |
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it