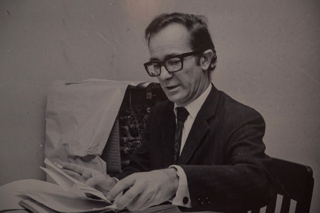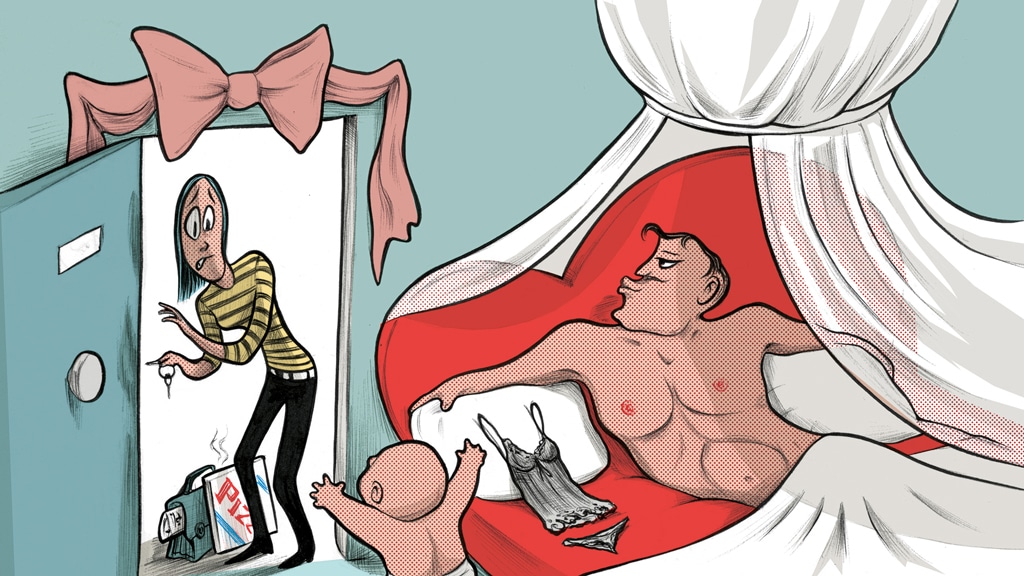L’importanza storica e il contributo dell’Egitto dei faraoni all’evoluzione della civiltà sono noti. Ma la cerimonia di apertura del Grand egyptian museum non è stata tanto una celebrazione della gloria passata, quanto una faccenda strettamente politica. La sfarzosa inaugurazione del 1 novembre davanti alle piramidi di Giza aveva tutti i crismi della propaganda contemporanea. Queste fiere della vanità tendono a stupire il mondo e a regalare ai paesi ospitanti un falso senso di ricchezza e rinnovata legittimità, ma a posteriori si rivelano per quello che sono: avvisaglie di decadenza e di un tracollo imminente di un regime.
Non è la prima volta che assistiamo a qualcosa di simile. Uno dei casi più famosi avvenne proprio in Egitto. Nel 1871 Il Cairo ospitò la prima dell’Aida. L’opera di Giuseppe Verdi era stata commissionata dal governatore dell’epoca, il chedivè Ismail, per celebrare l’apertura del canale di Suez. Un secolo più tardi Mohammad Reza Pahlavi, lo scià dell’Iran, organizzò una festa tra le antiche rovine di Persepoli per commemorare i 2.500 anni del regno di Ciro il Grande di Persia.
Parliamo di tre cerimonie diverse, che tuttavia hanno evidenziato tendenze storiche dominanti: imperialismo culturale occidentale, autoritarismo e consumo sfrenato. Il gusto europeo per la moda, la musica e il cibo (e perfino per la rivisitazione della storia) fu onnipresente alla prima dell’Aida e nella festa di Persepoli. Come raccontava l’intellettuale d’origine palestinese Edward Said nella sua analisi, Verdi impose scenografie “in cui la realtà dell’antico Egitto potesse riflettere l’occhio imperiale”. La storia fu scelta dall’egittologo francese Auguste Mariette, responsabile dei reperti antichi sotto il chedivè. E, come sottolinea Said, la trama era imbottita di stereotipi europei su un oriente esotico e dispotico.
Un secolo dopo, la festa a Persepoli si ridusse quasi interamente a una faccenda tra europei. Per costruire un accampamento capace di accogliere e intrattenere decine di dignitari stranieri, lo scià fece arrivare tutto e tutti – dagli alberi ai camerieri – dalle capitali europee.
Faraoni globalizzati
Il gusto europeo è stato ben visibile anche nell’evento del Grand egyptian museum. La musica classica europea ha dominato le scene in cui i ballerini hanno indossato elaborati costumi faraonici. In linea con la cultura globalizzata statunitense, gli organizzatori hanno rimarcato il carattere internazionale dell’evento, con artisti provenienti da tutto il mondo, dal Giappone al Brasile. Anziché chiederne la restituzione, gli obelischi trafugati in Egitto durante l’epoca coloniale (che svettano nelle piazze di Parigi o New York) sono stati presentati come prove dell’influenza culturale del paese. Erano quasi del tutto assenti il repertorio di musica araba dell’Egitto contemporaneo e la ricca tradizione dell’arte islamica, confinati in un’apparizione simbolica ed effimera. L’insistenza sul passato preislamico e sul presente europeizzato è un elemento ricorrente della cultura coloniale, riproposto già in occasione dell’Aida e della festa di Persepoli.
I costi esorbitanti associati a questi eventi sono un altro segnale della decadenza che incarnano. La spesa scriteriata del chedivè per il teatro dell’opera e il compenso di Verdi erano in linea con il suo temperamento. Il suo governo, infatti, è passato alla storia per i grandiosi progetti in un’epoca in cui la ricchezza si consolidava attraverso la proprietà terriera, lo sfruttamento del lavoro e altre forme di tassazione che ricadevano inesorabilmente sui contadini e sui lavoratori.
Le abitudini dispendiose di Ismail, spesso fomentate da consulenti europei corrotti, contribuirono all’esplosione del debito pubblico, preambolo della bancarotta dello stato e dell’occupazione britannica. Alla fine il gusto del chedivè per l’arte del vecchio continente e i suoi consulenti europei non lo salvarono dalla deposizione per mano occidentale.
La festa nel deserto organizzata dallo scià a Persepoli incarnava lo stesso desiderio di ostentazione. Secondo i resoconti giornalistici furono utilizzati quaranta camion e cento aerei per trasportare i materiali richiesti per allestire l’accampamento, con 18 tonnellate di cibo e 25mila bottiglie di vino servite da 180 camerieri stranieri. Atti di consumismo sfrenato che furono mostrati in tv al popolo iraniano, in un momento in cui, secondo alcune stime, circa metà della popolazione viveva in povertà.
Soldi privati e orgoglio nazionale
I mezzi d’informazione hanno riportato i costi di costruzione del Grand egyptian museum (ma non le spese per la cerimonia). Il progetto da 1,2 miliardi di dollari è innegabilmente impegnativo, ma diversamente dalla prima dell’Aida e dalla festa dello scià, in futuro sicuramente frutterà introiti ed è inquadrato nell’espansione di un importante settore come quello del turismo. In ogni caso non basterà per arrestare l’impennata del debito pubblico o alleviare la povertà che affligge l’Egitto.
La collaborazione con il settore privato è un altro segnale del ritorno dell’oligarchia nei corridoi del potere. Durante una lunga serie di conferenze stampa, il primo ministro Mostafa Madbouly ha ringraziato profusamente alcuni industriali del paese, tutti in prima fila all’inaugurazione del Grand egyptian museum. La scelta di un museo come manifestazione di orgoglio nazionale e promessa economica contrasta con l’enorme progetto della diga di Assuan degli anni cinquanta. Nonostante i difetti, la diga era un’opera che puntava a rafforzare il settore industriale e quello agricolo, oltre a portare l’elettricità nelle case degli egiziani. E quel progetto innescò la nazionalizzazione del canale di Suez che segnò un momento chiave nel declino dell’imperialismo britannico e nell’ascesa dell’Egitto come simbolo di indipendenza nazionale su scala regionale e globale.
Quei tempi sono ormai lontani. Oggi l’Egitto non ha nessun potere sul piano regionale. Invoca la “pace” – un tema onnipresente durante la cerimonia – mentre le acque del Nilo sono minacciate da una immensa diga in Etiopia e il Sinai è di fatto governato da Israele. Durante la festa di Persepoli, Mohammad Reza Pahlavi, che quattro anni prima si era autoproclamato “re dei re”, si rivolse solennemente alla tomba di Ciro: “Dormi tranquillo, noi siamo vigili”. La storia l’ha smentito: pochi anni dopo l’indegno erede del re persiano fu travolto dalla rivoluzione.
Da allora è passato mezzo secolo, e la colossale statua di Ramesse II, uno dei guerrieri più possenti dell’antico Egitto, è piazzata all’ingresso del Grand egyptian museum. Il tempo ci dirà se la sua presenza basterà a proteggere il paese da un destino amaro. ◆ as
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati