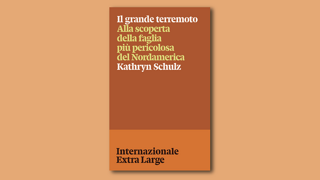I romani lo usavano per le tubature. Nel cinquecento le donne s’incipriavano il viso con polveri che lo contenevano. E fino agli anni settanta, quando si è cominciato a eliminarlo, veniva aggiunto alla benzina per migliorare il funzionamento dei motori. Di solito l’avvelenamento da piombo è considerato un problema delle civiltà relativamente moderne. Ma in un articolo pubblicato su Science Advances, il genetista dell’università della California a San Diego Alysson Muotri e i suoi colleghi dimostrano che era comune anche tra i nostri antenati dell’era preindustriale. Questo metallo tossico potrebbe addirittura aver aiutato l’Homo sapiens a diventare l’unica specie di ominidi esistente sul pianeta.
Muotri e il suo team hanno fatto questa scoperta mentre studiavano i resti di denti, che si conservano a lungo sotto forma di fossili e possono rivelare molto della vita dei proprietari perché intrappolano minuscole tracce delle sostanze chimiche che circolano nel corpo. Per esempio, se durante l’infanzia si beve abitualmente acqua contaminata da un certo elemento, i suoi residui permangono nei denti.
I ricercatori hanno studiato 51 denti umani e di specie affini degli ultimi due milioni di anni, vaporizzando con il laser minuscoli frammenti per rivelarne il contenuto. Sorprendentemente, il piombo era presente in 37 campioni. È stato trovato in tutti i tipi di ominide, compreso l’australopiteco, un antenato degli umani moderni che si pensa si sia estinto intorno a 1,9 milioni di anni fa, e l’Homo erectus, vissuto fino a circa centomila anni fa.
Non è chiaro come il piombo sia finito nei denti. Anche se può essere sprigionato da eruzioni vulcaniche e incendi, secondo Muotri la spiegazione più plausibile riguarda l’acqua. I primi umani si riparavano nelle grotte, e preferibilmente in quelle dotate di fonti d’acqua. In quell’acqua, però, spesso era disciolto il piombo contenuto nelle rocce circostanti. E i ricercatori sapevano da altri studi che almeno alcune delle grotte paleolitiche usate dalle varie specie di Homo ne erano sature.
I livelli di piombo in molti campioni erano alti, fino a 50 parti per milione. Gli studi moderni dimostrano che poche parti per milione bastano per provocare danni cognitivi nei bambini. Incuriosito, Muotri ha cercato di capire come gli antichi umani reagissero a simili esposizioni. Per farlo ha coltivato in laboratorio piccoli ciuffi di tessuto simile a quello del cervello, noti come organoidi cerebrali.
Tolleranza aumentata
Alcuni organoidi erano fatti con cellule il cui genoma conteneva una versione del gene Nova1 presente in tutti gli esseri umani moderni. Altri invece ne avevano una versione antica, contenuta nei genomi dei neandertal e presumibilmente nelle specie precedenti, come l’australopiteco. La versione moderna del Nova1 è essenziale per lo sviluppo del cervello. In altri studi Muotri aveva dimostrato che in presenza della versione antica del gene l’architettura cerebrale è talmente diversa che la forma moderna del gene è considerata uno degli indicatori genetici più chiari che distinguono gli umani moderni dai loro cugini neandertal. Inoltre il gene Nova1 è coinvolto anche nella risposta del cervello alla contaminazione da piombo.
I ricercatori hanno esposto gli organoidi a varie quantità di piombo per poi analizzarne il comportamento. Nessuno ha reagito bene, ma c’era una differenza evidente. In quelli con la versione antica del Nova1 l’avvelenamento alterava l’espressione di un altro gene, chiamato Foxp2. Negli umani moderni il corretto funzionamento del Foxp2 è essenziale per l’apprendimento del linguaggio. Gli organoidi con la versione moderna del Nova1 non presentavano questi problemi.
Secondo Muotri, quindi, l’evoluzione della nuova versione del gene Nova1 ha contribuito a impedire che l’esposizione al piombo interferisse con la capacità di parlare. Se ha ragione, la maggiore tolleranza all’avvelenamento da piombo potrebbe essere stata uno dei fattori che hanno permesso agli umani moderni di soppiantare gli altri ominidi e compiere imprese straordinarie, come inventare le tubature, la benzina e i cosmetici al piombo con cui avvelenarsi ancora di più. ◆ sdf
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1637 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati