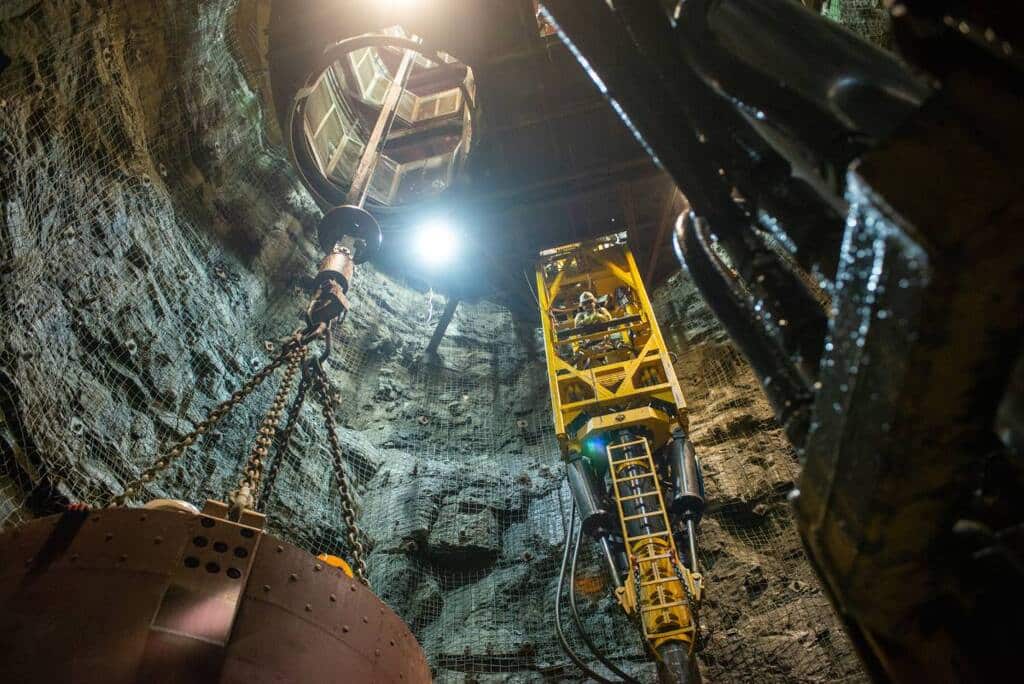Ad agosto è stata estratta nella miniera di diamanti di Karowe, in Botswana, una pietra definita “eccezionale”: un diamante rosa da 37,42 carati, che è poi stato portato ad Anversa, in Belgio, per essere tagliato e trasformato in gioielli. L’anno prima aveva fatto il giro del mondo la foto dell’allora presidente Mokgweetsi Masisi che esaminava con una lente d’ingrandimento un altro diamante grezzo da record: ben 2.492 carati, il secondo più grande mai trovato dopo il Cullinan, in Sudafrica nel 1905. La gemma era stata estratta sempre a Karowe, che è controllata dall’azienda mineraria canadese Lucara.
Dietro questi annunci trionfalistici si nasconde, però, un’altra realtà: il settore dei diamanti naturali è in difficoltà perché sempre più spesso, nella gioielleria e per altri usi industriali, queste gemme sono sostituite da quelle ottenute artificialmente, a costi notevolmente inferiori. Come nota il giornalista Keletso Thobega in un articolo per The Continent, “nascosto nell’ultimo rapporto trimestrale della Lucara c’è un avvertimento riguardo ai prossimi dodici mesi. L’azienda stima che non avrà la liquidità necessaria per tenere fede ai suoi impegni e per realizzare i suoi progetti. Le condizioni in cui si trova fanno nascere dubbi sulla sua capacità di mantenersi in attività”.
I profitti della Lucara sono calati da un utile di 40 milioni di dollari nel 2022 a una perdita di 20 milioni l’anno successivo, e il 2024, anche se è stato di nuovo un anno buono, non è bastato a garantire un po’ di respiro. Lo stesso vale per la più importante e nota azienda produttrice di diamanti del mondo, la DeBeers, la cui situazione finanziaria non è rosea. La DeBeers è in affari con il governo del Botswana, che detiene il 15 per cento delle azioni dell’azienda e partecipa alla joint venture Debswana. Quest’ultima ha perso il 52 per cento dei profitti negli ultimi due anni, situazione che ha portato a tagli della produzione e licenziamenti in un settore che aveva a lungo garantito al Botswana un’economia più prospera di quella di altri paesi africani.
Tenendo in mano la gemma eccezionale, l’ex presidente Masisi aveva esclamato: “Vedo la costruzione di nuove strade”. Lo racconta sempre Thobega in un articolo che avevamo pubblicato su Internazionale l’anno scorso, spiegando che il Botswana ha approfittato per anni della ricchezza generata dai diamanti. Inoltre, rispetto ad altri paesi che hanno svenduto agli stranieri le loro ricchezze minerarie, è riuscito a stringere accordi con le grandi aziende per assicurarsi una fetta del ricavato in un mercato dominato da sempre dai capitalisti bianchi.
Le radici coloniali
Come ricostruisce George Charles Darley su Al Jazeera, l’industria dei diamanti affonda le radici nel colonialismo. All’origine c’è l’uomo simbolo della dominazione britannica in Africa, Cecil Rhodes, che cominciò vendendo pompe idrauliche per le miniere e – grazie anche alla possibilità di ottenere facilmente credito dalle grandi banche dell’epoca, come la Rotschild – finì per comprare varie miniere nell’attuale Sudafrica e fondare insieme al socio Charles Rudd la De Beers Consolidated Mines. All’inizio del novecento l’azienda controllava il 90 per cento del mercato mondiale dei diamanti e poteva approfittare di un sistema razzista in cui gli operai neri guadagnavano stipendi miseri e vivevano in condizioni pessime, mentre i proprietari bianchi europei si dividevano i ricavi.
Nei decenni successivi l’azienda passò nelle mani della famiglia sudafricana Oppenheimer. Secondo Darley, questi imprenditori fecero in modo di controllare il mercato per mantenere artificialmente la scarsità di diamanti sul mercato e tenere alti i prezzi. Allo stesso tempo, intorno al 1946, la DeBeers incaricò un’agenzia pubblicitaria di Philadelphia di creare una nuova campagna pubblicitaria: ne venne fuori il famosissimo “Un diamante è per sempre”, che legò indissolubilmente la gemma all’idea di amore eterno, incarnata da un anello di fidanzamento scintillante. Prima, i fidanzati si regalavano altre cose preziose – medaglioni, gioielli di famiglia, fili di perle – ma da quel punto in poi le cose cambiarono. Grazie a quello che è stato definito “lo slogan del secolo”, scrive Darley, “la De Beers ha creato una nuova norma sociale… che ha attecchito nei mercati di ogni paese sviluppato. Il numero di spose statunitensi con al dito un anello di diamanti è cresciuto dal 10 per cento nel 1940 all’80 per cento nel 1980; in Giappone, da meno del 5 per cento nel 1960 al 60 per cento nel 1981”.
Quest’industria si è espansa progressivamente, adattandosi ai cambiamenti politici nei paesi di estrazione (per esempio, quando il Sudafrica è diventato democratico nel 1994) e trovando il modo di superare scandali come quello dei “diamanti di sangue” dell’inizio degli anni duemila. Ma oggi la concorrenza dei diamanti fatti in laboratorio sembra aver cambiato definitivamente le cose. Alcuni paesi, come Sudafrica e Botswana, cercano di ritagliarsi una fetta più grande dei guadagni evitando di esportare le gemme allo stato grezzo e favorendo sul proprio territorio attività come il taglio e la levigatura, che garantiscono margini di profitto più alti. A settembre, per esempio, ha aperto vicino a Johannesburg un impianto dell’indiana Finestar Diamonds and Jewellery, specializzata nella lavorazione delle pietre preziose.
In ogni caso il futuro dei diamanti non sembra più tanto brillante e non basterà uno slogan accattivante a risollevarne le sorti.
|
Iscriviti a Africana |
Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.
|
| Iscriviti |
|
Iscriviti a Africana
|
|
Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.
|
| Iscriviti |
Questo testo è tratto dalla newsletter Africana.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it