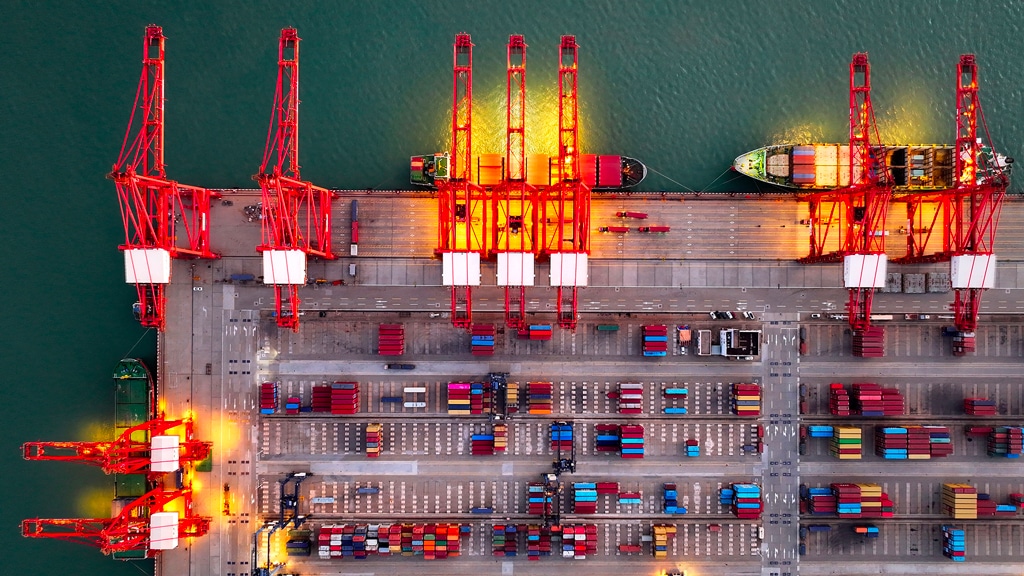La mattina del 12 novembre siamo stati svegliati di soprassalto dal rumore delle ruspe a pochi metri dalle nostre case, nel villaggio di Umm al Khair nella Cisgiordania occupata. Mentre gli operatori urlavano tra il frastuono dei motori, abbiamo immediatamente capito cosa stava succedendo: preparativi per demolizioni imminenti.
Per due ore siamo rimasti sospesi nel terrore. Ci siamo affrettati a impacchettare i documenti, raccogliere le coperte, tenere stretti a noi i bambini, aspettando il momento in cui le macchine si sarebbero abbattute sulle case. Quando finalmente i bulldozer se ne sono andati abbiamo realizzato che invece erano diretti verso il vicino villaggio di Al Fakheet, dove entro la fine della giornata hanno demolito due case e due pozzi. Ma sapevamo che sarebbero tornati per Umm al Khair: è solo questione di tempo.
Appena due settimane prima, il 28 ottobre, le autorità israeliane avevano consegnato agli abitanti tredici ordini definitivi di demolizione, riguardanti varie strutture che nel complesso costituiscono un terzo del villaggio. Ci hanno dato due settimane per presentare ricorso; il nostro avvocato è riuscito a ottenerne altre due. Ma quando i ventotto giorni saranno scaduti, le demolizioni potranno essere avviate in qualsiasi momento.
Gli ordini riguardano undici case, il nostro centro comunitario e la serra. Israele le considera “illegali” perché sono state costruite senza permessi, anche se ogni volta che ne chiediamo uno ci viene negato. Nel frattempo, le roulotte piazzate illegalmente vicino al centro del villaggio dal colono israeliano Yinon Levy – lo stesso che quattro mesi fa ha ucciso nostro cugino, l’attivista pacifista Awdah Hathaleen – restano lì. Se saranno eseguite, le demolizioni raderanno al suolo quasi tutta la parte meridionale di Umm al Khair, lasciando senza un tetto più di settanta persone, tra cui cinquanta bambini. Ma al di là della distruzione materiale, l’obiettivo è abbattere il morale di una comunità che è diventata un fulcro della resistenza non violenta alla pulizia etnica a Masafer Yatta (una zona a sud di Hebron costituita da una ventina di villaggi e dal 2022 diventata, su ordine della corte suprema israeliana, un’area di addestramento militare).
Denunce inutili
Nel tentativo di fare pressioni su Israele per bloccare le demolizioni, il 5 novembre abbiamo organizzato una conferenza stampa, a cui hanno partecipato quasi cento persone tra giornalisti, diplomatici e attivisti. L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esortato Israele a bloccare le demolizioni, mentre il deputato statunitense Jamie Raskin ha diffuso una lettera a sostegno della nostra campagna firmata da più di cento rappresentanti del congresso. Nonostante questo, ci è stato detto che le possibilità di fermare le demolizioni sono scarse.
Il mese scorso è stato il più pericoloso e doloroso dall’omicidio di Awdah Hathaleen. Il 9 novembre alle prime ore del mattino due coloni dell’avamposto illegale di Havat Shorashim hanno tagliato le nostre recinzioni e hanno portato le loro pecore negli uliveti del villaggio. Le greggi hanno pascolato distruggendo gli alberi piantati decenni fa dalla nostra famiglia.
Quando due dei nostri parenti hanno tentato di andarsene i coloni li hanno attaccati: hanno colpito Ahmed alla testa – facendolo finire in ospedale, dove ha rimediato cinque punti di sutura – e hanno picchiato nostro zio Yasser sul braccio. Abbiamo immediatamente chiamato la polizia israeliana, come facciamo sempre, ma i coloni hanno continuato per molto tempo la loro aggressione prima che qualcuno arrivasse. Quando circa mezz’ora dopo i soldati e la polizia si sono finalmente presentati nessuno è intervenuto. Molti erano a loro volta coloni. Come è successo fin troppe volte, hanno detto che qualcuno della nostra comunità aveva lanciato dei sassi contro i coloni e sulla base di queste false accuse hanno arrestato alcuni nostri cugini.
Mentre le forze israeliane guardavano senza fare niente, i coloni avevano mano libera. Guidati da Shimon Atiya hanno preso a bastonate duecento piante di ulivo, i campi di timo e decine di fichi, mandorli e fichi d’India. Molti alberi erano stati piantati quasi vent’anni fa dai nostri parenti e da Haj Suleiman Hathaleen, nostro zio e guida, ucciso dalle forze israeliane nel 2022. La terra che nutriva il villaggio – sia letteralmente sia spiritualmente – è stata ridotta a un campo brullo.
Più tardi quello stesso giorno un altro gruppo di coloni, stavolta vestiti in uniforme militare, è arrivato e ha eseguito l’ordine di Atiya di cacciarci dalla nostra terra. Finora abbiamo presentato senza successo più di trenta denunce contro Atiya e l’altra persona responsabile dell’attacco. Mesi fa i due avevano aggredito l’anziana madre di Ahmed, Fatima, e le prove video erano state consegnate alle forze dell’ordine israeliane. La polizia però non ha preso provvedimenti. Ogni volta che una denuncia è ignorata i coloni diventano più sicuri di sé e noi perdiamo ogni illusione che il sistema ci possa proteggere.
Muri e speranza
Il 10 novembre, Atiya è andato al cimitero di Umm al Khair. Senza esitazione ha cominciato a prendere a calci le tombe e a sdraiarcisi sopra. Quando gli abitanti e gli attivisti hanno cercato di non farlo entrare nel villaggio, l’esercito ha usato i suoi veicoli per creargli un passaggio alternativo, su terreni privati, a meno di un metro dalle nostre case. In seguito i coloni sono tornati altre tre volte al cimitero, a bordo dei fuoristrada che lo stato gli ha comprato; la seconda volta, l’11 novembre, Tariq è finito ammanettato e bendato, poi è stato arrestato e trasportato in una base militare proprio dall’esercito a cui avevamo chiesto aiuto. Dopo ore di detenzione militare e un interrogatorio, è stato liberato in piena notte senza accuse, senza condizioni e senza una multa, e gli è stato detto di tornare a casa a piedi da Hebron. Il 13 novembre, la polizia ha dichiarato che ai coloni è consentito l’accesso a una metà del cimitero, che loro considerano una terra “sottoposta a perizia” (il primo passo per dichiararla di proprietà dello stato).
Vedere qualcuno camminare, calpestare o sdraiarsi sulle tombe dei nostri cari, degli anziani, della nostra storia, mentre i soldati e la polizia guardano in silenzio, ci sembra un tentativo di cancellare non solo la nostra presenza ma anche l’esistenza passata: i nostri morti e i nostri ricordi.
Nei quattro mesi trascorsi dall’uccisione di Awdah il dolore a Umm al Khair non si è placato. Non c’è mattino senza terrore, non c’è notte senza pena. Nei momenti più difficili, quando non sappiamo se saremo in grado di reggere le pressioni sempre più forti, immaginiamo Awdah e Suleiman ripetere le parole che pronunciavano spesso, un impegno che alla fine sono stati costretti a onorare: “Resteremo qui, anche se dovessimo pagare con la vita”. Ogni alba porta un nuovo attacco, altri morti e un motivo in più per chiedersi quanto tempo ancora questa piccola comunità di duecento persone potrà sopportare il peso che le è stato imposto. Ma le nostre radici restano salde, come quelle degli ulivi che hanno tentato di distruggere, come le pietre che mormorano i nomi dei caduti.
Dal 2007, nel corso di circa venti operazioni, a Umm al Khair sono state demolite più di cento case e strutture. Molte sono state ricostruite, per poi essere di nuovo abbattute. Ogni volta dentro di noi qualcosa si è spezzato. E ogni volta abbiamo ricostruito non solo i muri, ma anche la speranza. È così che va la vita qui: i coloni costruiscono illegalmente e noi siamo puniti “legalmente”. I soldati proteggono gli aggressori, la polizia ignora le denunce e i tribunali emettono sentenze che non sono applicate. Il sistema progettato per realizzare una pulizia etnica ai nostri danni è ormai completo. ◆ fdl
Il 23 novembre 2025 Israele ha ucciso Haitham Ali Tabatabai, capo militare di Hezbollah, in un attacco a un edificio alla periferia sud di Beirut, che secondo le autorità libanesi ha causato altri quattro morti. Tabatabai è il più alto esponente di Hezbollah ucciso dal novembre 2024, quando Israele e il gruppo libanese alleato di Hamas e sostenuto dall’Iran hanno firmato un accordo, raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti, che ha messo fine a quasi due mesi di guerra aperta. Di recente Israele ha intensificato gli attacchi contro le roccaforti di Hezbollah nel sud e nell’est del Libano. Le autorità libanesi accusano Israele di violare l’accordo compiendo attacchi e continuando a occupare cinque posizioni strategiche nel sud del Libano. Washington esercita pressioni su Beirut affinché proceda a disarmare Hezbollah.
L’Orient-Le Jour si chiede se Hezbollah risponderà all’attacco che “si aggiunge a una serie di colpi” subiti dal gruppo, con circa 350 persone uccise dall’inizio del cessate il fuoco, tra cui un centinaio di civili: “Una passività forzata che oggi pone il gruppo in una posizione delicata, se non imbarazzante”. Secondo il quotidiano libanese però la milizia “ha più da perdere che da guadagnare riaprendo le ostilità” e potrebbe scegliere di privilegiare la cautela, tenendo a freno gli elementi più radicali al suo interno.
Amos Harel, esperto di questioni militari, commenta su Haaretz che l’attacco in Libano è funzionale agli interessi di Benjamin Netanyahu. Tenere alta la tensione su diversi fronti – dalla Striscia di Gaza alla Siria al Libano – serve al primo ministro israeliano per “controllare il dibattito pubblico e creare il clima che desidera nell’imminente campagna elettorale. Inoltre, gli fornisce una serie di scuse per rinviare ulteriormente il processo penale a suo carico”. Harel sottolinea però che Netanyahu non avrebbe mai agito senza aver ricevuto il pieno sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vuole creare “una nuova realtà in Libano”. ◆
Tariq Hathaleen è un attivista, insegnante di inglese e leader della comunità di Umm al Khair. Ahmed Hathaleen è un attivista e giornalista di Umm al Khair.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1642 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati