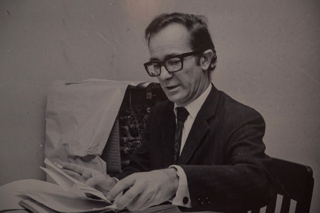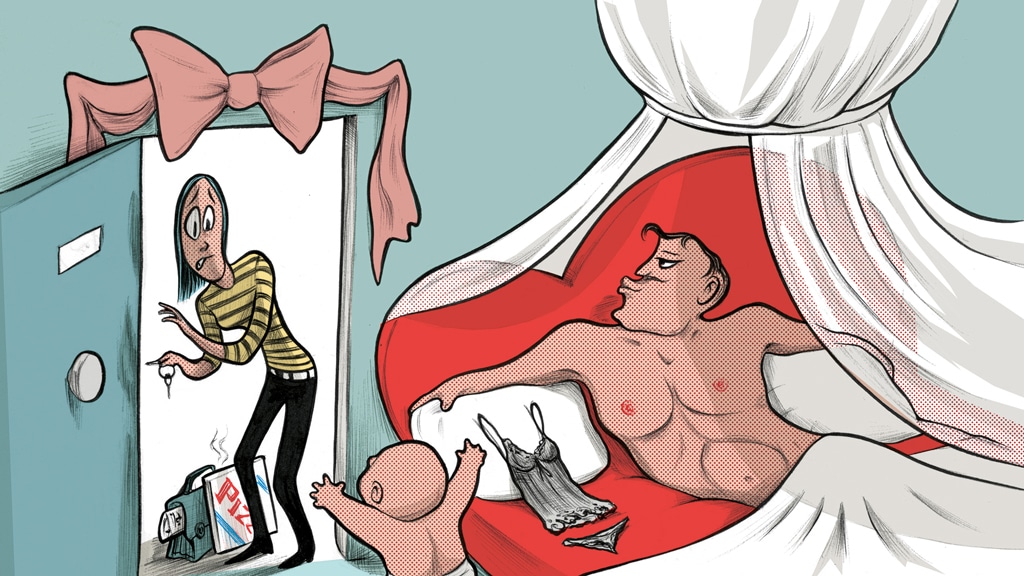È facile essere critici nei confronti delle conferenze delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. La Cop30, in corso fino al 21 novembre a Belém, in Brasile, ha suscitato le consuete lamentele: questi vertici sono troppo affollati e burocratici, e non producono abbastanza risultati. Dopo trent’anni di conferenze, le emissioni di gas serra continuano ad aumentare e secondo molti il sistema è inadeguato ad affrontare il problema.
Ma queste critiche non colgono il punto. Le emissioni stanno aumentando molto più lentamente di quanto avverrebbe senza le regole dell’Onu. Nel 2009 i climatologi avvertivano che se gli stati non avessero fatto niente la temperatura media globale sarebbe salita di sei gradi rispetto al periodo preindustriale. Prima dell’accordo di Parigi del 2015, il riscaldamento previsto era sceso a quattro gradi, e oggi le Nazioni Unite calcolano che se non si adotteranno altre misure le temperature saliranno di circa due gradi e mezzo.
Questo calo costante è dovuto al fatto che, contrariamente a quanto si pensa, il mondo sta davvero facendo qualcosa contro la crisi climatica. Negli ultimi 15 anni la drastica riduzione del costo delle fonti rinnovabili di energia, soprattutto il solare e l’eolico, ha fatto sì che il loro uso aumentasse in modo straordinario. Nel 2025 o nel 2026 le rinnovabili produrranno per la prima volta più elettricità del carbone. Una transizione simile sta riguardando i veicoli elettrici, che ormai rappresentano più di un quinto del mercato.
Secondo gli scettici questo è merito dell’innovazione tecnologica e non delle conferenze delle Nazioni Unite. Ma l’innovazione non avviene da sé: è guidata dalle misure che la rendono redditizia. Negli ultimi vent’anni i governi di tutto il mondo hanno introdotto standard di efficienza energetica, obiettivi per le rinnovabili e sovvenzioni che hanno stimolato le aziende a migliorare le tecnologie. Con il calo dei costi – soprattutto dagli anni dieci, quando la Cina ha avviato la produzione di massa delle tecnologie verdi – è stato possibile adottare obiettivi più ambiziosi, facendo calare ulteriormente i costi. È stato un circolo virtuoso: le politiche hanno stimolato l’innovazione e viceversa.
È per questo che i negoziati dell’Onu sono importanti. L’accordo di Parigi vincola ogni stato a presentare obiettivi e piani sempre più ambiziosi ogni cinque anni. Senza un coordinamento internazionale sarebbe stato molto improbabile che così tanti paesi si muovessero insieme nella stessa direzione. È questo impegno globale a indirizzare la crescita dei mercati a bassa emissione di carbonio.
Secondo i critici, però, i piani nazionali non sono sufficienti. Due gradi e mezzo di riscaldamento saranno anche meglio di sei, ma le conseguenze saranno comunque catastrofiche.
È vero che l’accordo di Parigi ha un difetto fondamentale: stabilisce un obiettivo per la temperatura globale, ma lascia a ogni stato la libertà di decidere come raggiungerlo. I nuovi piani nazionali presentati prima della Cop30 non sono ancora sufficienti a raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5-2 gradi. Questo “divario delle emissioni” sembra dar ragione ai critici.
Ma sarebbe una conclusione troppo affrettata. I piani nazionali, noti come Contributi determinati a livello nazionale (Ndc), non sono previsioni. Gli stati preferiscono evitare di fissare obiettivi che potrebbero essere compromessi da eventi imprevisti. Ma molti considerano gli Ndc un obiettivo minimo, non massimo. I nuovi Ndc cinesi ne sono un esempio. Diversi commentatori li hanno giudicati deludenti. Ma nell’annunciarli il presidente Xi Jinping ha detto che il paese cercherà di superarli. I dati degli ultimi 15 anni suggeriscono che sarà così.
Soluzioni informali
Un altro motivo di ottimismo è che i paesi più poveri non sanno ancora quanto sostegno finanziario riceveranno, ma questo nei prossimi cinque anni diventerà più chiaro. Alla Cop30 il Brasile e l’Azerbaigian, che ha ospitato il vertice precedente, hanno presentato la Roadmap Baku-Belém, un piano per raccogliere 1.300 miliardi di dollari di finanziamenti entro il 2035. Anche se si arrivasse solo a una parte di questa somma, molte economie emergenti saranno in grado di ridurre le emissioni più in fretta di quanto suggeriscano i loro piani attuali.
Infine bisogna ricordare che le iniziative sul clima nascono sempre di più al di fuori delle trattative formali. I progressi, ora, dipendono meno dalla negoziazione di nuove norme e più dalla loro attuazione. A Belém sono state annunciate iniziative importanti per la tutela delle foreste pluviali tropicali, i combustibili sostenibili, l’agricoltura rigenerativa, i crediti di carbonio, le emissioni di metano, la lotta agli incendi, l’infrastruttura pubblica digitale, le tasse sui biglietti aerei e le risorse finanziarie per l’adattamento. Chi critica il grande numero di partecipanti alle conferenze spesso ignora che molti di loro hanno un interesse diretto in queste e in altre soluzioni alla crisi climatica.
Il Brasile e altri paesi sperano che in futuro questi vertici riguarderanno più iniziative settoriali e finanziarie che negoziati di regole più dettagliate. L’azione sul clima sta entrando in una nuova era. Ed è proprio questo il senso delle regole internazionali: una cornice per incoraggiare ambizioni, coordinamento e responsabilità crescenti.
Ovviamente non bisogna ignorare i problemi. Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, il presidente Donald Trump continua la sua campagna per favorire i combustibili fossili e ostacolare le energie rinnovabili. La politica sul clima è diventata uno scontro tra visioni alternative del futuro energetico e industriale, che si combatte non solo durante i negoziati dell’Onu, ma anche nei governi e nei consigli di amministrazione.
Non c’è dubbio che la transizione energetica è in corso. Ma il suo ritmo dipende dalla fiducia delle aziende nella sua prosecuzione. E per questo occorre il costante impegno dei governi a raggiungere gli obiettivi climatici, affinché gli investimenti e l’innovazione restino redditizi. Definire inutili le conferenze sul clima rischia di minare questa fiducia. I critici delle Cop amano considerarsi paladini della verità. Ma potrebbero finire per diventare i complici involontari di Trump. ◆ sdf
Michael Jacobs insegna economiapolitica all’università di Sheffield,nel Regno Unito.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati