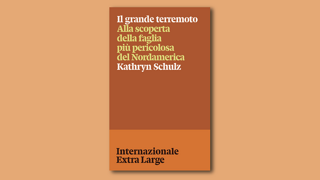La possibilità di raggiungere una tregua in Ucraina è oggetto di accesi dibattiti (e di forte scetticismo) tra gli analisti politici. Ma tra gli economisti un punto d’accordo è stato raggiunto: sul piano finanziario continuare la guerra non è nell’interesse della Russia. L’invasione dell’Ucraina sta divorando le riserve, gonfiando il deficit di bilancio e portando l’economia in recessione. Eppure sono in pochi a discutere di cosa succederebbe se i combattimenti finissero. L’economia russa, ormai convertita alla produzione bellica, è del tutto impreparata alla pace.
Quanto spenda la Russia per la guerra è più o meno chiaro: i costi del bilancio federale, dei bilanci regionali e delle imprese sono stimati tra 25 e 47 miliardi di rubli al giorno, cioè tra 260 e 495 milioni di euro. Lo Stockholm international peace research institute prevede che entro la fine del 2025 la spesa militare russa raggiungerà il 7,2 per cento del pil, il livello più alto dai tempi sovietici (nel 1990 la cifra era del 12–13 per cento). Questa iniezione di fondi pubblici è distribuita tra i circa seimila fornitori e appaltatori che compongono il complesso militare-industriale russo, come indicato nel registro riservato del ministero dell’industria e del commercio di Mosca. Il Dossier center, un centro di giornalismo d’inchiesta creato dall’ex oligarca russo in esilio Michail Chodorkovskij, ha avuto accesso ai dati nella primavera del 2025 e ha scoperto che circa un terzo di queste imprese (2.023 per l’esattezza) opera nella radioelettronica. Le altre si occupano di aviazione (390), macchine utensili e ingegneria pesante (216), armi convenzionali (167), munizioni e prodotti chimici (86).
La macchina bellica riceve forniture anche da imprese del settore civile: dall’industria leggera, che produce uniformi militari, generi alimentari e legname (298 aziende) alla cantieristica navale (265). Per farla breve, il registro non comprende solo aziende che fabbricano armi. “Nello sforzo bellico sono state coinvolte circa 850 imprese che non avevano alcun rapporto con la difesa”, ha spiegato il ministro dell’industria Anton Alichanov nel giugno 2024. Molte di queste operano ancora liberamente: solo il 47 per cento è stato sottoposto alle sanzioni internazionali. Dall’analisi di un quarto di quelle iscritte all’anagrafe del complesso militare-industriale è inoltre emerso che il volume delle importazioni è all’incirca lo stesso per le tutte le aziende, che siano sotto sanzioni o no. Un’eventuale revoca delle misure occidentali non darà quindi una particolare spinta economica al paese.
Oggi in Russia non ci sono regioni interamente dipendenti dall’economia di guerra. Tuttavia i grandi conglomerati dell’industria bellica sono concentrati in determinate zone. Se i contratti della difesa dovessero ridursi, alcune di queste aree andrebbero in recessione. La maggior parte delle aziende coinvolte ha sede a Mosca (1.645), a San Pietroburgo (786) e nella regione di Mosca (524), anche se in molti casi gli impianti sono altrove. Le regioni che più risentirebbero della fine della guerra sono il Tatarstan e le oblast di Nižnij Novgorod, Sverdlovsk, Čeljabinsk, Samara, Rostov, Tula, Novosibirsk e il territorio di Perm.
Nella zona di Sverdlovsk, che ospita il 20 per cento delle imprese belliche del paese, la Uralvagonzavod produce materiale rotabile ferroviario e attrezzature da combattimento, come carri armati, veicoli corazzati e da ricognizione. La regione di Tula è il più grande produttore di munizioni, armi leggere, artiglieria e armi anticarro e antiaeree. A Rostov si fanno gli elicotteri, mentre in Tatarstan ci sono una fabbrica di droni e la casa automobilistica Kamaz: un terzo della sua produzione è destinato all’esercito.
In totale, nel complesso dell’industria bellica russa lavorano 3,8 milioni di persone. Eppure il settore non riesce a soddisfare tutti gli ordini. Secondo il primo vicepremier Denis Manturov, nonostante un significativo afflusso di lavoratori dall’industria civile c’è ancora bisogno di circa 160mila persone.
Nel complesso dell’industria bellica russa lavorano 3,8 milioni di persone
Se arriva la pace
Gli economisti sono concordi nel ritenere che la guerra è sempre dannosa per l’economia. Un’analisi dei dati di 133 paesi nel periodo tra il 1960 e il 2012 ha dimostrato che un aumento della spesa militare pari all’1 per cento del pil riduce la crescita economica dell’1,1 per cento. Inoltre, quando cresce la spesa per la difesa diminuiscono inevitabilmente gli investimenti sociali. Secondo gli esperti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, in caso di guerra il calo del pil pro capite può raggiungere il 40–70 per cento.
Se si guarda agli esempi passati, si capisce che il ritmo della ripresa postbellica varia notevolmente: in circa un terzo dei casi il pil pro capite torna al livello registrato in paesi simili senza guerre nell’arco di cinque anni; tuttavia, in quasi la metà dei casi rimane sotto questo livello anche 25 anni dopo la fine del conflitto. “Il recupero è particolarmente difficile se la pace raggiunta è instabile. Inoltre, anche se il pil torna a crescere, possono comunque rimanere cicatrici indelebili, che colpiscono le risorse del lavoro e il capitale”, spiegano i ricercatori europei. Le guerre portano a un aumento delle spese di bilancio che si protrae per decenni e che comprende gli obblighi finanziari nei confronti dei veterani e gli interessi sui debiti accumulati per coprire le spese militari.
Dopo la fine di una guerra gli ordini della difesa non sempre calano immediatamente: a volte capita perfino che aumentino. In questo caso l’obiettivo è ripristinare le scorte di armamenti ed evitare l’improvviso collasso di un’economia diventata nel frattempo dipendente dalle spese belliche. Una situazione simile si è verificata, per esempio, dopo il conflitto tra India e Pakistan del 1999, noto come la guerra di Kargil. Anche in Russia è difficile immaginare che una tregua porti a una riduzione della spesa militare. “Sono andate perse così tante attrezzature che per almeno altri cinque-dieci anni l’industria della difesa funzionerà a pieno regime, e forse addirittura si espanderà”, spiega l’economista russo Vladislav Inozemtsev.
In ogni modo, è inevitabile che dopo la fine di un conflitto prima o poi il bilancio della difesa cominci a ridursi. Konstantin Sonin, professore dell’università di Chicago, ritiene che quando la guerra finirà, tutte le fabbriche cresciute durante il conflitto – soprattutto quelle produttrici di armi – diventeranno centri di disoccupazione: “Le più colpite saranno le cosiddette imprese ad alta tecnologia, che producono droni e sistemi di controllo missilistico di precisione. In questo modo si ripeterà il dramma degli anni ottanta e novanta, quando centinaia di migliaia di persone persero il lavoro nel settore della difesa e pretesero che il governo mantenesse invariata la spesa per la produzione di armi di cui il paese non aveva bisogno”. Allo stesso tempo, chiarisce Sonin, la smilitarizzazione dell’economia russa sarà necessaria per rendere possibile una futura prospettiva di crescita.
Anche molte imprese civili perderanno il sostegno dei contratti statali nel settore della difesa, e il flusso di lavoratori provenienti da queste aziende, oltre che dal settore della difesa propriamente detto, causerà una stagnazione della crescita salariale, mentre il carovita eroderà i redditi reali. Molto dipenderà da quali sanzioni saranno revocate in caso di tregua.
Secondo Sonin, anche in caso di un accordo di pace non ci sarà una completa revoca delle sanzioni. Tuttavia, per aiutare l’economia russa basterebbe un parziale allentamento dell’isolamento internazionale del paese: “Gli esportatori avranno più soldi, i russi in generale avranno più soldi e questo contribuirà alla crescita”.
Inozemtsev è scettico sulla reale portata di questa crescita: “Le forniture di petrolio alla Cina e in parte all’India vengono stabilite con un anno o due di anticipo e Putin non le reindirizzerà verso l’Europa. Al massimo, la riapertura del mercato europeo potrebbe portare al ripristino delle forniture di gas, ma i ricavi del settore sono circa cinque volte più bassi di quelli del petrolio. Per quanto riguarda quest’ultimo, potrebbero sparire gli sconti concessi all’India e si ridurrebbero le spese di trasporto e i costi per l’elaborazione dei pagamenti. In questo modo il prezzo al barile crescerebbe di 10–12 dollari”.
Inoltre un impatto positivo potrebbe averlo anche il cambiamento del clima imprenditoriale nel paese. “I dirigenti d’azienda stanno aspettando che la guerra finisca per avere certezze sugli investimenti. Se ci sarà la pace”, conclude Inozemtsev, “l’economia si riprenderà indipendentemente dalle esportazioni di petrolio verso l’Europa”. ◆ ab
The Insider è un sito d’informazione indipendente russo, in esilio a Riga, in Lettonia.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1637 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati