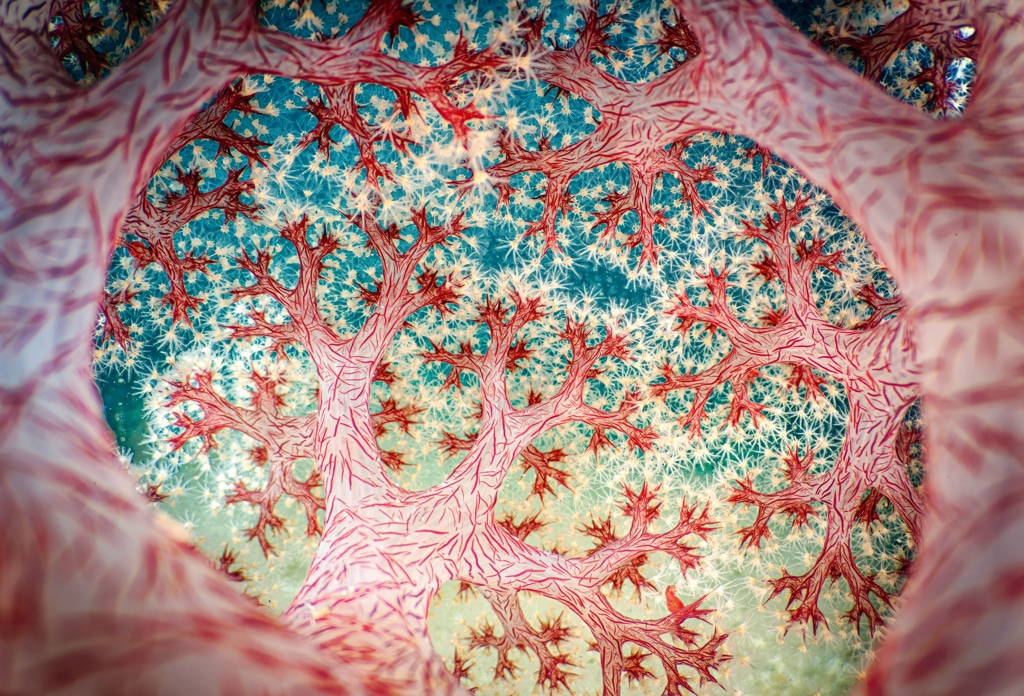C’è voluta la caduta dell’antica capitale del Darfur perché la comunità internazionale prestasse finalmente attenzione alla guerra civile sudanese. Sono passati due anni e mezzo dal suo inizio, nell’aprile 2023, e quattro dal colpo di stato che ha interrotto la transizione civile avviata dal movimento popolare che aveva sfidato una delle più antiche dittature del continente, quella di Omar al Bashir (1989-2019).
L’entità dei massacri compiuti dal 25 ottobre commuove le opinioni pubbliche di tutto il mondo, com’era successo nel 2004 davanti al ripetersi delle uccisioni di massa nella stessa regione del Sudan. La soluzione politica promessa allora dalla diplomazia internazionale non prese forma, perché non si fecero abbastanza pressioni sul governo di Khartoum e sui molti gruppi armati del Darfur, visto che ai tempi era considerata più importante l’indipendenza del Sud Sudan. Riguardo al Sudan occidentale prevalse un atteggiamento vittimistico, con gli aiuti umanitari e la compassione che nascondevano le difficoltà a risolvere quei problemi sociali e politici che avevano reso possibile il massacro.
Oggi ci ritroviamo con gli stessi gruppi armati, certamente invecchiati, ma sempre ambiziosi e poco attenti al futuro delle comunità che pretendono di rappresentare. Il gioco internazionale infatti è cambiato radicalmente: sono state messe in discussione alcune regole fondamentali del diritto internazionale e sono emerse potenze medie che, in un modo o nell’altro, pretendono di avere voce in capitolo sul futuro del Sudan, sulla sua forma di governo, sulla scelta dei suoi dirigenti, sullo sfruttamento delle sue risorse e sulle sue alleanze regionali.
Sarebbe sbagliato interpretare questa guerra come la semplice conseguenza dell’ambizione di due generali: Abdel Fattah al Burhan, capo delle forze armate, e Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, capo di una milizia paramilitare, le Forze di supporto rapido (Rsf), che erano alleate dell’esercito fino al 15 aprile 2023. Avevano combattuto insieme in Darfur all’inizio degli anni duemila e si erano ritrovati fianco a fianco nella primavera del 2019 per arrestare l’allora presidente Omar al Bashir e tentare, senza successo, di sedare una rivolta popolare.
Si erano alleati anche nell’ottobre 2021 per porre fine a un governo di transizione confuso, inefficace sotto molti aspetti, ma che cercava di riprendere il controllo di un’economia dominata dagli interessi di persone vicine al vecchio regime e ai militari.
Una profonda crisi economica
Il conflitto tra i due, cominciato nell’aprile 2023, è passato da uno scontro urbano tra due forze armate a una guerra civile. Per spiegarlo bisogna ricordare la profonda crisi economica del periodo finale del regime islamista, che aveva compromesso ciò che restava del tessuto sociale e aveva spinto le diverse comunità a ripiegarsi su se stesse. Va inoltre sottolineato il ruolo, già essenziale negli anni duemila, dei servizi segreti militari, della fazione più militarista del partito islamista al potere e delle Rsf nell’aggravare le tensioni intercomunitarie, oltre all’emergere di altri gruppi armati che si sostengono con i saccheggi e la distruzione delle infrastrutture ancora in piedi.
Ciò che è accaduto richiama i tragici eventi degli anni duemila, quando il conflitto si è gradualmente ampliato. La crisi sudanese non rimarrà entro i confini del paese. Dovremo sorprenderci se scoppieranno disordini in Ciad, nella Repubblica Centrafricana o nel Sud Sudan, tutti paesi che hanno un ruolo in questa economia di guerra, come già lo hanno avuto più o meno volontariamente vent’anni fa?
Anche se la crisi alla base di questa guerra è profondamente locale – riguarda il fallimento della transizione dopo trent’anni di dittatura, nonché le gerarchie sociali e le disuguaglianze che il regime ha esacerbato – è il nuovo contesto internazionale a spiegarne la durata e l’intensità. I paesi che hanno interessi in Sudan sono noti: Russia, Iran, Qatar, Turchia, Egitto appoggiano l’esercito; Emirati Arabi Uniti, Ciad, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Etiopia, la Libia di Khalifa Haftar sostengono le Forze di supporto rapido (Rsf).
Misure inefficaci
Il loro coinvolgimento non è sempre uguale, i loro interessi mirano più all’affermazione della propria influenza che alla conquista di minerali o terre fertili, o ad avere un ruolo dominante nella regione. Ma tutti contribuiscono al perpetuarsi della guerra. Va anche sottolineato il ruolo della Cina, da molti anni principale partner commerciale del Sudan, indifferente al collasso del paese ma pronta a vendere a entrambe le parti i suoi droni.
Il paradosso è che questi paesi sono indispensabili alla diplomazia occidentale in due conflitti considerati centrali – le guerre in Ucraina e a Gaza – e tutti, tranne gli stati paria (Russia e Iran), pesano sulle bilance commerciali e sugli investimenti diretti in occidente. Dietro i superlativi moralizzanti delle dichiarazioni ufficiali, c’è il nulla: nessuna sanzione, nessun intervento per bloccare i flussi di armi e contribuire a una soluzione politica. Gli aiuti umanitari, assolutamente necessari, prendono il posto di un’azione diplomatica incisiva.
L’amministrazione statunitense di Joe Biden (2020-2024) non ha fatto praticamente nulla se non promuovere incontri tra le parti in conflitto a Jedda, in Arabia Saudita, mossa più dall’urgenza di migliorare le relazioni con Riyadh che dall’esigenza di trovare una soluzione alla crisi sudanese. L’Unione africana ha perso credibilità per il suo sostegno ai militari, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad, un’organizzazione dei paesi del Corno d’Africa e dell’Africa orientale) per i suoi legami commerciali con le Rsf. L’Unione europea ha investito risorse con buone intenzioni ma senza prendere provvedimenti rilevanti contro i responsabili della guerra sudanese e i loro sponsor internazionali.
In questo contesto arriva il presidente statunitense Donald Trump. Come ha fatto nell’est della Repubblica Democratica del Congo e a Gaza, cerca di ottenere una tregua umanitaria (anche se non rispettata) senza curarsi troppo, a quanto pare, di una soluzione politica globale. Il Sudan, ancora una volta, rischia di rimanere a metà strada: forse arriverà il cessate il fuoco, ma non la soluzione dei problemi che ogni vent’anni portano questo paese sull’orlo del baratro. ◆ adg
Roland Marchal è un esperto francese dell’Africa subsahariana, in particolare delle sue guerre civili.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1640 di Internazionale, a pagina 44. Compra questo numero | Abbonati