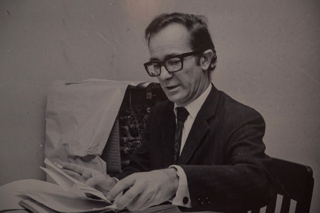Gli odori raccontano il paesaggio che abbiamo intorno, evocano ricordi, suscitano emozioni. Ci spingono a compiere azioni e fare determinate scelte. La scienza li studia, il marketing invece usa il loro potere evocativo per attirare clienti e vendere prodotti: alcuni negozi usano nebulizzatori di profumo per indurre a spendere di più, i fast food per far venire fame, le compagnie aeree per rilassare i passeggeri. Certe aziende creano invece delle “nuvole aromatiche” per aumentare la produttività. E poi ci sono le esperienze sensoriali che abbinano alle opere d’arte un certo profumo, coinvolgendo lo spettatore anche attraverso l’olfatto.
Ma gli odori ci servono anche a riconoscere eventuali pericoli per la salute delle persone. Sempre più spesso le agenzie per la protezione dell’ambiente ricevono segnalazioni su cattivi odori, sia legati a cause già note, per esempio la vicinanza di raffinerie o impianti di trattamento dei rifiuti, sia a situazioni ancora sconosciute, che vengono a galla proprio per via degli odori.
Come riconoscere gli odori e, soprattutto, come misurarli? La metodologia che permette di farlo è l’olfattometria dinamica. “Usiamo molti strumenti per misurare gli odori, ma quello di gran lunga più sensibile è ancora il nostro naso: attualmente nessuno strumento può arrivare alla sua precisione”, spiega Silvia Rivilli, che nel 2003 a Udine ha collaborato alla fondazione del laboratorio di olfattometria dinamica (Lod). “Per capire se un odore può infastidire chi lo sente si usa un diluitore, che diffonde nell’aria una quantità crescente di molecole odorose, fino a che sono percepite dai recettori olfattivi nella mucosa nasale, che poi trasmettono segnali al cervello”.
Non tutti i nasi però sono uguali. E allora per misurare l’intensità di un certo odore è necessario selezionare persone che abbiano un olfatto rappresentativo dell’intera popolazione. “I nostri olfatti sono diversi e rispondono in modo differente”, dice Rivilli. A incidere sono fattori esterni (la temperatura, il grado di umidità) e interni (un raffreddore, le protesi dentarie, ma anche i cambiamenti ormonali). “Solo il 30 per cento della popolazione soddisfa i nostri requisiti”.
Dopo aver individuato un odore, i ricercatori fanno delle simulazioni per capire fin dove quell’odore potrebbe diffondersi nell’ambiente, e chi potrebbe percepirlo. È la cosiddetta modellistica della dispersione: “Nella maggior parte dei casi a un odore non è collegato un rischio sanitario, ma il fastidio che causa alle persone”, afferma Rivilli. “Prima che nasca un nuovo stabilimento, possiamo già sapere dove arriverà l’odore e se sarà fastidioso per gli abitanti della zona”.
Lo spartiacque in Italia è stato il decreto legislativo 183 del 2017, secondo cui le emissioni odorigene sono a tutti gli effetti una forma di inquinamento, e il superamento dei limiti è sanzionabile. Questo ha spinto a modificare l’approccio delle istituzioni, delle aziende e dei cittadini nei confronti degli odori.
Nel 2023 il decreto 309 ha definito le linee guida nazionali sulle emissioni odorigene di impianti e attività produttive come laboratori di tinteggiatura, falegnamerie e ristoranti, stabilendo limiti diversi in base al tipo di area: più bassi nei centri urbani, più alti nelle zone industriali e agricole.
“L’odore è un problema solo se qualcuno lo percepisce come qualcosa che non va?”, afferma Rivilli. “Se la pianificazione urbana è fatta in maniera approssimativa, ecco che nascono i problemi. Ci sono zone in cui le case sono state costruite a poche decine di metri dalla ciminiera di una fonderia. La responsabilità non è solo delle aziende, ma anche delle amministrazioni”.
Nel 2015 il laboratorio di olfattometria dinamica di Udine ha lanciato l’app Geonose, che permette di creare progetti di monitoraggio grazie ai quali chiunque può segnalare le cosiddette molestie olfattive in una certa zona. L’approccio è quello della citizen science, che prevede un coinvolgimento attivo delle comunità locali nella ricerca scientifica. Incrociando in tempo reale la geolocalizzazione, la data e l’ora delle segnalazioni con i dati meteorologici e la direzione dei venti, si può “seguire” l’odore e capire da dove proviene, in modo da risolvere velocemente un eventuale problema.
L’app è usata sia dai comitati di cittadini sia dalle aziende che vogliono monitorare il proprio impatto sul territorio. Ci sono casi più critici, in cui gli abitanti si scontrano con le aziende, e altri in cui si apre un dialogo, spesso mediato dalle istituzioni.
“Raramente ci si pensa, ma uno dei settori con più effetti a livello di odori è quello della ristorazione, in particolare nei centri storici delle città”, racconta Rivilli. “Sono stati aperti molti contenziosi civili e penali”.
In Sicilia, per monitorare le molestie olfattive dal 2019 c’è il progetto Nose (Network for odour sensitivity), messo a punto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) insieme al Cnr-Isac. I territori su cui ci si concentra di più sono le aree a elevato rischio di crisi ambientale (Aerca) di Siracusa, Gela e la valle del Mela, oltre all’area di Catania.
Attraverso un’app è possibile raccogliere in tempo reale e in forma anonima le segnalazioni: se il limite di dieci nell’arco di un’ora e nel raggio di cinquecento metri da uno dei campionatori automatici di aria è superato, scatta il prelievo. Il campione poi è analizzato per identificare la presenza di eventuali inquinanti. Dopo 15 segnalazioni in un’ora nello stesso comune è attivato il sistema di allarme. “Attraverso le segnalazioni è possibile tracciare il percorso degli odori fino alla loro origine”, spiega Anna Abita, direttrice dell’unità sulla qualità dell’aria dell’Arpa. “Questo ci permette di fare controlli più specifici, e soprattutto di rendere evidente il problema delle molestie olfattive attraverso la raccolta di dati”.
La maggior parte delle segnalazioni arriva dall’Aerca di Siracusa, dove la presenza dell’industria petrolchimica contribuisce all’emissione di varie sostanze inquinanti. Il polo è il più grande d’Italia, il secondo più grande in Europa dopo quello di Rotterdam, nei Paesi Bassi, e comprende tre impianti di raffinazione petrolifera, due stabilimenti chimici, tre centrali elettriche, un cementificio, due fabbriche di gas industriale e decine di aziende dell’indotto. In totale produce il 30 per cento del fabbisogno nazionale di idrocarburi.
Dal 2019 a oggi in quell’area più di cinquemila persone si sono registrate alla piattaforma Nose, inviando oltre ventiduemila segnalazioni. La tipologia di odore più segnalata è quella degli idrocarburi (67 per cento), mentre i disturbi più riscontrati sono le difficoltà respiratorie (26 per cento) e l’irritazione alla gola (20 per cento).
“L’odore è importante, Nose può sembrare uno strumento di poco conto, ma in realtà è fondamentale”, dice Cinzia Di Modica del comitato Stop veleni, che da dieci anni si batte per difendere i diritti degli abitanti e del territorio. “Prima quando sentivamo un odore cattivo bisognava chiamare la prefettura, mandare un fax, invece ora le segnalazioni arrivano in tempo reale alle istituzioni”.
I dati raccolti dal progetto sono usati sia per il monitoraggio della situazione sia per denunciare il superamento dei limiti di legge di alcune sostanze inquinanti. “Nelle giornate in cui c’era una molestia olfattiva intensa e persistente abbiamo presentato alcuni esposti in procura: dietro alla puzza potrebbero nascondersi sostanze tossiche, come benzene, dichiarato cancerogeno dall’Organizzazione mondiale della sanità”, conclude Di Modica. “Ogni cittadino dovrebbe avere il diritto di vivere in un ambiente sano e poter aprire le finestre di casa in libertà”.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it