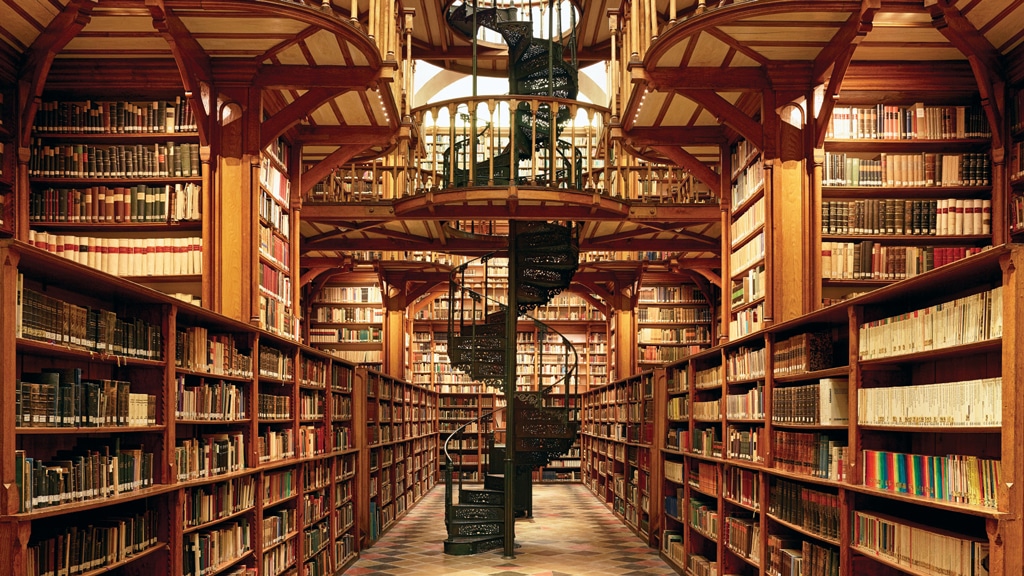Pioveva su Harlem. Ero fermo all’angolo tra Amsterdam avenue e la 162ª strada, il cappotto ormai bagnato, il mio vecchio ombrello che a malapena sopportava le repentine folate di vento. Erano quasi le quattro del pomeriggio e cominciava già a farsi buio. Non conoscevo Harlem. Non sapevo in che direzione andare. Non sapevo da che parte era Edgecombe avenue, a Washington Heights. Rimasi semplicemente là a guardare la strada davanti a me, come se potessi riconoscere qualcosa tra la pioggia e il vento e il rapido crepuscolo di dicembre. Mi strinsi sotto l’ombrello. A stento riuscii ad accendermi una sigaretta floscia e umida.
Da Marjorie, suppongo.
Mi spaventò, lì accanto a me, stoica. Sembrava che la pioggia non la infastidisse. O sembrava non sapere che stava piovendo. Vai da Marjorie, suppongo, mentre tirava fuori dal borsone un paio di guanti fini di lana nera. Ma non sai come arrivarci, mentre tirava fuori dal borsone una lunga sciarpa della stessa lana nera. Si vede lontano un miglio.
Al mio orecchio il suo inglese aveva un lieve accento. Forse caraibico. O africano. La pelle del volto era di un nero profondo e perfetto e forse ancora liscio. Il bianco dei suoi occhi brillava nella penombra. Solo qualche filo grigio nei capelli – tagliati in un afro cortissimo – tradiva la sua età.
È così ovvio?, le domandai, e lei si abbottonò l’impermeabile nero, incrociò le braccia e mi disse che era per via del giorno, dell’ora, della fermata della metropolitana all’angolo tra Amsterdam avenue e la 162ª, dell’espressione del volto, del fatto che trovava sempre qualcuno fermo lì. Tirò fuori dal borsone un cappello di feltro nero a cloche, stile anni venti. Trovi gente che ha l’aria di essersi smarrita in piena Harlem?, le chiesi. O trovi gente con l’aria di essere disperatamente in cerca di un modo per arrivare da Marjorie? E sorrisi con un misto di vergogna e sollievo. Qualcosa del genere, disse. Andiamo, disse. Di qua, ragazzo, già camminando. Io mi sbrigai e diedi un ultimo tiro di sigaretta, e schiacciandola per terra scoprii con inquietudine o forse con piacere che sotto le spesse pieghe dell’impermeabile nero, incuranti degli schizzi delle pozzanghere, c’erano i suoi stivali da cowboy rosso sangue.
Prima volta, allora?
Mi sorprese che il suo passo fosse così lento e così fluido. Come cadenzato. Come quello di un’indossatrice su una passerella: elegante, esotica, consapevole di essere osservata. Come se non avesse alcuna fretta di arrivare e togliersi dalla pioggia. Le allungai più volte il mio ombrello – misero e fragile per quel vento – ma lei non se ne accorse, o non le importava, o non voleva avvicinarsi troppo a uno sconosciuto. Dal bordo del cappello le colavano giù delle gocce. Io ero ancora stregato dai suoi stivali rosso sangue. Forse per il rosso sangue. Forse per il fatto che non ho mai avuto degli stivali da cowboy. Troppo timido.
Sì, prima volta, dissi. Un amico mi ha mandato una cartolina, dissi, una foto di Marjorie con un lungo abito turchese o verde menta, e mani di ebano, e l’indirizzo dell’appartamento in Edgecombe avenue, ma senza raccontarmi molto di più. Pensai di tirar fuori la cartolina e mostragliela, come prova. Allora non sai chi è Marjorie? Più o meno, dissi, un po’. Ci fermammo all’angolo tra Amsterdam avenue e la 161a. Guarda, quelli vanno da lei, mi disse indicando due passanti con una cartina piegata in mano. E anche loro, indicando un altro gruppo. E anche lui, indicando un signore di una certa età, in giacca e cravatta, che aveva con sé una grande custodia nera. Come fai a saperlo? Lei sorrise o forse sorrise nel buio. Ormai sono tante domeniche, ragazzo.
Il semaforo diventò rosso e attraversammo la strada.
Marjorie Eliot si chiama, disse. Sono anni che apre le porte del suo appartamento ogni domenica, tutte le domeniche, senza un giorno di riposo né vacanze, da una domenica del 1992, quando è morto suo figlio. Rimase in silenzio. Una feroce raffica di vento ci colpì in pieno. Ogni domenica un concerto jazz, continuò. Jazz da salotto. Alle quattro del pomeriggio. Nel suo appartamento. Con musicisti ogni volta diversi. I musicisti vanno e vengono. Musicisti esordienti, musicisti famosi, musicisti amici suoi. E sempre gratis. Tutti quelli che vogliono andare a trovarla e ascoltare un paio d’ore di jazz sono sempre i benvenuti in casa sua, e ormai sono tanti. Fece una pausa, respirò a fondo e poi, in tono affabile e al tempo stesso proibito, sussurrò: tutto per rendere onore alla memoria di suo figlio, attraverso la musica.
Girammo a sinistra. Mi domandò come mi chiamavo e be’, molto piacere, Eduardo, disse. Il mio nome è Shasta. Ci sono nomi che vibrano, mi passò per la testa allora o mi passa per la testa adesso. Ci sono nomi che uno desidera ardentemente gridare. Mi domandò di dove ero e io le dissi del Guatemala, che mi trovavo a New York solo per qualche giorno, solo di passaggio. Pensai di dirle che ero lì, di passaggio, per riscuotere una borsa Guggenheim – che Dio li benedica, scriveva Kurt Vonnegut o il narratore di Vonnegut – con cui poi, se fossi riuscito a vincere le mie paure e i miei demoni, sarei andato in Polonia, a Łódź, la città di mio nonno. Ma non dissi altro. E nemmeno lei domandò altro. Abituata, suppongo, come ogni newyorchese, al fatto che tutti sono lì di passaggio, che tutti sono lì per il proprio assurdo pellegrinare, che siamo solo una miserabile manciata di sale.
Attraversammo St. Nicholas avenue. Laggiù, disse mostrandomi qualcosa con lo sguardo, c’è il St. Nick’s Pub, il leggendario jazz club di Harlem. Ah, il vecchio Poospatuk, le dissi io e lei, di sfuggita, quasi complice, mi lanciò un mezzo sorriso. Qualcosa sapevo della storia del St. Nick’s Pub. Sapevo che quando aveva aperto per la prima volta, negli anni trenta, si chiamava The Pooseepahtuck club, come una tribù locale di nativi americani. Poi, negli anni quaranta, era stato ribattezzato Luckey’s Rendezvous dal nuovo proprietario, Luckey Roberts, il grande pianista stride che riusciva a estendere così tanto la mano sui tasti, dicevano, perché si era fatto tagliare la pelle tra le dita da un chirurgo. Poi, negli anni cinquanta, i proprietari successivi, dopo aver aggiunto un repertorio d’opera, lo avevano chiamato Pink Angel perché era un posto popolare, dicevano, tra gli omosessuali. Infine, dagli anni sessanta, era diventato il St. Nick’s Pub.
Arrivammo a Edgecombe avenue. Dall’altra parte c’era una piccola striscia di alberi. Dall’altra parte degli alberi c’era una strada. Dall’altra parte della strada, lontano, si sentiva scorrere placido il fiume Harlem. Voltammo a destra. Rimasi zitto, sperando che lei mi dicesse ancora qualcosa, impaziente di arrivare e al tempo stesso desideroso di non arrivare mai. Quasi subito si fermò davanti al portone nero di un enorme edificio dalle linee classiche, e rivolse lo sguardo verso di me. Uno sguardo colmo di qualcosa. Forse gentilezza. O noia. O leggenda. Mi sembrò che la pelle del suo volto, magari per l’umidità o per la luce di un vecchio lampione, ardesse nella notte. Disse: Marjorie Eliot dice di aver cominciato a ospitare concerti jazz nel suo appartamento, dopo la morte del figlio, come un modo per sopravvivere alle domeniche.
L’edificio al numero 555 di Edgecombe avenue ha vari nomi. Qualcuno lo chiama Paul Robeson residence. Altri Roger Morris building. Altri Triple Nickel. Altri ancora Count Basie place. Costruito nel 1916, per i primi venticinque anni fu un palazzo dove valeva la segregazione residenziale: era solo per bianchi. Ma intorno al 1939, quando cambiarono le caratteristiche sociali di Harlem, cambiarono anche le regole e i vincoli dell’edificio al numero 555, e diventò la casa di personaggi importanti e famosi della comunità afroamericana di Harlem. Come il musicista Count Basie. Come il compositore e pianista Duke Ellington. Come il sassofonista Coleman Hawkins. Come lo scrittore Langston Hughes. Come il giudice (e primo afroamericano alla corte suprema) Thurgood Marshall. Come il giocatore di baseball (e primo afroamericano nella major league) Jackie Robinson. Come il pugile (e primo afroamericano nel circuito professionistico del golf) Joe Louis. Come la cantante Lena Horne. Come la scrittrice Zora Neale Hurston. Come il cantante e attivista politico Paul Robeson. Come la pianista Marjorie Eliot.
Passa, passa, ragazzo.
Aveva tirato fuori un mazzo di chiavi, aveva aperto il pesante portone di ferro nero. Misi via l’ombrello ed entrai in fretta, mentre lei teneva il portone per un gruppo di turisti e li indirizzava verso l’ascensore dicendo di salire al terzo piano. Io restai lì a guardare l’atrio: grande, sfarzoso, interamente rivestito di marmo verde, grigio e beige, con zoccoli di gesso finemente lavorato e color oro. Sulle pareti c’erano bassorilievi sempre color oro, in cattivo stato, di bambini paffuti che giocavano, suonavano flauti e cavalcavano capre. Il soffitto era un’immensa vetrata, anche quella era in cattivo stato. Quando ero molto piccola, mi disse guardando in alto e al tempo stesso scrollandosi via l’acqua dall’impermeabile, decisero di verniciarla di nero e di coprirla con assi di legno. Si tolse i guanti. Si tolse il cappello. Si passò una mano sul suo corto afro sale e pepe, mentre faceva scivolare la punta rosata della lingua sul labbro superiore e poi sul labbro inferiore, come se leccasse delle goccioline di pioggia. Per proteggere la vetrata, disse. Da un ipotetico attacco atomico.
Andammo verso l’ascensore. E nell’attesa, io me la immaginai bambina, che cresceva lì dentro, che giocava e correva nell’atrio e nei corridoi e in mezzo a tutti quei bambini color oro e a tutti gli inquilini famosi dell’edificio, sempre con ai piedi i suoi stivali rosso sangue.
È tanto che conosci Marjorie? Sì, è tanto, disse lei. Era molto amica dei miei genitori. Pensai di domandarle chi erano i suoi genitori, di domandarle se vivevano ancora lì. Ma lo giudicai inopportuno. La domenica la aiuto come posso, disse. A volte metto le sedie. A volte sistemo le luci azzurre. A volte, nell’intervallo, servo bicchieri di succo d’arancia e biscottini, per i visitatori. A volte, disse, aiuto qualche anima smarrita a ritrovare il cammino. Sorrise con grazia. È il mio modo, anche se minimo e inutile, disse, di onorare la memoria di un figlio morto. Rimase in silenzio, e mi sembrò che avesse detto queste ultime parole con un’altra voce. Forse con una voce tremante o più rauca o un po’ rotta. Forse con la voce occlusa e falsa di un ventriloquo. E allora capii, capii con certezza, capii con assoluta sicurezza che anche lei aveva perso un figlio.
Le porte dell’ascensore si aprirono ed entrammo e lei premette il pulsante e salimmo lentamente, in silenzio. Entrambi guardando avanti. Entrambi guardando in alto. Entrambi guardando i suoi stivali rosso sangue. Entrambi sentendo o immaginando di sentire, in quello spazio che non è spazio, in quella piccola anticamera, la forza devastante ed eroica di una madre per il figlio morto.
All’improvviso risuonò lo scampanellio dell’ascensore. Si aprirono le porte. Tu scendi qui, disse, io proseguo fino all’ultimo piano. Rimasi un po’ sorpreso. Avevo dato per scontato che anche lei sarebbe venuta da Marjorie, che mi avrebbe accompagnato, e glielo dissi. Lei scosse la testa. Oggi no, disse. Oggi, disse, sopravvivo da sola.
Uscii nel corridoio. Sentii ancora lontana, come in sordina, come soffocata, la melodia dolce e dissonante di un pianoforte. Mi voltai verso l’ascensore, verso di lei. La ringraziai. Qui a destra, disse, appartamento 3F, disse, e sbrigati, ragazzo che sei già in ritardo. Il pianoforte smise di suonare, e poi un silenzio, e un lieve applauso. Lei mi sorrise solo con gli occhi. Tesi la mano, un po’ frettoloso e brusco, con il desiderio di rimandare l’inevitabile. Lei tardò a capire ma tese a sua volta la mano. E rimanemmo così un paio di secondi, forse neanche, ciascuno sul proprio lato della porta.
Eduardo Halfon è uno scrittore guatemalteco. Il suo ultimo libro pubblicato in italiano è Lutto (Il Saggiatore 2022). Il titolo originale di questo racconto è Surviving sundays. Traduzione a cura di Francesca Chiesura, Mauro Ghidoni, Chiara Romani, Giulia Romani, Rebecca Trevisi e Ilide Carmignani nell’ambito del corso “Tradurre il mondo” della Fondazione Unicampus San Pellegrino.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1630 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati