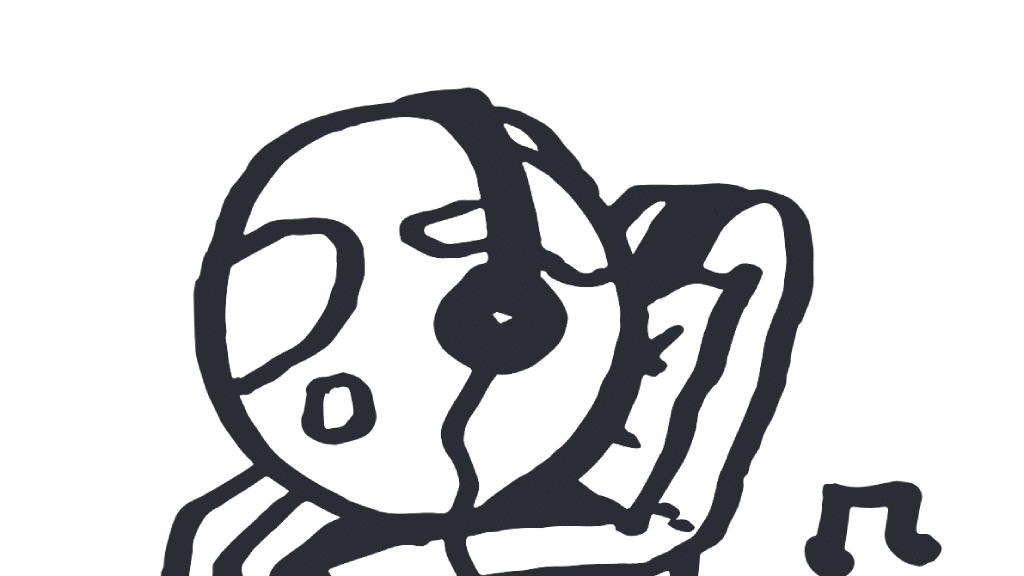Superare il confine tra Croazia e Bosnia a Orašje è un gioco da ragazzi. Il funzionario della dogana dà un’occhiata alla targa, inserisce nel computer i dati del documento d’identità e si può proseguire.
Il paesaggio cambia: dopo l’Ungheria e la Croazia orientale, dove le tracce della guerra di trent’anni fa sono quasi scomparse, perfino a Vukovar, che all’epoca era stata ridotta in macerie, i primi chilometri sul versante bosniaco mi portano in un mondo diverso. È sera. I supermercati lungo la strada danno l’impressione di negozi improvvisati. I distributori di benzina sono già chiusi.
Poco dopo c’è un altro confine, questa volta senza posti di blocco. I cartelli di benvenuto si vedono poco. Siamo nella Repubblica serba, una delle due entità della Bosnia Erzegovina. A Lončari svolto a sinistra verso Brčko, una piccola cittadina sul fiume Sava. Il paesaggio agricolo è spoglio. Le auto procedono lentamente, lo zelo della polizia locale è noto. Dopo qualche chilometro la prima sorpresa: sul muro di un edificio c’è un grande ritratto di Ratko Mladić, il criminale di guerra. Sotto si vede la lettera “Z”, simbolo dell’imperialismo russo.
Supero un altro confine e arrivo nel distretto di Brčko, una zona amministrata congiuntamente dalla Federazione croato musulmana e dalla Repubblica serba, creata come cuscinetto tra le due parti della Repubblica serba, che circondano la Federazione a est e a ovest. All’ingresso della città c’è l’hotel Evropa, con un’insegna al neon rotta. Il traffico è più intenso e le strade sono animate. Nel pub Tri sobe (Tre stanze) i clienti si riversano in strada. Per la prima volta da quando ho lasciato la città di Orašje, vedo di nuovo donne con il velo. I giovani proprietari dell’appartamento in cui passerò la notte sono pieni di speranza. Parlano bene dell’occidente, cosa non scontata tra i serbi. Vicino c’è il nuovo edificio dell’Università europea, un ateneo privato.
Il lago artificiale
Una breve passeggiata in città sembra dimostrare che bosniaci, croati e serbi riescono a convivere, anche se non mancano le tensioni. Le aspirazioni separatiste dall’entità serba, espresse con sempre maggiore audacia negli ultimi anni dal suo presidente Milorad Dodik, preoccupano non solo questa sponda della Sava.
A Brčko, però, regna la calma. Quando la sera chiedo a tre studenti i loro progetti per il futuro, non sembrano preoccuparsi della politica. Solo Esma, studente di economia, vuole andare all’estero. Le chiedo se in futuro tornerà in Bosnia. “Forse”, risponde sorridendo e scambiando uno sguardo con gli altri due. Di sicuro non a Brčko. Forse a Sarajevo.
La mattina dopo torno a Lončari. Lo scalpellino del posto conferma con orgoglio che il volto sul muro è quello di Mladić, poi osserva la mia reazione. Quando gli dico che vengo dalla Polonia annuisce soddisfatto. I polacchi sono benvoluti in tutti i Balcani.
Da Brčko mi dirigo verso sudest. Si cominciano a vedere le colline e all’orizzonte le montagne per cui la Bosnia Erzegovina è famosa. Il lago artificiale di Sniježnica è uno degli angoli più suggestivi di queste parti. Mi lascio alle spalle i boschi del monte Sniježnica e mi addentro nuovamente nella Repubblica serba. Il terreno degrada, rivelando una delle valli più belle di tutti i Balcani. Zvornik, con i suoi edifici ai piedi delle montagne, sorge sulle rive del fiume Drina. Alcuni minareti testimoniano la presenza dei suoi abitanti di ieri e di oggi. È impossibile dimenticare i crimini commessi qui trent’anni fa, anche se oggi ne restano poche tracce. Ad attirare l’attenzione è il ponte di Alessandro I, il primo re di Jugoslavia, tra il 1929 e il 1934. Il poliziotto che lo sorveglia vieta l’accesso. Oggi il ponte è un valico di frontiera che si percorre a piedi ed è riservato alla comunità locale. Sull’altra sponda della Drina, a meno di due chilometri di distanza, in territorio serbo, si trova Mali Zvornik.
Risalgo lungo il fiume che scorre maestosamente tra le montagne. Ogni volta che esco da uno dei tanti tunnel lungo la strada resto abbagliato dal colore verde pallido delle acque della Drina. Molte case nei villaggi che incontro sono vuote, anche se alcune sono molto belle. La povertà si vede ovunque. Nei giardini bruciati dal sole si affaccendano soprattutto gli anziani.
Case abbandonate
A Bratunac lascio la Drina e mi dirigo a sudovest verso Potočari e Srebrenica. Penso alle immagini ormai familiari delle esecuzioni di uomini e ragazzi avvenute nei prati vicini, che sconvolsero l’Europa nell’estate del 1995. Srebrenica oggi è una città fantasma. Diverse migliaia di persone vivono ancora nella valle angusta e claustrofobica. A ogni angolo si avverte un’assenza. Molte case sono abbandonate. Sui pendii delle colline spiccano i cimiteri musulmani. Quando entro in un negozio percepisco un’atmosfera di diffidenza. Diverse paia di occhi mi scrutano dai balconi. Solo i gatti, onnipresenti, sembrano indifferenti a tutto e a tutti.
Potočari, pochi chilometri più in basso, ospita il più grande cimitero delle vittime del 1995 e anche un museo-memoriale. I preparativi per il trentesimo anniversario del massacro sono quasi ultimati, le famiglie dei morti stanno arrivando. Nel parcheggio ci sono alcuni autobus. Dalle auto che passano si sente musica ad alto volume. Un uomo, alla guida di una vecchia Volkswagen suona ostentatamente il clacson e grida qualcosa dal finestrino. Sorride beffardo, ma incerto. Nessuno gli fa caso.
I prati del monte Jahorina, che sovrasta Sarajevo, sono in piena fioritura. Un tripudio di colori e profumi. Più in basso la città che, dopo anni di ricostruzione, è tornata a essere il cuore politico, commerciale e culturale della Bosnia Erzegovina. La Baščaršija, un tempo il mercato principale, ora è il centro turistico della città. Le strade strette sono affollate di turisti provenienti da tutto il mondo. Adi, che gestisce una pensione e un ristorante, dice che Sarajevo oggi è la città più bella dei Balcani. E lui le ha viste tutte. Ha sessant’anni e ha trascorso qui tutta la vita. È impossibile non essere d’accordo. Sarajevo è una città bellissima sulle colline. In passato quella posizione si rivelò una trappola mortale, ma non oggi.
I prati del monte Jahorina, che sovrasta Sarajevo, sono in piena fioritura
Il venerdì sera, nella vicina via Zelenih Beretki (Berretti verdi), chiamata così negli anni novanta in onore della organizzazione paramilitare formata per difendere la città, la vita notturna è intensa. Parlo con dei giovani bosgnacchi (bosniaci musulmani). A cento metri da noi si trova l’hotel Europe, un tempo hotel Evropa. Gli chiedo quindi dell’Europa. In nessun altro luogo in Bosnia l’atmosfera è così filoccidentale. Quando sollevo la questione della Repubblica serba, alzano le spalle. Non vogliono parlarne. Hana e Isa dicono senza mezzi termini che qui siamo in Bosnia e che è meglio che nessuno provi a metterlo in discussione. Isa aggiunge ridendo che anche lui difenderebbe la sua città e il suo paese. Sarajevo è la Bosnia, la Bosnia è Sarajevo, afferma.
Intorno rimbomba la musica. Lungo il viale Maršala Tita (Maresciallo Tito) scorre un fiume di gente spensierata. Su un edificio è appeso uno striscione che annuncia i festeggiamenti per il centenario della nascita di Alija Izetbegović, ex-presidente e filosofo, uno degli architetti della Bosnia Erzegovina contemporanea.
Dalla capitale mi dirigo di nuovo verso la Drina. Un impiegato della stazione di servizio di Rogatica, sentendo che vengo dalla Polonia, annuncia con orgoglio: “My name is Dragomir, I’m from Republika srpska” (Mi chiamo Dragomir, sono della Repubblica serba). Alle porte della città alcuni motociclisti mi fanno cenno di rallentare perché più avanti c’è una pattuglia della polizia. Vado a cinquanta all’ora e non hanno motivo di fermarmi. Tuttavia la paletta si alza. I poliziotti guardano la targa. Un ventenne sorridente mi chiede:
– Sve ok (tutto bene)?
– Good luck (buona fortuna).
Non devo mostrare i documenti. Presto sono di nuovo sulla Drina. Nel suo corso superiore sembra ancora più affascinante che nei dintorni di Zvornik. Il ponte di Višegrad, reso famoso dal romanzo di Ivo Andrić, attira sempre turisti, anche se qui sono per la maggior parte serbi.
La cifra del massacro
Faccio inversione e risalgo il corso del fiume. Sono diretto a Goražde, città che negli anni novanta fece parlare di sé. Oggi è l’unica enclave bosgnacca della zona. In centro risuonano i clacson. Per la via principale sta sfilando un corteo di auto, in testa un taxi con le quattro frecce accese. Subito dietro un’auto bianca decorata con delle rose e la bandiera della Bosnia Erzegovina legata sul portapacchi. È una coppia di sposi.
In un ristorante parlo con una donna di settant’anni che lavora in cucina. A un certo punto traccia con il dito delle cifre sul bancone: 8.371. È il numero delle vittime del massacro di Srebrenica. In questa valle non c’è scampo dalla storia. La donna parla dei cecchini che uccidevano i civili, come a Sarajevo. Elenca i nomi delle località un tempo abitate da bosgnacchi.
A Goražde visito lo stadio cittadino, sul muro c’è scritto: “Don’t forget Srebrenica ’95 (non dimenticate Srebrenica ’95)”. Sul balcone di una casa vicina un bambino punta un fucile giocattolo contro i passanti. Quando incrociamo lo sguardo si intimidisce e sparisce dentro casa. La facciata del palazzo è piena di macchie bianche di malta che otturano i fori lasciati dai proiettili. La guerra è finita trent’anni anni fa, ma la zona di confine tra Bosnia e Serbia non si è ancora ripresa dal dolore e dalla sofferenza. Fortunatamente, non tutto qui si lascia sopraffare dal passato. Nella vicina Foča, nella Repubblica serba, da alcuni anni si può di nuovo ammirare la moschea Aladža. All’epoca fu rasa al suolo. Era considerata una delle più belle dei Balcani. Ora è avvolta dal profumo degli tigli.
Parto per Trebinje, che si trova all’estremità meridionale della Bosnia Erzegovina. Nella valle di Sutjeska, ai piedi della vetta del Maglić, sono in corso i festeggiamenti per l’anniversario di un’altra battaglia di una guerra ancora più lontana nel tempo. Lungo la strada che costeggia il fiume c’è un corteo, alcuni partecipanti indossano repliche di vecchie uniformi. Una folla si è radunata sotto il monumento che commemora lo scontro tra le potenze dell’Asse e i partigiani di Tito. Si sentono canti in lontananza. La maggior parte delle persone è arrivata dalla Serbia. Ricordano con commozione i tempi precedenti al 1989. Uno di loro, Milan, quando sente la parola “Polonia” ricorda Wojciech Jaruzelski, un grande leader, dice lui. Se fosse rimasto al potere dopo il 1989, continua, oggi la Polonia sarebbe un grande paese. E invece tutto è andato perduto. Come la Jugoslavia dopo la morte di Tito. Al momento dei saluti mi abbraccia.
Un venditore ambulante mi propone una bandierina commemorativa per quattro euro. Quando gli chiedo quanto costerebbe in marchi convertibili, la valuta della Bosnia, risponde 4 marchi (2 euro). Quindi la prendo per 2 euro, alla metà del prezzo iniziale.
Nei dintorni di Trebinje il paesaggio diventa mediterraneo. Le montagne aride e brulle da alcuni giorni sono colpite da incendi. Sui cartelli con i nomi delle località spesso c’è la lettera “Z” scarabocchiata in fretta insieme ad altre scritte che lodano la Russia e Putin. A Trebinje ho notato piccole effigi di Mladić fatte con un timbro. Ma questa è solo una delle verità su questa zona, rinomata per la sua ospitalità. Molti serbi lavorano nella croata Dubrovnik e il turismo, pilastro dell’economia locale, oggi unisce popoli che un tempo osservavano con circospezione le mosse reciproche.
All’ombra dei platani e dei tigli che adornano il vecchio borgo è in corso un festival folkloristico. Al mercatino compro una copia del romanzo Il ponte sulla Drina, pubblicato nel 1945. Racconta un’altra Bosnia, quella precedente al 1914, quando le comunità musulmana e serba vivevano in pace e il ponte le univa. Lo compro come souvenir e forse anche come talismano. ◆ sb
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1630 di Internazionale, a pagina 78. Compra questo numero | Abbonati