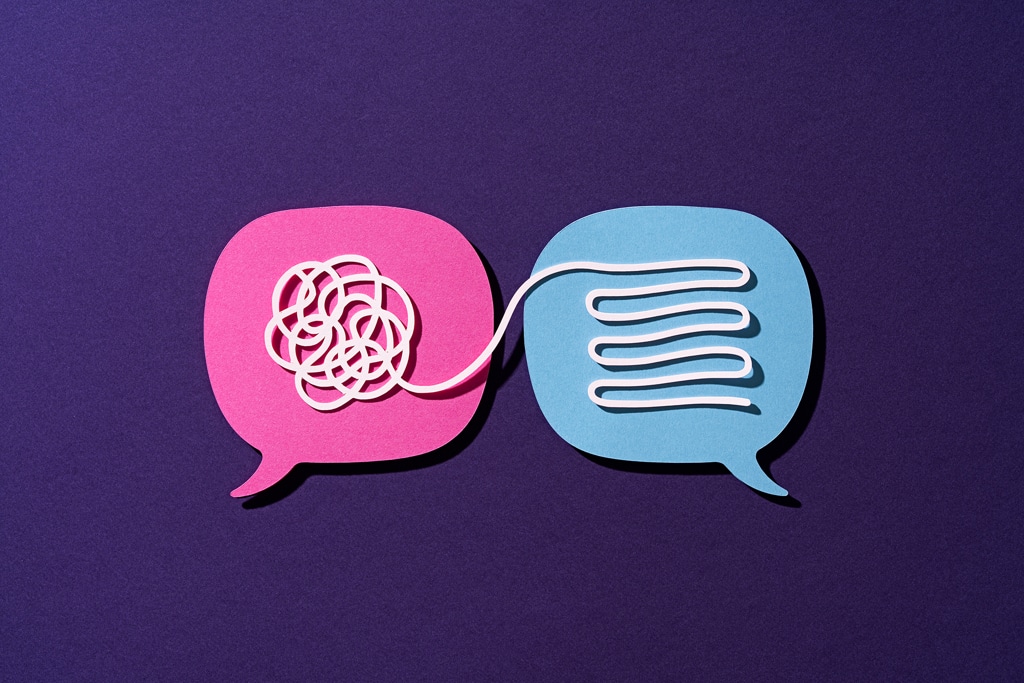C’era una volta il “popolo sacro”, a cui appartenevano il Primo uomo e la Prima donna. Nati dalle nuvole, non solo hanno dato forma alla Terra, ma hanno creato anche il Sole, la Luna e le stelle, per poi ascendere a loro volta in cielo. Ogni notte tra le stelle è possibile scorgere le loro sagome che ruotano intorno a un Focolare, con al centro l’Innesco.
Il racconto fa parte della cosmogonia del popolo navajo del Nordamerica, com’è stata descritta dal poeta e studioso austriaco Raoul Schrott. Questa versione molto stringata contiene un elemento essenziale: possiamo ancora veder ruotare le stelle nel cielo, perlomeno nell’emisfero nord del pianeta. Quella che i navajo chiamano la Prima donna è la costellazione di Cassiopea, mentre il Focolare è la stella polare. La gamba e il perizoma del Primo uomo, invece, corrispondono al Grande carro degli europei. In realtà, la gamba è un po’ storta, ma la leggenda navajo ha una spiegazione: è colpa di una violenza domestica. Nel popolo sacro non regnava sempre l’armonia, così una volta la Prima donna si arrabbiò con il suo uomo e, senza pensarci troppo, gli spezzò il femore.
Le stelle raccontano storie a chi le osserva e le leggende che hanno ispirato sono numerose. Tutte le costellazioni – da Orione all’Orsa maggiore, passando per i dodici segni dello zodiaco – sono frutto dell’invenzione di persone che, a seconda delle epoche e delle latitudini, hanno collegato le stelle in modo da formare figure diverse. Per sei anni Schrott ha studiato com’era visto il cielo notturno da diciassette culture diverse – alcune scomparse da tempo – e le leggende al riguardo. Il risultato è il volume di 1.280 pagine chiamato Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit (Hanser 2024), l’atlante del cielo stellato e dei miti sulla creazione dell’umanità.
L’atlante di Schrott si allontana dalla prospettiva moderna ed eurocentrica, e cita solo di sfuggita le costellazioni ufficiali di oggi, che spesso riprendono antichi modelli greci o babilonesi e sono già abbondantemente documentate. L’autore insiste su una caratteristica delle costellazioni del passato: avevano un’utilità pratica, perché servivano a ricordare le storie sulle origini del mondo e su cosa era giusto o sbagliato.
Enciclopedia per immagini
“La volta celeste è una specie di enciclopedia per immagini delle culture umane”, spiega Schrott. Ora che le costellazioni sono riconosciute a livello internazionale, questa dimensione si è persa: “Non abbiamo più un dio da scorgere tra le stelle”. Inoltre le costellazioni ufficiali non hanno più una rilevanza per la vita quotidiana delle persone.
Schrott è stato sorpreso dalle differenze e, allo stesso tempo, dalle somiglianze tra i cieli stellati delle diverse società: “Ogni cultura ha disegnato un suo cielo, ma alcune caratteristiche sono comuni”. Spiegare le differenze è facile: innanzitutto, a seconda della posizione in cui ci troviamo sulla Terra vediamo porzioni diverse del cielo, individuando le stesse stelle ora più in alto, ora più in basso, o forse non trovandole affatto. Inoltre a causa della precessione degli equinozi, cioè il movimento della Terra che fa cambiare lentamente l’orientamento del suo asse di rotazione, la porzione visibile del cielo varia con il passare del tempo.
Infine entra in gioco la pareidolia, cioè la tendenza degli umani a trovare forme note in immagini casuali, come per esempio quando le nuvole ci sembrano pecore o quando riconosciamo nei profili delle colline e delle montagne le sagome di persone sdraiate.
Guardando le stelle dev’essere successo qualcosa di simile: le persone hanno visto cose e animali che gli erano familiari. Poiché la fauna varia a seconda delle regioni del pianeta, chi osservava il cielo notturno ha collegato le stelle disegnando cammelli, renne, squali o tartarughe.Tra le costellazioni più note c’è il Grande carro, formato da sette stelle che anche a livello internazionale vengono spesso percepite come un’unica figura. Solo che in genere non è un carro. In Nordamerica, per esempio, è il Big dipper, il grande mestolo, mentre i britannici ci vedono un aratro.
Sottosopra
Ufficialmente quelle stelle fanno parte del fondoschiena dell’Orsa maggiore, che ha una coda lunga, decisamente atipica per un’orsa. Quegli stessi puntini si potrebbero collegare in vari modi, ottenendo animali di ogni tipo, dal gatto al topolino. A dare il nome all’Orsa maggiore furono gli antichi greci, che scelsero di identificarla con l’orsa, un animale che vive a nord, visto che si osserva soprattutto nell’emisfero boreale.
L’idea del carro, invece, risale ai babilonesi: lo chiamavano Mar.Gid.Da, che si può tradurre con “carro”. Solo che il carro babilonese era più grande di quelli che conosciamo oggi ed era orientato in un’altra direzione, con il timone in basso.
Nelle stelle che secondo i greci formavano le zampe dell’orsa, i babilonesi avevano visto le figure di due importanti divinità: Ninlil, la madre degli dei, e davanti a lei il marito Enlil, dio dell’agricoltura. Sul timone c’era una volpe che, come spiega Schrott, accorreva in aiuto dei malati e dei moribondi.
Per i navajo, invece, le sette stelle formano la gamba di un guerriero maschio, il Primo uomo o Uomo rotante. Per via della rotazione terrestre, il Primo uomo e la Prima donna girano intorno alla stella polare: nelle sere d’estate l’uomo è a testa in giù, in quelle d’inverno è in piedi. Ai nativi del Canada e della Groenlandia quelle sette stelle, invece, ricordano una renna: il timone era la sua schiena, mentre il quadrato di stelle formava la testa e le corna.
A seconda delle regioni ci sono delle piccole differenze, precisa Schrott: alcuni ci vedevano un solo caribù, altri più d’uno. I caribù sono animali da lavoro molto importanti per gli inuit e la costellazione che gli hanno dedicato è speciale. Generalmente gli inuit identificavano persone e animali con singole stelle, ed è un caso unico che alla renna sia stata attribuita un’intera costellazione.
Anche le popolazioni tuareg del Sahara e del Sahel videro in quelle stelle un animale per loro molto importante: una cammella che si allunga verso un albero di acacia spinosa mentre, come vuole la leggenda, un fabbro intenzionato a ucciderla le si aggrappa al collo. La scena è completata da altre stelle, quelle del Piccolo carro e la stella polare, rispettivamente un piccolo di cammello e una schiava che lo tiene al guinzaglio per impedirgli di correre dalla madre.
L’eroe irascibile
In Perù le sette stelle del Grande carro sono visibili solo nei mesi invernali, in cui ci sono frequenti temporali: probabilmente è per questo che i suoi abitanti, in epoca precolombiana, ci riconoscevano il dio del tuono, che portava un nome diverso a seconda della regione. Nella mano alzata impugna uno scettro capace di scatenare la tempesta, nell’altra tiene una fionda. Era un dio creatore e vendicativo, e andava placato anche con sacrifici umani.
Nella tradizione della penisola arabica, il Grande carro è un Catafalco, il sostegno di una bara. Accompagnato da persone in lutto o parenti, a seconda della leggenda, il defunto procede eternamente nel corteo funebre senza mai ricevere sepoltura, una storia che secondo Schrott riprenderebbe un antico culto idolatrico per cui la rotazione eterna sarebbe la punizione per chi si ribella a dio.
La più antica documentazione delle costellazioni risale alla Mesopotamia ed è arrivata a noi per un fortunato incidente
In Sudan Schrott ha sentito una storia diversa: la sagoma disegnata da quelle stelle non è un catafalco ma l’alcova del sultano, mentre le tre stelle del timone sarebbero tre vergini.
Un’altra costellazione molto nota è Orione. Rappresenta un cacciatore dalle spalle larghe, con in mano un’arma e nell’altra una pelliccia o uno scudo, a seconda delle rappresentazioni. Le stelle che formano la sua testa sono moderatamente luminose. Secondo una tradizione greco-romana, Orione era così arrogante da vantarsi di poter affrontare qualsiasi animale e allora Gaia, dea della Terra, mandò un enorme scorpione a ucciderlo. Trasformati in costellazioni, Orione e lo Scorpione si trovano su lati opposti del firmamento e non si vedono mai insieme: Orione è visibile d’inverno, lo Scorpione in primavera.
Anche i tuareg hanno una storia simile. In quelle stelle, racconta Schrott, riconobbero la sagoma di Amanar, un eroe leggendario noto per la sua irascibilità. Anche se non conosciamo precisamente le sue gesta, sappiamo che la costellazione di Amanar guidava le azalai, le carovane del sale che attraversavano il deserto dirette a est. Nelle varie regioni, al condottiero del cielo si attribuiscono leggende diverse: una lo vuole esiliato in cielo per aver picchiato la madre, la Terra. Per punizione sarebbe eternamente torturato con il fuoco e il ghiaccio, probabilmente perché la stella Rigel, il piede dell’eroe, brilla di un freddo colore bluastro, mentre Betelgeuse, uno dei punti che formano le spalle, tende al rosso.
Secondo un’altra interpretazione, diffusa nel sud dell’Algeria, in quelle stelle non si vede Amanar, ma un uomo che d’estate – quando la costellazione si presenta perpendicolare rispetto al Sahara e i datteri sono maturi – è vivo, mentre d’inverno – quando la costellazione si presenta orizzontale e i datteri non sono pronti – è morto disteso a terra, nudo.
La costellazione di Orione è visibile anche dall’emisfero australe, ma capovolta. I maori della Nuova Zelanda non ci hanno visto una figura umana, ma la poppa della grande nave dei morti. Quella che per altri popoli è la cintura di Orione, per loro è il ponte dell’imbarcazione. Sopra, in compagnia del suo cane, c’è il dio Taramainuku, impegnato a pescare le anime dei morti per condurli negli inferi e poi gettarli nel cielo, dove continueranno a vivere sotto forma di stelle.
Nel cielo stellato l’umanità ha individuato figure che non si ottengono solo unendo tra loro le stelle, ma anche considerando le zone d’ombra interne alla Via lattea. A dire il vero, la Via lattea è ovunque, perché ne fanno parte tutte le stelle visibili a occhio nudo dalla Terra. Solo che la maggior parte degli astri si colloca lungo un piano che, visto dalla Terra – soprattutto dall’emisfero australe – ha l’aspetto di una scia luminosa che gli esseri umani, molto prima di inventare i telescopi, hanno immaginato come un fiume, un sentiero, una divinità che avvolge la Terra o anche come del latte schizzato dal seno della dea Era.
Sette sorelle
Per gli aborigeni australiani wardaman è un uccello gigante. Secondo Schrott a ispirarli fu il genyornis, l’uccello del tuono, estinto già nel Pleistocene, anche se oggi è riconoscibile nell’emù. A maggio, dopo la stagione delle piogge, la sua ombra è la prima che torna a stagliarsi nella Via lattea. Il posteriore dell’uccello è vicino alla stella Antares, appartenente alla costellazione dello Scorpione, mentre il becco è nella Croce del sud, costellazione che può rappresentare anche l’impronta degli artigli dell’uccello. In quella stessa parte della Via lattea gli abitanti di altre zone dell’Australia hanno visto un canguro, una tartaruga lungocollo o, quando la scia luminosa è più appiattita sulla volta celeste, un gruppo di coccodrilli.
Circa seimila chilometri a est dell’Australia, nelle Isole della Società della Polinesia francese, a quella scia luminosa sono state associate invece le sagome di due pesci balestra. In questo caso la Via lattea era considerata un corso d’acqua nel quale si dissetavano gli dei. In quell’acqua due pesci mordicchiavano i nugoli di stelle, creando le nuvole che portano la pioggia.
Per quanto diverse siano le costellazioni e le relative leggende, Schrott fa notare che hanno tutte una base comune: alle stelle sono collegati i miti sulla creazione del mondo, che tra l’altro presentano elementi ricorrenti, come il diluvio universale, gli ibridi umani-animali e le stelle come esseri umani ascesi in cielo. Può succedere perfino che in regioni molto distanti si raccontino leggende quasi identiche: gli aborigeni australiani e gli antichi greci, per esempio, ritenevano che le Pleiadi fossero sette sorelle inseguite da un cacciatore. Senza contare il fatto che quasi tutti in questo gruppo di stelle ne contano sette, anche se a occhio nudo se ne vedono solo sei.
Come spiegare queste somiglianze? Potrebbero essere semplici coincidenze o dipendere dal modo in cui le storie furono tramandate. A raccogliere miti e leggende furono spesso gli etnografi occidentali, per cui ci si può chiedere se le versioni che sono arrivate fino a noi non siano state influenzate dai loro preconcetti, tanto da discostarsi dagli originali.
Tuttavia Schrott ha un’altra teoria. Secondo lui le costellazioni potrebbero essere state inventate molto prima di quanto pensiamo e avere un’origine comune: “L’ipotesi è che già prima di lasciare l’Africa, circa settantamila anni fa, i vari gruppi di Homo sapiens avessero riconosciuto delle costellazioni comuni”. Quando si sparsero per il mondo adattarono quei racconti all’ambiente dove si ritrovarono a vivere. Pur non essendone convinto fino in fondo, Schrott nota che non ci sono spiegazioni altrettanto convincenti. Cita anche la ricerca di alcuni astrofisici australiani secondo cui, circa centomila anni fa, dalla Terra era ancora possibile distinguere sette stelle tra le Pleiadi. Quella dell’origine comune delle costellazioni è un’ipotesi ardita ma difficile da confutare, perché non sappiamo con certezza da quanto tempo l’umanità le conosca.
Una tavoletta da Ninive
Una cosa, però, è certa, spiega Susanne M. Hoffmann, astronoma ed esperta di storia culturale dell’osservazione delle stelle: la più antica documentazione delle costellazioni risale alla Mesopotamia del settimo secolo aC ed è arrivata a noi per un fortunato incidente. Gli assiri scrivevano su tavolette di argilla morbida, che erano riutilizzate più volte. Quando i babilonesi e i medi conquistarono la città assira di Ninive e ne incendiarono la biblioteca, il fuoco indurì le tavolette che vi erano conservate, contribuendo a preservarle. In questo modo si è conservata una testimonianza delle conoscenze di quell’epoca.
Tra gli scritti di Ninive c’è il cosiddetto Mul.Apin (stella dell’aratro), il più antico trattato sulle stelle. Alcune parti risalgono probabilmente al quindicesimo secolo aC, ma neanche questa data, chiarisce Hoffmann, può essere considerata l’inizio in senso assoluto: “Sappiamo che già verso il duemila aC egiziani e babilonesi avevano le loro costellazioni, anche se non ne conosciamo la collocazione nella volta celeste”. Dall’antico Egitto, per esempio, ci sono stati tramandati dei notturlabi, cioè degli strumenti usati per determinare l’ora notturna con l’aiuto della posizione delle stelle.
Sembra che il Mul.Apin avesse vari scopi: grazie alle stelle si stabiliva il calendario, si prevedevano le stagioni e s’identificavano i momenti della semina e del raccolto, spiega Hoffmann. Inoltre, le costellazioni servivano ai viaggiatori per orientarsi. Il trattato si conclude con una spiegazione su come predire il futuro osservando le stelle. Insomma, osserva l’astronoma, si può ipotizzare che il suo obiettivo finale fosse quello di prevedere il corso delle cose.
Molte costellazioni oggi universalmente riconosciute sono state elaborate nel corso di millenni, a partire da quelle babilonesi. Ma quel popolo probabilmente non le riconoscerebbe più. Le stelle infatti si sono spostate, finendo per formare figure diverse. Anche se le stelle si muovono – le sette del Grande carro, per esempio, si sono allontanate le une dalle altre – dalla Terra il loro movimento appare quasi impercettibile. Per poter osservare i cambiamenti bisognerebbe armarsi di una pazienza sovrumana: “Tra un milione di anni effettivamente il Grande carro non sarà più riconoscibile”, chiarisce Hoffmann. “Nel corso della storia degli esseri umani le stelle si sono avvicinate tra di loro solo di pochi secondi d’arco”.
Invece dai tempi antichi sono cambiate significativamente le costellazioni, cioè i modi in cui le varie culture collegano le stelle tra loro. Nell’antica Babilonia molte figure avevano significati religiosi, ma nel lungo percorso verso il presente queste configurazioni sono passate per l’antica Grecia e l’antica Roma.
Queste civiltà le hanno cambiate modificando quello che non capivano. Nei Pesci, per esempio, i babilonesi vedevano una coda di rondine, probabilmente perché si poteva vedere in autunno, nel periodo in cui questi uccelli migrano a sud. A un certo punto quella coda si è trasformata in due pesci legati da un nastro.
Poi c’è l’Acquario. “I babilonesi ci vedevano Enki, il dio della conoscenza e della magia”, racconta Hoffmann. Nell’iconografia più diffusa Enki “era rappresentato con due fiumi d’acqua che gli uscivano dalle spalle. Per i babilonesi gli attributi di una divinità si applicavano spesso sulla zona delle spalle, proprio come le mostrine dei militari. Ma per i greci non aveva senso”. La divinità greca della saggezza, la dea Atena, non aveva nulla a che fare con l’acqua, e tantomeno le usciva dalle spalle.
L’Acquario ha perso il suo significato religioso e nell’immaginario occidentale è diventato una brocca. Inoltre i babilonesi raffiguravano Enki in compagnia di una creatura benevola, metà pesce e metà capra. Nello zodiaco, ancora oggi, questa creatura precede l’Acquario e continua ad avere la coda del pesce: è il Capricorno.
Nomi universali
Secondo Hoffmann le costellazioni potrebbero ancora avere una rilevanza pratica, perché si possono usare per prevedere le stagioni e, sul medio termine, le condizioni meteorologiche. L’astronomia, però, le usa “principalmente per la nomenclatura”, spiega la studiosa, che all’Unione astronomica internazionale (Uai) dirige il gruppo di lavoro incaricato di dare i nomi alle stelle.
Secondo uno schema tradizionale, alle stelle si attribuisce una lettera dell’alfabeto greco sulla base del livello di luminosità percepito dalla Terra, dopodiché si prende come punto di riferimento la costellazione: ufficialmente la stella Betelgeuse è Alfa orionis, Aldebaran è Alfa tauri e Mizar è Zeta ursae majoris. Questo metodo ha portato ordine in un cielo notturno che prima era piuttosto caotico.
Negli anni venti del secolo scorso l’Uai ha codificato le costellazioni ufficiali, valide in tutto il mondo. In gran parte sono quelle greco-babilonesi, integrate nell’emisfero australe dalle costellazioni definite nel settecento dall’astronomo francese Nicolas-Louis de Lacaille, tra cui figurano per esempio il Bulino, la Macchina pneumatica e la Fornace. Su queste non ci sono miti e leggende da raccontare.
L’Uai, prosegue Hoffmann, ha escluso dall’elenco ufficiale le costellazioni con denominazioni stabilite da singoli paesi, che non si possono imporre a livello internazionale. Un tempo i prussiani avevano la Gloria di Federico, una spada con una corona di alloro, collocata tra Andromeda, Cassiopea e la Lucertola. Le stelle che la compongono brillano ancora, ma il nome è stato ormai dimenticato. ◆ sk
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1625 di Internazionale, a pagina 56. Compra questo numero | Abbonati