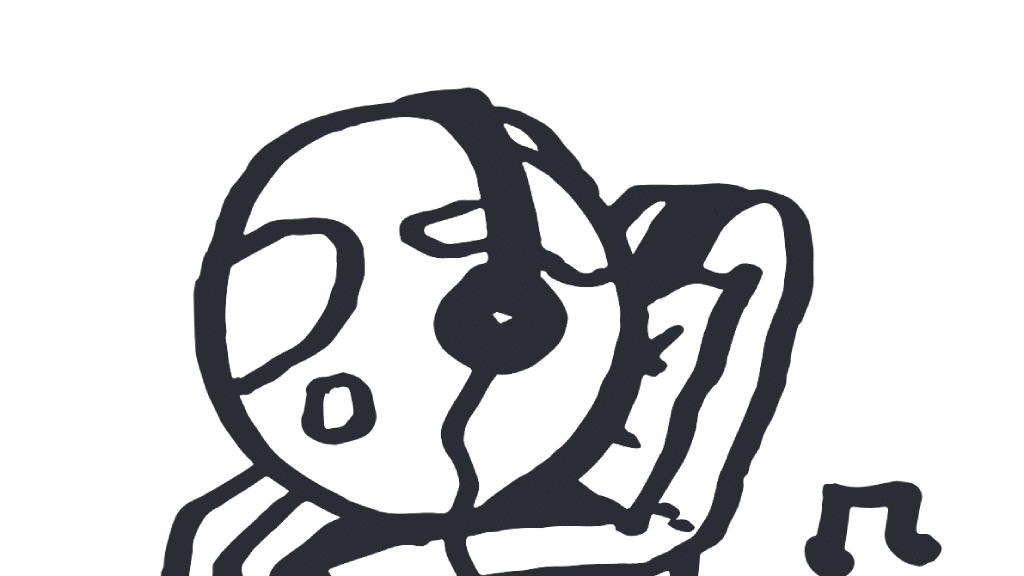Le voci della Striscia
di Gaza
◆ “Non sarò la vostra storia di successo, sarò il vostro specchio”, scrive una scrittrice palestinese in fuga da Gaza (Internazionale 1629). Nour Elassy mi hai spaccato il cuore, non riesco a smettere di pensare al tuo viaggio, al tuo senso di colpa, alla tua rabbia e al tuo coraggio. “Non dimenticatevi di me, Sara Awad, una studente palestinese”, scrive un’altra. Non lo farò, impossibile dopo le tue parole. Nel giorno in cui la Global sumud flottila sta partendo io vi leggo e sento disperazione e impotenza. Mi vergogno, non so cosa posso fare. Parlerò di voi alle mie figlie, leggerò le vostre parole. Racconterò la storia della vostra terra amata e derubata. Spiegherò loro che c’è un genocidio in atto che non viene riconosciuto, anche se possiamo vedere e sentire la vostra disperazione, anche se ci sono giornalisti coraggiosi che fanno il loro lavoro fino a morire. Conserverò questo numero di Internazionale per non dimenticare, per far sapere che sapevamo tutto ma non li abbiamo fermati.
Federica
◆ Il pensiero “Come preparare le valigie per l’esilio?” racchiude tutta la raggelante tragedia che vivono le persone che riescono a fuggire da Gaza. Spero che gli insegnanti possano trovare il tempo di accantonare momentaneamente testi e programmi per condividere in aula l’articolo di Nour Elassy.
Andrea Gallina
Ostaggio
◆ Ho letto l’ultimo editoriale di Giovanni De Mauro sull’uso della parola antisemita (Internazionale 1629). Le prepotenze linguistiche minano alla radice qualsiasi possibilità di dialogo. Nel dialogo due o più persone si lasciano attraversare dalla parola riducendo le distanze che le separano. Ma quando le parole diventano strumenti, armi, le distanze rischiano di diventare irriducibili. Papa Francesco esortava, in questi tempi complessi, a disarmare le parole per recuperare una dimensione di confronto. Abbiamo la responsabilità di riappropriarci del loro significato e averne rispetto.
Francesca Santese
A che servonoi vertici tra i leaderin tempo di guerra
◆ Questo articolo (internazionale.it) dimostra come lo studio della storia sia importante perché ci fa capire come in passato le decisioni dei sovrani e dei leader mondiali potevano cambiare le società, mentre oggi le uniche motivazioni che spingono questi “incontri di pace” sono prettamente di facciata perché gli interessi personali sono più forti di quelli pubblici.
Davide Andrea Ieluzzi
Errori da segnalare?
correzioni@internazionale.it
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1630 di Internazionale, a pagina 16. Compra questo numero | Abbonati