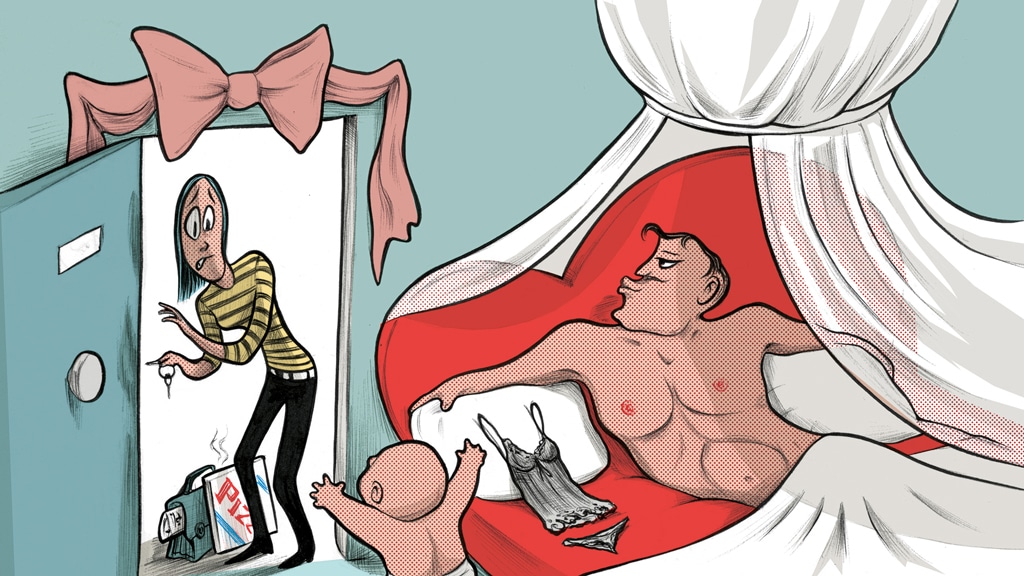È una domenica di fine luglio. Il giorno prima nell’arcipelago norvegese delle Svalbard è stata registrata la temperatura più alta di sempre: 21,7 gradi. Dopo essersi fatta strada tra le rocce, una massa d’acqua proveniente dal ghiacciaio Foxfonna si è riversata nella miniera 7. “È tutto allagato. Chi lavora qui da tanti anni non ricorda di aver mai visto tanta acqua”, dice Per Nilssen, direttore della miniera che fa capo all’azienda di stato Store Norske. “È colpa del caldo”. L’unica miniera norvegese di carbone ha dovuto chiudere perché è stata inondata a causa del disgelo del ghiacciaio sovrastante. Proprio per via di questa miniera, le emissioni di anidride carbonica pro capite delle Svalbard sono tra le più alte al mondo.
Non è l’unica cosa fuori posto in questo paradiso artico. Le Svalbard sono prese tra due fuochi: da un lato i cambiamenti climatici, dall’altro il turismo, che avrebbe dovuto diventare la principale fonte di reddito dell’arcipelago dopo l’abbandono del carbone, e che è stato duramente colpito dalla pandemia di covid-19. Nel frattempo il permafrost si scioglie, riaffiorano i resti di cacciatori di balene morti secoli fa e gli edifici cedono. Nel 2015 una massa di neve e detriti ha strappato undici case dalle fondamenta e le ha trascinate per un’ottantina di metri, sconvolgendo la vita di 25 persone e uccidendone due.
Recentemente è venuta alle Svalbard la ministra norvegese della giustizia e della protezione civile Monica Mæland, pochi giorni prima era toccato alla ministra dell’economia Iselin Nybø. Tutte queste visite a Longyearbyen, che conta poco più di duemila abitanti provenienti da una cinquantina di paesi, hanno un motivo. L’isola è in mani norvegesi da un secolo, ed è giunto il momento di adeguare alcune leggi, innanzitutto quelle sulla tutela dell’ambiente e sul turismo. La conversione dal carbone al turismo è stata tutt’altro che indolore e serve una svolta, che dovrebbe essere definita entro quest’inverno. Se si aggiunge la crisi dovuta alla pandemia, di certo i problemi non mancano.
Mæland ha visitato l’isola per la prima volta nel 1992. Raggiunse in motoslitta il ghiacciaio Von Post e pernottò in un rifugio di cacciatori. “Eravamo in mezzo al nulla, tutt’intorno solo ghiacci e foche. Una sensazione magica”, racconta. Stavolta invece la ministra deve correre da una riunione all’altra per farsi un quadro aggiornato della situazione sull’isola. “La società nelle Svalbard è fragile ed è stata colpita duramente dalla pandemia. La situazione è molto preoccupante”.
Nel 2015, lo stesso anno della valanga, si decise di puntare sul turismo. Il carbone avrebbe dovuto essere abbandonato e sostituito dai turisti. Turisti che con i loro lunghi viaggi in aereo o in nave contribuiscono al riscaldamento globale, e che mangiano cibi e comprano prodotti fatti arrivare da molto lontano. Tutto questo in una delle zone della Terra più esposte ai cambiamenti climatici. Le gigantesche navi da crociera bianche hanno cominciato ad assediare Longyearbyen, e gli abitanti non vedono altra via d’uscita che svignarsela per qualche ora. Alla scuola materna in centro è stato affisso un cartello che vieta di fare foto senza permesso. In inverno i turisti formano lunghe carovane di motoslitte che percorrono le vallate avanti e indietro, spesso dopo aver alzato il gomito. Gli operatori turistici stranieri sono accusati di fare concorrenza sleale e di violare le leggi sul lavoro.
“Le Svalbard stanno attraversando una trasformazione improvvisa”, afferma Line Nagell Ylvisåker, ex giornalista del quotidiano Svalbardposten e autrice del libro Verda mi smelter (Il mio mondo si scioglie). Abita a Longyearbyen da quindici anni e racconta che fino a una decina di anni fa l’arrivo del battello postale Nordstjernen era un evento, mentre ora le navi vanno e vengono di continuo. “La gente del posto se la dà a gambe quando arrivano. La vera questione è cosa prenderà il posto del carbone. Inizialmente si pensava al turismo, a cui è stato permesso di espandersi senza limiti. Ma anche quello non è molto ecologico”.
Deserto artico
“Ci stavamo trasformando in qualcosa di simile alla torre di Pisa”, dice Kjerstin Askholt, governatrice delle Svalbard. Askholt ci accoglie nel suo giardino a Skjæringa, dove all’inizio del novecento si insediarono i primi abitanti. Un po’ più a monte si trova la stazione della funivia, che veniva usata per trasportare il carbone. Un paio di anni fa, mentre stava pulendo i vetri, Askholt si è accorta che alcune parti dell’edificio avevano ceduto. “Mi sono rivolta all’ente statale che possiede l’immobile. Sono impalliditi. Per stabilizzare la struttura abbiamo dovuto piantare dei pali di ferro che affondano per 13 metri nel terreno”. Askholt governa un lembo di terra dove nessuno nasce né viene sepolto, e dove i cani da slitta faticano a trovare un albero per i propri bisogni, a meno che non si spingano fino a Endalen, l’unica area in cui cresce qualche betulla nana.
“C’è un motivo se la Norvegia è qui”, spiega Askholt. È scritto nero su bianco nel trattato delle Svalbard, firmato a Parigi nel 1920. “Alla Norvegia fu affidata la speciale responsabilità di tutelare e ‘per quanto possibile ripristinare’ la natura delle Svalbard. Venivamo da più di tre secoli di sfruttamento indiscriminato e l’arcipelago si era trasformato in una ‘terra di nessuno’. Nelle intenzioni delle parti, la storia non doveva ripetersi”. Per questo, in caso di conflitto con l’economia l’ambiente ha sempre la precedenza. Askholt aggiunge: “Lo sfruttamento del carbone dev’essere considerato in prospettiva storica ma dopo cento anni è sempre più illogico continuare a estrarlo nella regione che ha le norme ambientali più rigorose”.
Le Svalbard sono un deserto artico. In estate c’è talmente tanta polvere che bisogna togliersi le scarpe prima di entrare nelle case, negli alberghi e anche nell’ufficio del turismo. Un’eredità delle miniere.
“Secondo molti oggi abbiamo lo stesso clima della città norvegese di Tromsø, più piovoso e instabile, che provoca valanghe e smottamenti. L’inno delle Svalbard dice che Longyearbyen è protetta dalle montagne, ma all’improvviso il nostro mondo ha cominciato a franare. Ci troviamo di fronte a fenomeni nuovi, come l’erosione delle coste”, spiega Askholt.
A Longyearbyen gli insediamenti seguivano le miniere. La miniera aperta dagli statunitensi attirò gli abitanti verso il lato occidentale della valle. Poi ne fu aperta un’altra e la gente si insediò ancora più all’interno della valle. Poi si cominciò a costruire sull’altra riva del fiume, dove oggi abitano gli studenti. “In passato le case venivano costruite nelle aree geologicamente stabili. Negli anni settanta e ottanta, però, tutti volevano abitare sul lato soleggiato e avere una bella vista, così si cominciò a costruire sui fianchi della montagna, nell’area che poi ha ceduto”, spiega Askholt.
È stato deciso di demolire 140 alloggi nelle zone a rischio e di mettere in sicurezza il centro dell’abitato con muretti di contenimento e reti paramassi. Mentre i lavori procedevano, il flusso di turisti ha continuato ad aumentare. Negli ultimi cinque anni prima della pandemia il giro d’affari è raddoppiato fino a raggiungere un miliardo di corone all’anno (cento milioni di euro), ripartito su due stagioni, una che va da fine febbraio ad aprile e l’altra da giugno a settembre inoltrato.
Di recente lo Svalbardposten ha riferito che il ministero del lavoro sta preparando una nuova legge per contrastare i “rapporti di lavoro irregolari e i reati in materia di occupazione”. Alle Svalbard non si applicano le leggi norvegesi sulle ferie e sulla parità di salario per i dipendenti stranieri, né quelle sulle società per azioni, sul bilancio e sulla contabilità. “L’agenzia delle entrate sostiene che le aziende straniere non pagano tasse. Se poi il loro contributo al benessere locale è irrisorio, c’è da chiedersi che senso abbia creare le condizioni per il loro insediamento”, afferma Askholt.
Il coronavirus ha messo tutto in pausa e ha dato alla popolazione il tempo di riflettere. Askholt vorrebbe obbligare gli operatori turistici a impiegare guide autorizzate che garantiscano un’adeguata sicurezza per i visitatori, il rispetto delle norme ambientali e la prevenzione di danni ai siti d’interesse culturale. Alcuni turisti si avvicinano in motoslitta agli orsi polari, pensando che stiano solo oziando. “Un orso polare può rimanere immobile vicino a un buco nel ghiaccio anche per otto ore, in attesa di una foca. Se qualcuno lo disturba, tutta quest’attesa è vana”, commenta la governatrice. Negli ultimi cinque anni molti hotel sono stati ampliati e ora a Longyearbyen ci sono 951 posti letto. Ronny Strømnes, direttore di Visit Svalbard, racconta che la pandemia è arrivata nel momento peggiore. L’inverno era stato freddissimo, il ghiaccio era spesso e le condizioni per le escursioni in motoslitta erano ideali. Era tutto pronto, ma poi è arrivato lo stop. Ora gli alberghi sono vuoti e i cittadini extracomunitari, rimasti senza lavoro, non vedono altre prospettive che tornare nei loro paesi d’origine.
“L’ospedale delle Svalbard si trova a mille chilometri da Tromsø e ha un solo respiratore. Il trasferimento via mare richiede tre giorni, prendere un aereo con il covid-19 è rischioso”, spiega Strømnes.
Quando l’emergenza sarà finita la situazione potrebbe peggiorare ancora. Prima della pandemia durante i brevi mesi estivi arrivavano fino a 17 grandi navi da crociera, per un totale di 40mila passeggeri. A queste vanno aggiunte le crociere di spedizione provenienti da tutta Europa, che portano fino a cinquecento passeggeri ciascuna, per un totale di circa 22mila turisti all’anno.
“La maggior parte di questi turisti arriva con voli charter. Sono prelevati all’aeroporto e salgono direttamente sulla nave. Dopo sei giorni di navigazione, scendono a terra e vengono riaccompagnati all’aeroporto. Vogliamo fare in modo che i turisti si fermino in città”, dice Strømnes. “Su 150 tour organizzati nel 2018, solo 35 erano gestiti da noi. Vengono aziende da ogni luogo a mangiare nel nostro piatto”.
Chilometro zero
Alcune settimane prima dell’inondazione della miniera 7, percorriamo una polverosa strada sterrata in Adventdalen. A quindici chilometri da Longyearbyen si intravedono i contorni dell’unica miniera di carbone in Norvegia. Il direttore Per Nilssen tira fuori il pranzo al sacco mentre il caposquadra Bent Jakobsen, in tuta da lavoro, si siede di fronte a noi. Negli anni sessanta la Store Norske aveva quattrocento dipendenti, mentre oggi sono 150. “Longyearbyen non sarebbe esistita senza il carbone e la Store Norske. Fa male vedere come ci siamo ridotti”, dice Nilssen.
“La soluzione più ecologicamente sostenibile sarebbe fare i bagagli e lasciare le Svalbard, ma io sono un realista”
Il ministero dell’industria prevede di continuare a estrarre carbone dalla miniera 7 ancora per molti anni. Se il giacimento dovesse esaurirsi prima del 2038, ci sono 13-14 milioni di tonnellate di carbone nella miniera di Svea. Dall’altra parte della valle se ne potrebbero estrarre altri 7-8 milioni. Oggi il carbone non è più trasportato in funivia, ma con i camion fino a Longyearbyen e alla centrale elettrica. Mentre il 75 per cento del carbone estratto è destinato all’industria metallurgica e chimica in Europa, i conti della centrale delle Svalbard sono in rosso. “Entro il 2038 dovremmo dotarci di una nuova fonte energetica”, dice Nilssen, “ma nessuno ha stabilito quale potrebbe essere né quando sarà disponibile. Dunque non sappiamo quando potremo abbandonare il carbone. Inoltre la centrale sta diventando obsoleta, è molto costosa da gestire e può essere alimentata solo a carbone”.
Si parla di energia solare, ma è una soluzione buona d’estate e impraticabile nel resto dell’anno. Ci sarebbe l’energia eolica, ma che succede quando non soffia il vento? Inoltre, se le pale eoliche sono un pugno nell’occhio per i norvegesi della terraferma, è facile prevedere l’entità delle proteste se venissero installate in quest’isola così bella e unica. “Si potrebbe posare un cavo sottomarino dalla terraferma, ma è una soluzione costosa e complicata. Si pensa anche al gas naturale liquefatto e all’idrogeno”, afferma Nilssen.
“Sarebbe assurdo chiudere la miniera 7 e importare il carbone dalla Colombia”, sostiene Jakobsen.
“Ma anche questa alternativa è stata presa in considerazione”, risponde Nilssen. I due cominciano a parlare del fatto che dopotutto il carbone è una fonte di energia a chilometro zero, quindi avrebbe più senso concentrarsi sull’efficienza energetica.
“Se passassimo al solare o all’eolico tutte le case sarebbero riscaldate con l’energia elettrica. Gli abitanti di Longyearbyen non arriverebbero alla fine del mese, considerando i prezzi attuali dell’elettricità”, sostiene Jakobsen.
Ci addentriamo per nove chilometri nelle viscere della montagna, che poco tempo dopo saranno inondate a causa dell’ondata di calore. Quando usciamo dalla miniera, Nilssen mi spiega di aver fatto qualche conto: “Tra addetti alla produzione, tecnici alla centrale elettrica e indotto, parliamo di altre ottanta, novanta persone. Sono gli ultimi posti di lavoro nell’industria alle Svalbard. Tutti gli altri lavorano nel turismo e nei servizi. Non c’è niente di male, ma per avere una società stabile ci vuole qualche tipo di industria”.
Bisogni nella tundra
Espen Klungseth Rotevatn è arrivato qui nove anni fa, prima come vice organista della chiesa, poi come lavoratore estivo alla miniera Svea nel 2012 e 2013. Oggi dirige la scuola superiore per adulti e il coro. Oltre a essere il primo abitante dell’isola ad aver comprato una Tesla, è il portavoce dei Verdi (Mdg) alle Svalbard. Per ironia, il suo impegno politico è maturato in miniera. A quei tempi c’erano accese discussioni sull’opportunità che il Fondo statale per la gestione dei proventi del petrolio cedesse le proprie quote in attività legate al carbone. In un intervento sullo Svalbardposten, Klungseth Rotevatn affermò che il fondo avrebbe fatto meglio a indirizzare i ricchi finanziamenti riservati alle Svalbard verso attività più innovative ed ecologiche.
“Sono stato sommerso di critiche”, dice Klungseth Rotevatn ridendo. “Credo che la Store Norske possa sopravvivere anche senza carbone, ma deve convertirsi alla modernità”.
Alle elezioni locali del 2015 i Verdi hanno ottenuto il 12,9 per cento dei voti. Una vera valanga elettorale: in nessun altro comune norvegese hanno raggiunto numeri simili, sempre che le Svalbard possano essere considerate un comune. “La soluzione più ecologicamente sostenibile sarebbe fare i bagagli e lasciare le Svalbard, ma io sono un realista”, dice Klungseth Rotevatn.
◆ Le isole Svalbard si trovano a nord del circolo polare artico, a circa mille chilometri dal polo. Il primo insediamento risale all’inizio del seicento, ma per più di tre secoli sono rimaste terra di nessuno. Nel 1920 il trattato delle Svalbard, firmato a margine dei negoziati di pace alla fine della prima guerra mondiale, ha assegnato la sovranità alla Norvegia, ma ha stabilito che l’arcipelago debba restare un’area demilitarizzata e aperta alle attività economiche di tutti i 46 paesi firmatari. Inoltre il trattato prevede che i cittadini di qualsiasi paese possano stabilirsi e lavorare nelle isole senza bisogno di visto. Per questo motivo, a differenza del resto della Norvegia, le Svalbard non fanno parte dello spazio Schengen.
Secondo lui, non ha senso sostenere che sarebbe difficile far rispettare la sovranità norvegese senza una presenza diretta sull’isola. Piuttosto bisogna lavorare per rendere la società delle Svalbard più orientata al futuro. In quest’ottica, una delle prime cose da fare è tenere alla larga le grandi navi da crociera. “I turisti fanno i loro bisogni nella tundra, si avvicinano per chiedere se possono fotografare i tuoi figli. Non va bene. Un volo per arrivare qui costa pochissimo, mentre i posti letto e le attività sono molto cari. Dovrebbe essere il contrario”.
Dalla montagna, Klungseth Rotevatn guarda giù verso Longyearbyen, poi si volta e dice: “Da queste parti è quasi un tabù, ma spero che nel giro di cinque anni la miniera di carbone venga chiusa e si creino posti di lavoro in altri settori. Bisogna che il turismo sia regolamentato. Rischiamo di diventare una trappola per turisti, e ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi”.
Opportunità uniche
“Non è un caso se abbiamo deciso di stabilirci qui”, spiega Maja-Stina Ekstedt, direttrice della stazione Svalsat, che appartiene alla Kongsberg satellite services (Ksat). I satelliti in orbita polare passano sopra i poli mentre la Terra ruota sul suo asse, coprendo tutta la superficie del pianeta. Un satellite compie un giro completo in circa 90 minuti, e in 24 ore ne fa 14. “I satelliti sono impiegati nella ricerca ambientale, documentano i movimenti dei ghiacciai, monitorano la foresta pluviale, oltre a mandarci i dati climatici di tutto il mondo”, afferma Ekstedt.
Gli abitanti di Longyearbyen dicono per scherzo di essere tra i più sorvegliati al mondo. Alcuni si lamentano che la Via Lattea non è più la stessa con tutti quei satelliti che sfrecciano nella notte polare. Ma la raccolta dei dati satellitari muove grandi flussi di denaro e potrebbe rappresentare il vero futuro delle Svalbard.
“Cinque anni fa comunicavamo con cento satelliti. Oggi sono quattro volte di più, e continuano ad aumentare. Siamo leader nel mondo, ma per restare al passo dobbiamo costruire nuove antenne”, dice Ekstedt. Per questo motivo la Ksat ha chiesto l’autorizzazione a costruire venti antenne all’anno. È stata avviata una valutazione dell’impatto ambientale sulla biodiversità, sui siti d’interesse culturale e sul consumo di energia.
Secondo Ekstedt, per creare una società stabile alle Svalbard bisogna tenere conto delle peculiarità del luogo: “Perché non sfruttare la competenza già presente alle Svalbard per trovare soluzioni sostenibili? Non il turismo mordi e fuggi, ma alternative che valorizzino le opportunità che esistono solo qui”.◆ _ lv_
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1375 di Internazionale, a pagina 50. Compra questo numero | Abbonati