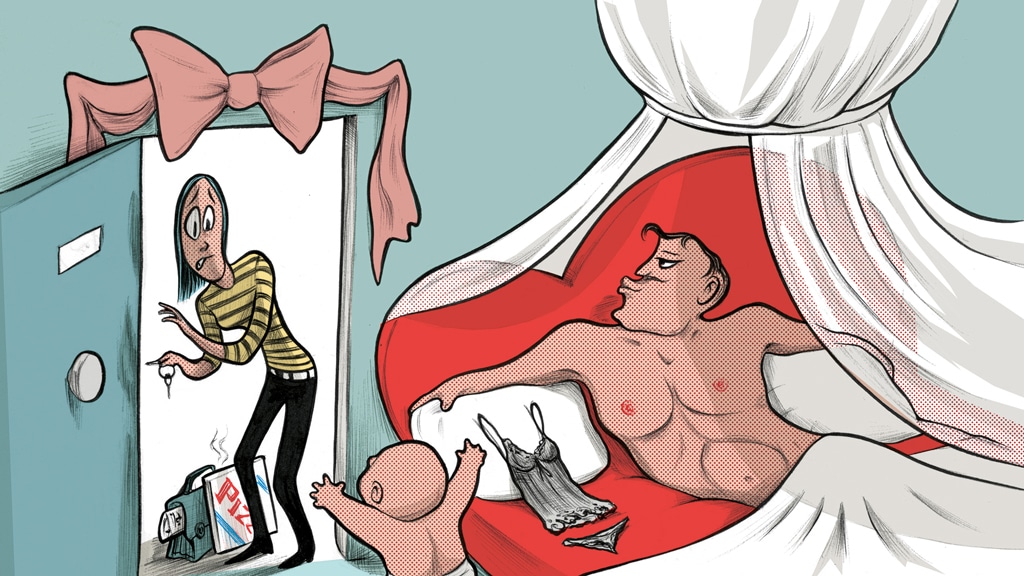In un silenzioso pomeriggio d’inverno, a Hamamatsu, una città costiera nel Giappone centrale, un ultraottantenne va a fare una passeggiata. Ha un’andatura strana, quasi meccanica, e il suo corpo sussulta a ogni piccolo passo. Le braccia rigide dondolano sui fianchi, non proprio in sincronia con le gambe. Un cappotto verde imbottito inghiotte la sua figura, e sotto un morbido cappello a falde marrone spunta un viso pienotto e rotondo.
Due donne gli camminano accanto mentre entra in biblioteca. Si ferma davanti a un distributore automatico che sembra parlare una lingua udibile solo a lui. Succo, bibite, caffè, zuppa di mais, tè: preme molti pulsanti in rapida successione. Impacciato, cerca di inserire troppe banconote finché una delle donne lo aiuta dolcemente. Due lattine di caffè zuccherato cadono nel vassoio.
Comincia a vagare nei corridoi della biblioteca. Alla fine, le due donne lo guidano verso una panchina accanto alla finestra. Gli porgono un libro fotografico sui gatti. Lui lo sfoglia lentamente: un micetto arrotolato in una ciotola, un altro che si crogiola al sole. Non sorride ma appare totalmente assorto e non dice quasi niente. Sembra uno spirito dimenticato in un guscio vuoto.
Nel 1966 Iwao Hakamada era stato arrestato con l’accusa di aver assassinato il suo capo, la moglie e i loro due figli adolescenti. Poi è stato condannato e ha trascorso gran parte dei 58 anni seguenti nel braccio della morte, chiuso in isolamento in una cella non più grande di un posto auto. Ogni mattina si svegliava senza sapere se quel giorno sarebbe stato l’ultimo.
Nel settembre 2024 un tribunale ha assolto Hakamada, che ormai aveva 88 anni. Un tale ribaltamento della sentenza, dopo tanti anni trascorsi in prigione, sarebbe eccezionale in qualunque paese. Ma in Giappone il tasso di condanne supera il 99 per cento per i casi che arrivano a processo, e in certi anni ha raggiunto addirittura il 99,9 per cento. Per questo la vicenda di Hakamada è sbalorditiva.
Inoltre la corte ha accusato la polizia e la procura di aver fabbricato le prove che avevano portato alla sua condanna. Nel marzo 2025 gli è stato riconosciuto un risarcimento di 217 milioni di yen (1,3 milioni di euro): la somma più alta nella storia del paese per un caso penale. “Quando il giudice ha pronunciato le parole ‘non colpevole’, la sua voce mi è sembrata divina”, mi dice Hideko Hakamada, la sorella, di 92 anni. “Non sono una donna che piange facilmente, ma mi sono spuntate le lacrime”. Non sappiamo se Hakamada – che soffre di gravi sintomi della sindrome di prisonizzazione a causa dei lunghi anni trascorsi in isolamento – è consapevole dell’importanza della decisione del tribunale, per lui e per il sistema giudiziario giapponese.
L’avevo incontrato la prima volta alla fine del 2022. Avevo visto dei video di interviste in cui appariva fragile ma composto, come una persona con cui si potesse ancora parlare. Ma quando con un collega ero arrivata a casa sua, lui era rimasto tutto il tempo in un’altra stanza. Non aveva risposto al mio saluto; non riuscivo a capire se si fosse accorto della mia presenza. In quel momento avevo capito che quei video erano stati accuratamente montati per dargli una parvenza di lucidità che in realtà non esisteva. Avevo parlato invece con Hideko, che si prende cura di lui ed è stata a lungo al suo fianco. Intelligente e vivace, mi aveva raccontato mezzo secolo di ingiustizie con una sicurezza incrollabile. Senza il suo appoggio Hakamada sarebbe probabilmente marcito in quella cella minuscola. Con il tempo lei è diventata il fulcro di una rete di avvocati, attivisti e persone comuni che hanno contribuito a ottenere la sua assoluzione.
Oggi Hakamada sembra trovarsi più a suo agio con gli oggetti inanimati che con le persone; la sua stanza è piena di peluche. Nel febbraio scorso, quando sono tornata a trovarlo per accompagnarlo nella sua passeggiata, gli ho portato uno shiba inu (cane di razza giapponese) di peluche, su consiglio di una delle sue badanti. Quando gliel’ho nervosamente consegnato, lui mi ha detto con voce sommessa dōmo (grazie), l’ha osservato per un po’ e se l’è infilato in tasca. È stata l’unica interazione significativa che sono riuscita ad avere con lui. “Ha abbandonato la realtà molto tempo fa per rifugiarsi in un mondo immaginario”, mi ha detto Machiko Ino, una delle donne che lo accompagnano nelle sue uscite quotidiane. “Non potrebbe mai tornare alla realtà e fare i conti con quello che ha vissuto. Sarebbe troppo”.
Il delitto
Iwao Hakamada è nato nel 1936 a Hamamatsu, nota per le piantagioni di tè verde e la vista sul monte Fuji. Il più piccolo di sei fratelli, a detta di Hideko era “un ragazzo calmo e gentile”; i due da bambini erano molto legati. La sua famiglia non era benestante, e Hakamada aveva cominciato a lavorare subito dopo la scuola, intorno ai quindici anni. Qualche tempo dopo s’innamorò della boxe. Non è mai diventato famoso, ma ottenne un modesto successo e nel 1960 stabilì un record per il maggior numero di incontri disputati in un anno: 19. Questo primato, ancora imbattuto in Giappone, “oggi è assolutamente impensabile”, dice Shosei Nitta dell’Associazione giapponese di pugilato professionistico. “Quello che lo rendeva speciale è che spesso arrivava fino all’ultimo round, resisteva, incassava e si rialzava”. Ma il suo corpo aveva cominciato presto a cedere, e dopo qualche anno fu costretto ad abbandonare la carriera. Si trasferì da Hamamatsu a Shimizu, una piccola città portuale un paio d’ore più a est, dove cominciò a costruirsi una nuova vita. Prima trovò lavoro in un cabaret, poi per un breve periodo gestì un bar. Alla fine fu assunto in una fabbrica di miso, la Kogane, diretta da Fujio Hashimoto e dalla sua famiglia. Nelle prime ore del mattino del 30 giugno 1966 un incendio distrusse la casa degli Hashimoto, accanto alla fabbrica. Dopo essere riusciti a domare le fiamme, i vigili del fuoco trovarono i corpi di Hashimoto, della moglie e dei loro due figli adolescenti che erano stati uccisi con più di quaranta coltellate. Hakamada, all’epoca trentenne, viveva in un dormitorio dall’altra parte dei binari, non lontano da lì. Fu tra i primi ad accorrere per aiutare a spegnere le fiamme. Perciò fu una sorpresa quando, due mesi dopo, lo arrestarono con l’accusa di omicidio.
I brutali delitti avevano sconvolto la sonnolenta cittadina, e la polizia era sotto pressione per trovare in fretta un colpevole. Non esistevano prove materiali che collegassero Hakamada al crimine, ma il giovane non aveva un alibi solido. Era anche un bersaglio facile, uno straniero silenzioso senza parenti nella zona. E come ex pugile dal fisico robusto si pensava che potesse aver sopraffatto gli Hashimoto.
Hakamada si dichiarò innocente dal momento dell’arresto. Alcune persone gli credettero, tra cui Akiko Watanabe e suo marito (che suonavano nella band del cabaret dove aveva lavorato prima di entrare in fabbrica). Watanabe, che oggi ha novant’anni, lo ricorda come un uomo mite e gentile. Racconta che quando il suo bambino perse per strada un pezzo di stoffa a cui era affezionato, lei era pronta a lasciar perdere mentre Hakamada era tornato indietro a cercarlo. “Era il tipo di persona che faceva cose del genere”, mi ha detto. “Ha un cuore d’oro”.
La prova regina
La polizia si presentò a casa di Watanabe pochi giorni dopo gli omicidi. Lei ricorda che uno di loro, con la sigaretta in bocca, disse: “Dev’essere stato Hakamada, il pugile. Nessun altro avrebbe potuto commettere un crimine così spaventoso”. Gli agenti confiscarono dall’album di famiglia le foto in cui appariva l’uomo.
Dopo aver deciso che Hakamada era il loro uomo, i poliziotti cercarono di farlo confessare. Procedettero quindi a un interrogatorio implacabile che durò 23 giorni. Le domande si susseguivano spesso per dodici ore di fila; nel giorno più lungo addirittura per sedici. Gli agenti a volte si rifiutavano di dargli da bere e lo privavano del sonno. Lo costringevano a usare un gabinetto portatile nell’angolo della stanza degli interrogatori, davanti a tutti. Gli urlavano addosso, lo schernivano chiamandolo bokusaa kuzure, pugile fallito. Lo prendevano a pugni e calci, lo picchiavano con un bastone. In un’occasione Hakamada perse i sensi.
Alcune registrazioni audio di quegli interrogatori in seguito sono state rese pubbliche. All’inizio Hakamada si ribellava e diceva ai poliziotti: “Mi avete rovinato la vita. Non lo dimenticherò mai”. Ma dopo venti giorni di torture la sua volontà era fiaccata. E alla fine, il 6 settembre 1966, quasi delirante, confessò.
Il sistema giudiziario giapponese poggia in larga misura sulle confessioni. Gli esperti le definiscono “la prova regina”, perché costituiscono il fondamento di circa il 90 per cento delle condanne. Yoshiyuki Nishi, ex giudice e ora avvocato difensore, spiega in un libro pubblicato di recente, che l’ossessione del Giappone per le confessioni risale al periodo Edo, l’epoca tra il 1603 e il 1868, in cui il paese fu retto dagli shōgun (governanti militari) Tokugawa. Le confessioni allora erano considerate essenziali non solo per provare la colpevolezza, ma anche per mantenere la presa dello shogunato sul potere e preservare un’apparenza di ordine e controllo. Come in molte altre società della prima età moderna, spesso per estorcere ammissioni di colpa si ricorreva alla tortura.
Alla fine del diciottesimo secolo fu deposto l’ultimo shōgun e nacque uno stato più moderno. La famiglia imperiale, a lungo emarginata, tornò a occupare un ruolo centrale. Sotto l’imperatore Meiji, il Giappone adottò rapidamente alcune istituzioni occidentali come tribunali, parlamento e sistema nazionale dell’istruzione. Ma la tortura rimase. Gustave Boissonade, un giurista francese che era stato invitato in Giappone negli anni settanta dell’ottocento per contribuire alla modernizzazione del sistema giudiziario, rimase sconvolto visitando un tribunale e imbattendosi in un uomo che urlava perché aveva le gambe schiacciate da grosse pietre. Grazie alle esortazioni di Boissonade, in Giappone la tortura fu ufficialmente abolita nel 1879.
Kana Sasakura dirige l’Innocence project Japan – un’organizzazione che cerca di ribaltare le condanne ritenute ingiuste – e osserva che “la prassi di affidarsi alle confessioni di fatto non è cambiata rispetto al periodo prebellico”. Dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale, il Giappone fu occupato dagli Stati Uniti, che cercarono di costruire una democrazia non militarizzata. Ancora una volta, il sistema giudiziario fu riformato sul modello occidentale. Una disposizione della costituzione giapponese del dopoguerra recitava: “Nessuno può essere condannato o punito se l’unica prova a suo carico è la sua confessione”. Ma nella pratica gli inquirenti giapponesi hanno continuato a dipendere in larga misura dalle ammissioni di colpevolezza. In parte possono esserci motivi pratici: le intercettazioni e le operazioni sotto copertura, per esempio, sono rigidamente regolamentate, il che può rendere difficile costruire un caso basandosi solo su prove materiali. Ma anche la cultura ha il suo peso: nella società giapponese, la confessione è spesso vista come il primo passo per espiare una colpa.
Prima dell’incriminazione la polizia può trattenere un sospettato fino a 23 giorni, molto più a lungo di quanto sia consentito nella maggior parte dei paesi democratici (in molti stati europei il limite è fissato in un giorno o due). Allo scadere di questo termine, gli investigatori possono arrestare nuovamente la stessa persona con accuse diverse ogni volta che vogliono, una pratica che i critici chiamano “giustizia dell’ostaggio”.
Ufficialmente la detenzione per un periodo indefinito serve a impedire la distruzione delle prove o la fuga dei sospetti. Ma secondo giuristi ed ex detenuti è usata soprattutto per estorcere confessioni. Gli interrogatori prima del rinvio a giudizio si prestano agli abusi, anche perché gli avvocati difensori non possono essere presenti (a differenza, ancora una volta, di quanto avviene nella maggior parte dei paesi democratici).
Nel 2018 il clamoroso caso di Carlos Ghosn, presidente della casa automobilistica Nissan, portò il problema all’attenzione internazionale. Ghosn era stato arrestato con l’accusa – sempre respinta – di illeciti finanziari; dopo 108 giorni di detenzione era riuscito a fuggire fortunosamente in Libano (nascondendosi in una grande cassa per il trasporto di strumenti musicali) imbarcandosi su un aereo. Ma la maggior parte delle persone sottoposte a questa “giustizia dell’ostaggio” non finisce in prima pagina.
Nel dicembre 1966, quando cominciò il suo processo, Hakamada era già stato bollato come criminale. I giornali riproponevano il copione della polizia, quello di un pugile violento diventato assassino. Lo Yomiuri Shimbun, il principale quotidiano giapponese, ipotizzò che la carriera di pugile gli avesse danneggiato i centri del controllo emotivo; un professore lo definì “un classico caso di schizofrenia”. Un altro giornale citò uno psichiatra secondo cui Hakamada poteva soffrire di “una personalità estremamente anormale”. Nessuno di questi accademici aveva mai incontrato Hakamada. “Non erano solo la polizia e la procura, ma anche i mezzi d’informazione e l’opinione pubblica. Tutti furono complici nel creare un ‘mostro’ che in realtà non esisteva”, dice Takako Suzuki, una deputata che si batte per la riforma della giustizia penale.
Un anno dopo i delitti la polizia comunicò di aver scoperto cinque capi di abbigliamento macchiati di sangue in fondo a un serbatoio di miso nella fabbrica: una camicia bianca a maniche corte, un paio di pantaloni, delle mutande verdi, un paio di suteteko bianchi (calzoni tradizionali giapponesi che s’indossano tra i pantaloni e le mutande) e una maglia scura a maniche lunghe. Sembrava che esistesse finalmente una prova materiale a conferma della confessione di Hakamada. Ma qualcosa non tornava. Nella confessione estorta dalla polizia Hakamada aveva detto che la notte degli omicidi indossava il pigiama, non gli abiti da lavoro che la polizia sosteneva di aver trovato. Perché, si chiedevano la famiglia e gli avvocati di Hakamada, un assassino avrebbe dovuto nascondere i vestiti insanguinati in un serbatoio di miso invece di distruggerli semplicemente bruciandoli? E perché la polizia – che sicuramente aveva ispezionato la scena del crimine subito dopo l’incendio – aveva trovato quelle prove decisive solo un anno più tardi?
Nelle lettere alla famiglia dalla prigione Hakamada rimaneva combattivo: “Dio, non sono io l’assassino. Lo grido ogni giorno”, scrisse una volta. “Prego che queste parole cavalchino i venti di Shizuoka e raggiungano le orecchie della gente”. Ma nel 1968 fu ritenuto colpevole da una commissione di giudici e condannato a morte. Tra le lettere che Hideko mi ha mostrato quando sono andata a trovarla nel suo piccolo appartamento di Hamamatsu, una si distingueva tra tutte. Era stata scritta poco dopo la condanna a morte, con lettere artificiosamente squadrate e linee dritte. Hideko mi ha spiegato che il fratello aveva usato un righello: le mani gli tremavano così tanto che non riusciva quasi a tenere in mano la penna.
Ma Hakamada prendeva colpi su colpi. Entrambi i genitori morirono quello stesso anno, una notizia che la famiglia in un primo momento cercò di tenergli nascosta. Quando finalmente lo seppe, ne fu sconvolto. “Il corpo mi si paralizzò per lo shock. Pregai che fosse un errore. Da allora è stato l’odio a tenermi in vita. Oggi ho come la sensazione che sotto la pelle mi scorra solo sangue freddo”, scrisse in un’altra lettera. Nel 1980, quando la corte suprema confermò la condanna a morte, la salute mentale di Hakamada precipitò. Cominciò a parlare di “malvagie onde radio” che lo attaccavano e sosteneva di non essere più un uomo, ma dio stesso. Con il tempo smise di riconoscere le persone, compresa Hideko, e presto si rifiutò addirittura di incontrarla.
Nella maggior parte delle democrazie un tasso di condanne superiore al 99 per cento sarebbe considerato una prova che il sistema non funziona (nel Regno Unito è intorno all’80 per cento). Ma in Giappone è ritenuto un tasso del tutto ragionevole. In parte questo dipende dalla selettività nei rinvii a giudizio: i pubblici ministeri scelgono di non procedere nel 60-70 per cento dei casi che esaminano. Daniel Foote, uno studioso di diritto, ha scritto che il sistema giapponese applica un “paternalismo benevolo”, in cui i pubblici ministeri si comportano come guardiani della moralità muniti di uno straordinario potere discrezionale nel decidere chi dev’essere incriminato e chi merita clemenza. Sono indulgenti, paradossalmente, con chi mostra rimorso e riconosce le proprie responsabilità, ma punitivi con chi insiste nel proclamarsi innocente. Come mi ha detto la parlamentare Suzuki, “il Giappone è considerato uno dei paesi più sicuri al mondo, con quel tasso di condanne superiore al 99 per cento. Ma l’altra faccia della medaglia è che una volta preso di mira sei finito. In questo senso, il Giappone fa davvero paura”.
L’accento sulla riabilitazione e il reinserimento sociale – a molti detenuti vengono offerti programmi educativi e di formazione professionale – ha senz’altro i suoi meriti. Ma molti osservatori restano critici sul ruolo eccessivo dei pubblici ministeri. “Si credono delle divinità”, mi dice l’avvocata Kyoko Yoshida. In passato ha fatto la giudice, ma si è dimessa perché delusa dal sistema, che paragona a una cucina dove “i pubblici ministeri cucinano e i giudici si limitano a mangiare qualunque cosa venga loro servita senza fare domande”. La riforma della giustizia non è mai stata un tema di attualità in Giappone, dove i reati sono rari. Molti cittadini pensano che la loro sicurezza sia il frutto di un sistema penale efficiente, e di rado hanno motivo di chiedersi cosa significhi trovarsi dalla parte sbagliata della legge.
I mezzi d’informazione e i polizieschi televisivi, mettono raramente in discussione lo status quo: gli investigatori di regola sono rappresentati come diligenti e moralmente specchiati. Ma perfino la cultura pop qualche volta ha affrontato casi di errori giudiziari. Queste storie trasformano in intrattenimento l’impressionante tasso di condanne del Giappone concentrandosi sugli sforzi di eroi geniali e carismatici per combatterlo. In un videogioco molto popolare, Ace attorney, i giocatori assumono il ruolo di un avvocato della difesa che cerca di ottenere un verdetto di non colpevolezza per il suo cliente. E nella serie televisiva 99.9, un avvocato immaginario di nome Miyama si oppone costantemente ai suoi superiori – che vorrebbero vederlo impegnato in cause civili, più redditizie – e contro ogni previsione riesce a strappare sentenze di assoluzione. “Voglio solo conoscere i fatti”, dice Miyama con un sorriso malizioso. “Anche quando la colpevolezza sembra sicura al 99,9 per cento, la verità potrebbe nascondersi in quello 0,1 per cento che resta”.
Ma la verità è che per combattere le condanne ingiuste in Giappone non basta la tenacia di un singolo avvocato coraggioso. Come dimostra il caso Hakamada, per contestare una sentenza occorre una comunità di persone determinate e una campagna di pressione pubblica. Il sostegno dei familiari non è sempre scontato. In molti casi di condanne ingiuste, “perfino i parenti spesso li abbandonano”, mi ha detto Hideko. Dopo un matrimonio e un divorzio in giovane età, si è dedicata a salvare il fratello. Per quasi sessant’anni ha organizzato manifestazioni per far conoscere il suo caso incontrando avvocati e politici per spingerli a riesaminare le prove. Anche nel lungo periodo in cui il fratello si è rifiutato di vederla Hideko ha continuato ad andare al centro di detenzione. “Era il mio modo di dirgli: non ti dimentico”.
Le ho chiesto se prova rabbia per aver visto lo stato rubare la vita di suo fratello e mi ha risposto: “Non provo mai rabbia. Non ho tempo per essere arrabbiata”. La sua resilienza colpisce chiunque la incontri. “Ha praticamente vissuto all’inferno per mezzo secolo”, osserva la parlamentare Suzuki. “Ma Hideko non si lamenta mai, non punta il dito contro nessuno. Continua semplicemente a dire la verità, a credere nell’innocenza del fratello e a concentrarsi su quello che deve fare”.
Hideko ha collaborato intensamente con la squadra della difesa del fratello, formata da un piccolo gruppo di avvocati che lavorano pro bono. A guidarlo è Hideyo Ogawa, un settantenne che segue il caso fin dagli anni ottanta. È un uomo incantevole e bizzarro, con una passione per le camelie, in particolare per le yōshutsubaki, le varietà di origine straniera con fiori grandi che sono spesso ignorate dalla floricoltura tradizionale giapponese perché troppo vistose. Ogawa rappresenta un’associazione locale dedicata a questi fiori su cui ha perfino scritto un libro. Dice che queste camelie somigliano un po’ ai suoi clienti emarginati. Quando Ogawa aveva cominciato a sostenere che le prove contro Hakamada erano una montatura, gli altri avvocati della difesa si erano mostrati scettici. “Quasi tutti gli avvocati partono dal presupposto che le prove presentate dalla polizia siano autentiche”, mi spiega. “Se cominci a metterle in dubbio, i giudici ti prendono per pazzo”.
Secondo Ogawa l’assoluzione è stata frutto della collaborazione tra gli avvocati e i sostenitori di Hakamada, che nei primi decenni di detenzione erano per lo più “i soliti sospetti”: simpatizzanti di sinistra e sindacalisti che avevano partecipato ai movimenti studenteschi degli anni sessanta e settanta. Di solito gli studi legali si tengono a distanza dalle iniziative pubbliche. Ma “ogni volta che organizzavamo riunioni o analizzavamo le prove”, spiega Ogawa, “i sostenitori partecipavano e condividevano le loro idee, un impegno collettivo inedito per altre squadre di avvocati”.
Sulla scena del crimine
Uno dei collaboratori più importanti è stato Toshiki Yamazaki, un uomo di 71 anni dal fisico asciutto e con un’energia spavalda. Quando ci siamo incontrati, a febbraio, aveva un cappotto happi tradizionale sopra la camicia, un paio di occhiali tondi e un sorriso malizioso. Da studente universitario si era avvicinato alla politica perché interessato al problema dell’inquinamento industriale; più tardi si è impegnato in un altro caso di errore giudiziario avvenuto poco lontano da Shimizu. In seguito aveva programmato di tornare nella città di origine, sull’isola di Kyūshū, ma presto si è trovato coinvolto nel caso Hakamada. “E a quel punto ho finito per mettere radici qui”, dice.
Yamazaki mi ha portato sulla scena del crimine. “È esattamente come nel 1966”, dice indicando la casa degli Hashimoto in rovina, dietro una cortina di alberi incolti. La fabbrica è stata demolita, al suo posto c’è una fila di case. Ma i binari che separavano l’abitazione degli Hashimoto dalla fabbrica sono ancora lì, e ogni tanto il campanello del vicino passaggio a livello segnala l’arrivo di un treno. Abbiamo camminato lungo un sentiero stretto che conduceva al cancello posteriore di casa Hashimoto. Secondo la polizia Hakamada era passato di lì più volte la notte del crimine: una volta per fuggire dopo l’omicidio, poi per tornare con la benzina, e ancora una volta per scappare dopo aver appiccato l’incendio. Ma c’era un problema. Al loro arrivo gli investigatori trovarono ancora chiuso il catenaccio superiore del cancello. Sostennero che Hakamada era strisciato attraverso il minuscolo varco sotto l’entrata, anche se avrebbe potuto facilmente aprire il saliscendi. “È una storia ridicola”, ha commentato Yamazaki. Mette in dubbio anche la versione della polizia sui vestiti rinvenuti nel grande contenitore di miso. Durante il processo Hakamada aveva provato a indossare i pantaloni per tre volte, ma non era mai riuscito a farli salire oltre i fianchi (i procuratori sostennero che si erano ristretti nel miso e che Hakamada era ingrassato).
Guardando le fotografie in bianco e nero degli indumenti Yamazaki aveva pensato che qualcosa non tornava. Com’era possibile che la camicia bianca fosse ancora così chiara dopo essere rimasta a mollo per quattordici mesi nella pasta scura di soia fermentata? E come spiegare delle macchie di sangue così vivide, quasi fossero fresche?
La risposta, sospettavano in molti, era che la polizia aveva piazzato lì i vestiti macchiati di sangue poco prima del loro presunto ritrovamento. Nel 2000 Yamazaki decise di provarlo. Uccise un pollo, ne fece colare il sangue su uno straccio e pressò del miso sulla stoffa. Nel giro di pochi giorni la macchia si scurì e alla fine diventò nera. Il miso è acido, spiega, e il processo di fermentazione ossida sostanze come il sangue. “Sono diventato un esperto di miso”, dice ridendo. L’esperimento in seguito fu ripetuto dagli avvocati della difesa e da altri sostenitori, usando anche sangue umano. Insieme ai test del dna – condotti più volte dopo il 2000 – questi esperimenti con il miso sono diventati prove cruciali per la difesa, impegnata a chiedere un nuovo processo. Ma per decenni la petizione è stata respinta dai tribunali. “Sembrava una situazione disperata”, mi dice Yoshiyuki Todate, un avvocato entrato nella squadra della difesa in quel periodo. “Potevamo davvero tirarlo fuori da quella cella?”.
Ciononostante il sostegno pubblico a Hakamada cresceva. Gruppi come l’Associazione di pugilato hanno cominciato a usare la loro posizione per far conoscere la sua vicenda. Un sostenitore influente – e inaspettato – fu Norimichi Kumamoto, il giudice che aveva scritto la sentenza di morte di Hakamada. Nel 2007 espresse pubblicamente il suo rimorso, un gesto decisamente insolito, dal momento che i giudici non dovrebbero commentare le proprie sentenze. Anche se credeva nell’innocenza di Hakamada, durante le deliberazioni Kumamoto era stato messo in minoranza dagli altri due giudici. “Ho sofferto fin dalla pronuncia della sentenza”, ha detto. “Non volevo portarmi addosso questo peso per il resto della vita”. In seguito Kumamoto si convertì al cristianesimo, una scelta rara in Giappone, dove solo l’1 per cento della popolazione segue questa religione. Disse che sperava di ritrovare Hakamada – che si è convertito anche lui – nella vita dell’aldilà (Kumamoto è morto nel 2020).
La riforma della giustizia non è mai stata un tema di attualità in Giappone
La svolta
Finalmente nel 2014 il caso di Hakamada è finito davanti al giudice Hiroaki Murayama, secondo cui c’era motivo di ritenere che le prove fossero state fabbricate. Murayama ordinò un nuovo processo e il rilascio di Hakamada, affermando che “tenerlo ancora in detenzione sarebbe un’intollerabile violazione della giustizia”. Fu una notizia sconvolgente per l’opinione pubblica, e per Hakamada, che allora aveva 78 anni e fu ricoverato due mesi in ospedale per valutare gli effetti dell’isolamento prolungato. Anche dopo essersi trasferito da Hideko, è rimasto inquieto. Per qualche tempo ha rifiutato di uscire di casa, e passava le giornate camminando in tondo nella sua stanza: probabilmente ripeteva quello che aveva fatto per decenni nella sua minuscola cella.
Dopo l’assoluzione Hakamada e la sorella hanno cominciato a ricevere la solidarietà dei concittadini. Tra questi c’è Machiko Ino, una delle donne che accompagna Hakamada nelle sue passeggiate. È rimasta profondamente commossa dalle sue lettere dal carcere (pubblicate dai suoi sostenitori), e ci ha visto una straordinaria sensibilità letteraria, considerato il suo livello di istruzione. Osservandola mentre camminava accanto a lui, tenendogli la mano e parlando con dolcezza, ho avvertito da parte sua un affetto quasi materno.
Dopo la decisione del giudice Murayama di riaprire il caso Hakamada nel 2014 i pubblici ministeri hanno presentato ricorso e ci sono voluti quasi dieci anni perché cominciasse il nuovo processo, nell’ottobre del 2023. Quando finalmente l’hanno assolto, Hakamada è diventato il quinto condannato a morte, nel Giappone del dopoguerra, a essere scagionato dopo un nuovo processo. Tutte e cinque le condanne si erano basate su confessioni che gli imputati avevano poi ritrattato.
Le loro esperienze hanno evidenziato fino a che punto la legge giapponese sul nuovo processo – immutata da più di settant’anni – sia inadeguata a correggere gli errori giudiziari. Uno dei problemi più eclatanti è la condivisione delle prove, poiché inquirenti e pubblici ministeri possono decidere quali materiali consegnare o meno alla difesa. “Perfino nei processi ordinari, non solo nei nuovi processi, gli avvocati difensori spesso non sanno quali prove esistano”, dice Tadahiko Sakaguchi, avvocato della Federazione giapponese degli ordini forensi. “I pubblici ministeri non hanno l’obbligo di fornire un elenco di quelle a disposizione”. Nel caso di Hakamada avevano trattenuto le fotografie a colori, scattate nel 1967, dei vestiti “rinvenuti” nel contenitore di miso. Quelle immagini confermavano ciò che aveva insospettito persone come Yamazaki già nelle foto in bianco e nero: i vestiti erano decisamente troppo puliti e chiari per essere rimasti immersi nel miso per un anno. Le foto a colori sono state consegnate alla difesa solo nel 2010, in seguito alle pressioni del tribunale, che stava cominciando a considerare l’opportunità di un nuovo processo. Se fossero state consegnate prima la revisione del caso avrebbe potuto essere anticipata di decenni.
Anche se la sua odissea è finita, sembra incapace di tornare alla realtà
Una revisione necessaria
Il caso Hakamada ha spinto quasi quattrocento parlamentari di diversi schieramenti ad aderire a un gruppo che chiede di rivedere la legge giapponese sui nuovi processi. Resta da vedere se avranno successo: per decenni le proposte di riforma sono state instradate ai consigli consultivi del ministero della giustizia, che tendono a essere favorevoli ai pubblici ministeri e insabbiano i cambiamenti. Ma ora potrebbe esserci una svolta.
La vicenda di Hakamada ha ispirato anche altri a battersi contro condanne ingiuste. Nel marzo del 1986, a Fukui, fu assassinata una ragazza di 15 anni. Un anno dopo la polizia aveva arrestato il ventunenne Shoji Maekawa senza che nessuna prova fisica lo collegasse al delitto. Condannato come colpevole di omicidio ha trascorso sette anni in prigione. Poi ne ha passati più del doppio in tribunale, cercando di riabilitare il suo nome. I suoi avvocati hanno rintracciato più di 250 elementi di prova mai resi pubblici e che confermavano i loro sospetti: la polizia aveva stretto un accordo con un uomo legato alla criminalità organizzata che aveva accettato di testimoniare contro Maekawa se fossero state ritirate le accuse a suo carico per vicende di droga. La polizia aveva inoltre istruito altri testimoni perché si adeguassero a quella versione dei fatti.
Quando gli ho chiesto perché continuasse a lottare dopo aver già scontato la pena, Maekawa, che oggi ha 59 anni, ha esitato. “Ci sono stati momenti in cui ho pensato di lasciar perdere. Ma voglio che sia fatta giustizia”, dice. Secondo lui il sistema giudiziario giapponese risente non solo degli abusi della pubblica accusa, ma di qualcosa di più profondo: un’avversione culturale ad ammettere i propri errori. “Penso che i giapponesi cerchino troppo la perfezione. C’è una sorta di arroganza”, spiega, “l’idea che noi non sbagliamo”.
Maekawa e i suoi legali hanno raccolto prove sufficienti per ottenere un nuovo processo, cominciato a marzo. L’estate scorsa è stato assolto. Il giudice che presiedeva il collegio giudicante si è scusato, riconoscendo che “per 39 anni lei ha sopportato sofferenze immense, prendo molto sul serio il fatto che ciò abbia portato a qualcosa di irreparabile. Le auguro sinceramente felicità per la vita che la attende”. Ma la reazione della polizia e della procura è stata molto più ostile: hanno deciso di non rivedere il caso e non si sono ufficialmente scusati con Maekawa. “È scoraggiante”, ha commentato Satoru Yoshimura, il suo avvocato. “Se non sono capaci di riflettere sulle loro azioni dopo tutto questo, che razza di paese siamo?”.
Anche nel caso di Hakamada il governo giapponese è stato riluttante ad ammettere le proprie colpe. Dopo l’assoluzione, il capo della polizia di Shizuoka ha fatto visita a Hakamada e alla sorella, inchinandosi profondamente in segno ufficiale di scusa, ma quel gesto è stato successivamente sminuito dalla procuratrice generale. In una dichiarazione ha riconosciuto che il processo si era “prolungato” eccessivamente e aveva provocato un enorme stress per Hakamada, ma ha anche detto che la procura era “profondamente insoddisfatta” della sentenza e respingeva l’affermazione del tribunale secondo cui le prove erano una montatura (la difesa di Hakamada ha poi querelato lo stato per diffamazione).
Oggi Hakamada ha 89 anni, soffre di un lieve diabete e mostra la fragilità fisica della sua età. Cinquantotto anni di agonia e isolamento hanno lasciato cicatrici profonde e irreparabili nella sua mente. È ancora intrappolato nel mondo immaginario che si era creato per sopravvivere alla prigionia e anche se la sua odissea è finita sembra incapace di tornare alla realtà.
Il giorno dell’assoluzione Hideko ha aperto sul tavolo i giornali con i titoli dedicati al caso del fratello. Un video ha ripreso il momento in cui gli ha comunicato la notizia, con la voce tremante per l’emozione. “Hai vinto. È andato tutto come sostenevi tu”, gli dice scrutando il suo volto e toccandogli una mano. “È tutto a posto ora. Puoi stare tranquillo. Lo capisci?”. Hakamada non risponde. Rimane seduto in silenzio, gli occhi piccoli e infossati fissi davanti a sé. Il suo volto corrucciato è pesante e impenetrabile come sempre. Ma ai miei occhi, quello che si intravede è un accenno di un sorriso. ◆ gc
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 50. Compra questo numero | Abbonati